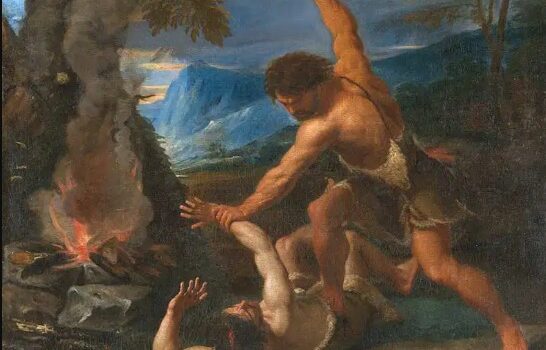La crisi del metodo Trump. Da dealer maker a spettatore in ritirata

La telefonata di due ore tra Donald Trump e Vladimir Putin, tenutasi lunedì scorso, è uno di quegli eventi che, più che per i risultati concreti, si impongono per il peso simbolico. Non ci sono stati passi avanti, e forse nemmeno passi laterali. Anzi, per certi versi, si è tornati indietro. Trump, che in campagna elettorale aveva promesso di chiudere la guerra in 24 ore, ora minaccia di ritirarsi dai negoziati entro un mese se non ci saranno risultati visibili. È un’evoluzione comunicativa drastica: dal “deal maker” al “deal quitter”. E come spesso accade con Trump, la narrazione mediatica vale quanto — o più — del contenuto effettivo.
La Russia, dal canto suo, continua a recitare un copione già visto: disponibilità al dialogo a parole, intransigenza e minacce nei fatti. Putin non arretra. E anzi, il tono dei negoziatori russi a Istanbul, dove si sono tenuti i colloqui paralleli con la delegazione ucraina, ha ricordato più un ultimatum medievale che un tentativo di soluzione diplomatica.
La dinamica evidenziata dalle conversazioni a più livelli — Washington, Mosca, Kiev, Bruxelles, Vaticano — mostra chiaramente quanto la guerra in Ucraina sia ormai anche una questione di comunicazione internazionale. E in questa comunicazione, gli Stati Uniti, la Russia e l’Ucraina stanno giocando partite differenti, con regole incompatibili.
Soprattutto Trump, che ha sempre concepito la diplomazia come un’estensione della sua strategia comunicativa, si ritrova oggi stretto tra due fuochi: da un lato, la necessità di mantenere il controllo del racconto — e della propria immagine di risolutore — e dall’altro l’evidenza che né la Russia né l’Ucraina si muovono secondo i tempi e le logiche della comunicazione elettorale americana.
Inoltre, questa telefonata cade in un momento delicato per il cosiddetto “metodo Trump“: una dottrina di relazioni internazionali improntata su bilateralismo muscolare, leverage economico (dazi) e marginalizzazione sistematica dell’Unione Europea. È una strategia che, in contesti di instabilità diffusa, può apparire efficace. Ma alla prova della guerra vera, mostra le prime crepe.
Il metodo Trump: da mediatore a spettatore
Fin dal primo giorno del secondo mandato, Trump ha impostato il conflitto ucraino come una prova muscolare per la sua leadership internazionale. Ha promesso pace rapida, mediazione autorevole, e una soluzione che avrebbe messo in riga tanto Mosca quanto Kiev. Ma con il passare dei mesi, quella narrazione si è sgonfiata sotto il peso della realtà: la Russia non intende trattare da posizione di parità e l’Ucraina non è disposta a cedere territori in cambio di promesse.
Il cambiamento comunicativo è evidente: dal tono trionfalistico al tono condizionale. «Mi tirerò indietro», ha detto Trump. Un’affermazione che non rappresenta solo una frustrazione personale, ma anche una strategia preventiva di de-responsabilizzazione: se non si arriva alla pace, non è colpa sua. È una narrazione a prova di fallimento.
La proposta originaria di un cessate il fuoco di 30 giorni, negoziata a Gedda con il supporto di Francia, Germania, Regno Unito e Polonia, è stata completamente abbandonata. Mosca ha invertito i termini: prima i negoziati, poi la tregua. In altre parole: prima l’umiliazione diplomatica, poi forse la sospensione dei bombardamenti.
Trump ha anche lasciato intendere che non imporrà nuove sanzioni, sostenendo che sarebbero controproducenti. Ha persino accennato a “opportunità commerciali” con la Russia nel dopoguerra, dichiarazione che strappa il velo residuo su ogni forma di deterrenza. Il presidente americano sta parlando come se l’Ucraina fosse già una nota a piè pagina della nuova entente economica post-conflitto.
Il Vaticano, evocato come possibile sede per i negoziati, rientra pienamente nella narrazione trumpiana: una sede “neutra”, simbolica, autorevole ma non incisiva. Un palco ideale per la diplomazia teatrale, ma poco funzionale alla risoluzione concreta di un conflitto in corso.
In questo quadro, Trump continua a comunicare più che negoziare. La sua dottrina — una sorta di “realpolitik mediatica” — si fonda sulla costruzione di una percezione pubblica favorevole. Non tanto sul raggiungimento di risultati effettivi, quanto sulla loro rappresentazione spettacolare.

Il linguaggio della guerra e il cinismo del negoziato
Il vero centro della vicenda non è tanto la diplomazia americana, quanto la postura russa. I colloqui di Istanbul, presentati come occasione per un rilancio del dialogo, si sono trasformati in una lezione di intimidazione strategica. Le dichiarazioni di Vladimir Medinskij, il capo dei negoziatori russi, sono tra le più dure degli ultimi mesi.
«Possiamo combattere un anno, due, tre. Abbiamo combattuto in Svezia per ventuno anni. Siamo pronti a combattere per sempre». La frase è stata indirizzata direttamente alla delegazione ucraina, e forse in particolare a Serhiy Kyslytsya, ex ambasciatore ONU e zio di un soldato ucciso nel 2022. Una comunicazione emotivamente calibrata per ferire, non per persuadere.
Mosca ha chiesto formalmente la cessione di quattro regioni: Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson. Alcune sono sotto controllo parziale. Ma Medinskij ha alzato la posta: se Kiev non cede ora, “la prossima volta parleremo di sei regioni”. Una minaccia chiara: Kharkiv e Sumy sono le prossime sulla lista.
La diplomazia russa è un’estensione del campo di battaglia, non una sua alternativa. In questo, Putin è coerente con la sua retorica storicizzante. Il richiamo alla Grande Guerra del Nord, conclusa nel 1721, non è un vezzo da storico dilettante: è una dichiarazione di intenti epocali.
Intanto, sul terreno, si moltiplicano gli indizi di un’imminente offensiva estiva nel Donbas. Dopo il parziale fallimento a Pokrovsk, i russi si sono spostati a nord, guadagnando terreno utile per accerchiare Kramatorsk. La stagione più favorevole alle operazioni militari è cominciata, e la Russia vuole sfruttarla per consolidare le proprie posizioni prima di qualsiasi tregua negoziata.
In questo scenario, l’unico risultato tangibile dei negoziati è stato uno scambio di prigionieri: mille per parte. Un gesto importante dal punto di vista umanitario, ma irrilevante a livello strategico. La guerra continua. E lo fa con una retorica che alimenta, anziché spegnere, il conflitto.
Il caso Ucraina mette in luce le prime crepe della Dottrina Trump. Dopo aver costruito un impianto negoziale fondato sull’unilateralismo spettacolare, Trump si ritrova ora intrappolato nelle sue stesse promesse. La minaccia di “tirarsi indietro” è in fondo una resa comunicativa: non può ottenere ciò che ha venduto agli elettori.
Trump ha voluto centralizzare su di sé ogni trattativa, escludendo l’Unione Europea, marginalizzando Kiev e trattando Putin come un interlocutore paritario. Ma questa strategia ha limiti strutturali: quando il negoziato non si traduce in un risultato mediatico utile alla sua narrazione, perde attrattiva.
L’intera postura americana nella crisi ucraina sta diventando una performance senza copione. La diplomazia performativa di Trump, che funziona in campagna elettorale o in contesti negoziali bilaterali (come con Messico o Canada), si infrange contro l’asimmetria della guerra.
L’Europa, nel frattempo, è rimasta spettatrice impotente. L’esclusione dai tavoli, i dazi annunciati e la mancanza di una strategia comune hanno evidenziato la subalternità sistemica del continente. Trump non cerca alleati. Cerca comparse nel proprio teatro geopolitico.
Eppure, proprio in questo momento di difficoltà, la Casa Bianca non sembra pronta a rivedere l’impostazione. L’idea di affidare la mediazione al Vaticano, di non imporre nuove sanzioni, di non coinvolgere direttamente le istituzioni europee, sono tutti segnali di una percezione distorta dell’efficacia comunicativa.
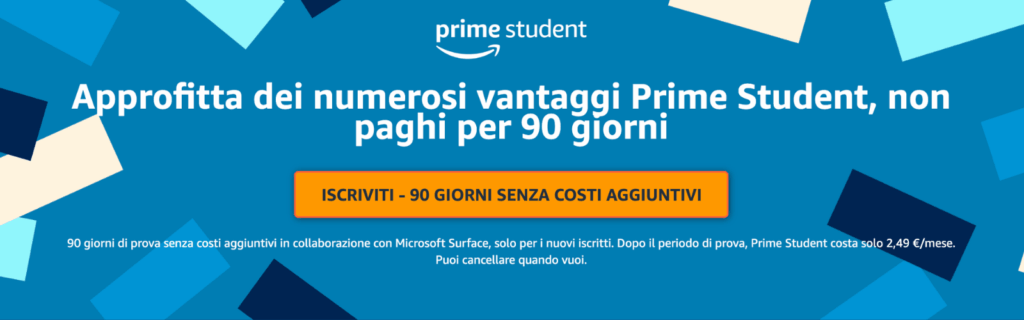
La diplomazia performativa non è vera diplomazia
La vicenda ucraina, letta attraverso il prisma trumpiano, mette in luce una frattura profonda tra due modelli di gestione della diplomazia: da un lato la diplomazia strutturata, multilaterale, spesso lenta ma fondata su codici condivisi e prassi istituzionali; dall’altro, la diplomazia performativa o “spettacolo”, centrata sul gesto simbolico, la dichiarazione spettacolare, il frame narrativo da consegnare ai media. Trump incarna quest’ultima in modo radicale. Ma la sua efficacia inizia a mostrare crepe profonde.
Fin dall’inizio del suo secondo mandato, Trump ha scelto di trattare la politica estera come un’estensione del suo personaggio pubblico: il negoziatore carismatico, il risolutore dei conflitti globali, il “uomo forte” che, con una telefonata, può rovesciare gli equilibri geopolitici. È una visione coerente con il suo stile, ma poco adatta a scenari di logoramento bellico, dove la dimensione simbolica viene rapidamente erosa dal protrarsi del conflitto reale.
Nel cuore della diplomazia performativa trumpiana c’è una concezione quasi coreografica della politica estera: ogni gesto, ogni telefonata, ogni annuncio pubblico viene pensato per massimizzare l’effetto sulla percezione, non necessariamente sull’esito concreto. Trump non ha mai fatto mistero di questo approccio. Lo aveva già teorizzato nel suo libro-manifesto del 1987, The Art of the Deal, dove dichiarava che “la percezione è spesso più importante della realtà” e che “esagerare” è uno strumento legittimo per spostare i termini di un negoziato.
Ma tra il manuale di business e la gestione delle crisi internazionali c’è una distanza profonda. Per quanto la narrazione del leader abile a negoziare possa funzionare nella gestione di un contratto immobiliare o di un’OPA ostile, quando si applica a una guerra su larga scala – con decine di migliaia di vittime, invasione territoriale e uno stallo nucleare latente – si scontra con i limiti della sua stessa retorica. Il problema di Trump non è solo che promette soluzioni impossibili, ma che costruisce intere strategie diplomatiche come se fossero sequenze televisive.
L’idea che basti “chiudersi in una stanza con Putin e Zelensky” per trovare l’accordo – come più volte dichiarato – è coerente con l’immaginario di The Apprentice più che con quello di un vertice multilaterale. In questo senso, la crisi attuale è anche una crisi del “deal-making come diplomazia”, perché il contesto internazionale non risponde alle logiche del branding personale. E perché, davanti a un leader come Putin, la teatralità trumpiana non produce intimidazione, ma indifferenza.
Il caso dell’Ucraina lo dimostra. La promessa di una pace in ventiquattr’ore — ripetuta almeno 53 volte in campagna elettorale — era funzionale a costruire un mito politico. Ma nel momento in cui Trump si confronta con la realtà dei fatti, quella promessa si trasforma in un boomerang comunicativo. Il tono muta: da assertivo a condizionale, da certo a ipotetico. «Mi tirerò indietro», ha detto, esprimendo un’inaspettata fragilità negoziale. È un salto retorico rilevante, perché segnala che il presidente non è più in controllo della trama, ma ne è ostaggio narrativo.
La diplomazia performativa, per funzionare, ha bisogno di performance vincenti. Ma quando l’avversario — in questo caso Putin — non partecipa al copione e anzi lo disintegra con ogni dichiarazione minacciosa o ogni chilometro guadagnato sul campo, l’intero impianto rischia il collasso. E con esso, la credibilità internazionale degli Stati Uniti come regista della trattativa.
La telefonata di due ore tra Trump e Putin è stata l’esempio perfetto di questa crisi. Due ore di nulla strategico, ma dense di simboli: la promessa del Vaticano come sede neutrale, il ritiro della proposta di cessate il fuoco, la concessione russa a trattare “senza pressioni”. Ma dietro queste mosse non c’è sostanza: solo l’illusione che la messa in scena della pace possa sostituire la pace stessa. La diplomazia reale, nel frattempo, langue: la Francia, la Germania, il Regno Unito e la Polonia, che avevano appoggiato l’iniziativa di Gedda, sono stati declassati a comparse.
E poi c’è l’assenza strutturale dell’Unione Europea, un tema che la dottrina Trump tratta con ostinata indifferenza. Escludere l’Europa dai tavoli negoziali non è solo una scelta geopolitica, ma una scelta comunicativa: significa riconoscere solo interlocutori “forti”, capaci di offrire contropartite rapide e visibili. Ma questa impostazione rischia di lasciare Trump solo nel momento in cui i suoi alleati naturali — cioè gli europei — sarebbero i primi a sostenere una pace credibile, fondata su un equilibrio duraturo. La sua ostentata autosufficienza è, in questo senso, una forma sofisticata di auto-isolamento negoziale.
Il ruolo dell’economia come leva di estorsione
Un altro elemento di debolezza è l’uso selettivo della leva economica. Trump ha detto chiaramente che non intende applicare nuove sanzioni alla Russia, temendo un’escalation incontrollabile. Ma il segnale che ne deriva, sul piano comunicativo, è devastante: la leadership americana appare riluttante, esitante, ambigua. L’idea di “buone opportunità commerciali” nel dopoguerra con Mosca, pronunciata in diretta TV, ha scardinato ogni residuo di deterrenza. Dove una volta c’erano linee rosse, oggi ci sono ipotesi di investimento. E questo, per Mosca, è un invito a continuare.
In definitiva, la diplomazia performativa di Trump si trova di fronte al suo paradosso fondamentale: funziona finché può esibire vittorie, ma si svuota di senso nel momento in cui si incaglia in contesti refrattari allo spettacolo. Le guerre di logoramento, le trattative congelate, gli avversari che non giocano secondo le regole della messinscena — tutto questo rivela i limiti di un approccio centrato più sul frame che sulla struttura.
Nel suo primo mandato, Trump aveva capito che i gesti eclatanti (come l’incontro con Kim Jong-un o lo spostamento dell’ambasciata a Gerusalemme) bastavano a generare una narrativa vincente. Ma il secondo mandato richiede di fare i conti con crisi permanenti. E una crisi permanente, come quella ucraina, non può essere contenuta nei limiti di una strategia comunicativa basata sull’effetto sorpresa. Qui serve una vera diplomazia, fatta di compromessi lenti, reti multilaterali, leadership diffusa.

Ma questo, per Trump, è il linguaggio degli altri. Lui parla in slogan, mentre la storia parla in continuità.
La verità è che la Dottrina Trump è sempre stata più fragile di quanto sembrasse. Funziona quando può controllare i tempi e i contenuti. Crolla quando deve confrontarsi con la complessità non negoziabile di una guerra totale.
Il contrasto tra la diplomazia trumpiana e la strategia russa si misura sulla distanza tra immagine e sostanza. Trump costruisce frame comunicativi centrati sulla sua figura: è lui il garante della trattativa, il promotore della pace, il gestore della scena. Ma ogni volta che la realtà bussa alla porta — con missili, truppe, e ultimatum — la narrazione si incrina.
Putin, al contrario, usa la diplomazia come teatro della guerra, non come strumento per chiuderla. Ogni negoziato è un banco di prova per la resistenza al compromesso. La logica è quella dello sfinimento, non della mediazione.
E l’Ucraina, stretta tra questi due codici incompatibili, rischia di essere ridotta a pedina in una partita giocata altrove. La promessa americana di una pace rapida si è infranta contro l’intransigenza russa e la realtà geopolitica. Ora resta uno spazio vuoto — quello che Trump minaccia di abbandonare — e che nessuno sembra ancora pronto a colmare.
Nel frattempo, l’Europa osserva. Non senza nervosismo. E forse, per la prima volta da anni, senza più la certezza di avere voce in capitolo.