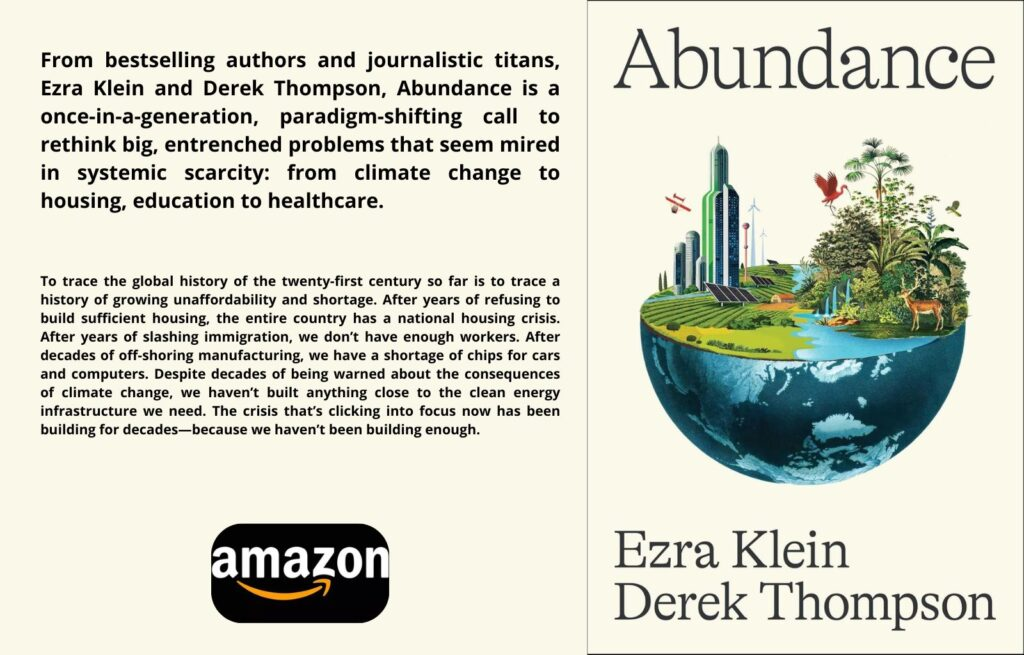Rinunciare alla web tax non è un favore all’America, ma alle ambizioni europee di innovazione

Nel verde della Scozia, all’ombra del Turnberry Golf Club di proprietà Trump, si gioca una partita decisiva per il futuro delle relazioni economiche tra Europa e Stati Uniti. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, è volata lì con l’obiettivo di siglare un accordo commerciale che eviti una nuova escalation protezionista. Il punto di caduta? Un compromesso sul livello dei dazi (una tariffa generale del 15%) e, soprattutto, un sacrificio simbolico ma denso di significato: la sospensione della web tax europea.
Era prevedibile. Anzi, probabilmente inevitabile.
La web tax, da anni cavallo di battaglia di una certa Europa ideologizzata, ha sempre avuto un doppio volto: da una parte, la pretesa di riequilibrare la tassazione delle multinazionali digitali; dall’altra, una pulsione squisitamente politica, a tratti protezionistica e spesso esplicitamente antiamericana. Una forma di resistenza al dominio delle Big Tech d’Oltreoceano, che è servita – più che a correggere vere distorsioni fiscali – a mandare un messaggio: noi europei non vogliamo essere colonizzati digitalmente.
Ma oggi, nel 2025, questo messaggio appare logoro. Non solo perché nessuno Stato membro è davvero riuscito a implementare una digital tax efficace, ma anche perché l’Unione Europea, sotto attacco economico e geopolitico da più fronti, ha bisogno di rafforzare le sue alleanze – non di alimentare scontri simbolici.
A Turnberry si tratta dunque un compromesso più pragmatico che ambizioso: i dazi generali sulle merci europee in ingresso negli USA verranno fissati al 15%, secondo un modello simile a quello già applicato con il Giappone. È una riduzione sensibile rispetto ai 30% minacciati nei mesi scorsi da Trump, che aveva incluso nel mirino settori chiave come l’auto, l’agroalimentare e i farmaceutici. Restano fuori dal compromesso alcuni ambiti più sensibili, come acciaio e alluminio, che continueranno a scontare tariffe elevate (fino al 50%).
In cambio, Bruxelles ha deciso di sospendere la proposta di tassazione dei colossi digitali americani. Non si tratta di una rinuncia tecnica, ma politica. La Commissione von der Leyen si è assunta la responsabilità di smontare un’arma che, nei fatti, ha avuto più valore simbolico che fiscale.
Ed è qui che la riflessione europea deve farsi più profonda. Siamo davvero convinti che una tassa applicata esclusivamente a un pugno di aziende americane – Google, Meta, Amazon, Apple, Microsoft – rappresentasse una riforma equa e neutrale? O era piuttosto un’espressione di ostilità politica, mascherata da giustizia tributaria?
Che la web tax fosse discriminatoria, lo hanno sempre sostenuto con forza gli Stati Uniti. Ma è tempo che anche l’Europa ne prenda atto, almeno in parte. Perché la verità è che la proposta è nata e cresciuta anche sulla spinta di un riflesso culturale antiamericano, nutrito di diffidenze e frustrazioni, più che di una reale volontà di riformare il diritto fiscale internazionale. E che proprio questa carica ideologica abbia reso la web tax inefficace, impopolare e alla fine indifendibile sul piano negoziale.
Nell’accordo scozzese, dunque, l’Europa non perde una battaglia commerciale, ma mette in discussione una retorica. La retorica di un’Europa baluardo contro l’imperialismo digitale, senza però dotarsi di un proprio ecosistema competitivo. La web tax è stata una scorciatoia simbolica di fronte a un fallimento strategico: l’assenza di un vero mercato unico digitale, di un’infrastruttura tecnologica sovrana, di campioni industriali capaci di competere con le Big Tech americane.
Tuttavia, il compromesso faticosamente raggiunto non convince tutti. Olivier Blanchard, uno dei più autorevoli economisti europei, ha espresso in queste ore un giudizio netto: “Why on earth should the European Union be willing to accept, as it seems ready to do, the 15% tariff? Are we really so weak that this is the best we can hope for?”. Il suo punto è chiaro: accettare una tariffa generalizzata al 15% significa sancire un rapporto sbilanciato, in cui l’Europa si presenta al tavolo delle trattative senza sufficiente forza negoziale. In altre parole, una resa di fronte all’unilateralismo americano.
I dubbi di Blanchard
La domanda sollevata da Blanchard è cruciale: l’Unione Europea sta scegliendo davvero l’accordo migliore possibile, o sta semplicemente evitando il peggio? E, ancora più importante, può permettersi di accettare un compromesso così oneroso senza alzare, subito dopo, il livello della sua ambizione strategica?
La buona notizia è che l’Europa, almeno oggi, ha scelto la realtà. Ha scelto di sedersi al tavolo con Washington, di abbassare i toni e di puntare sul dialogo commerciale. Lo fa in un momento delicato, in cui le tensioni globali – dall’Ucraina al Medio Oriente – richiedono una solida convergenza tra le democrazie occidentali.
Ma la realtà, da sola, non basta. Che si firmi o meno un accordo a Turnberry, l’Unione Europea ha davanti a sé un compito ben più difficile e non più rinviabile: competere. Competere sul fronte dell’innovazione e della tecnologia, liberando il potenziale di crescita delle sue start-up, attraendo nuove idee di impresa e favorendo l’afflusso di capitali verso il continente. Se davvero si arriverà a un’intesa con gli Stati Uniti, il passo successivo dovrà essere quello di alzare l’asticella della competitività.
La vera sfida dell’Europa non sono i dazi, ma la capacità di competere
Perché nel nuovo ordine mondiale, chi rinuncia alla difesa simbolica deve almeno vincere la battaglia concreta. Non più l’illusione di difendersi con le tasse, ma la determinazione a vincere con le idee.
Rinunciare alla web tax non sarà un favore all’America, ma alle ambizioni europee. Alle nostre vere ambizioni: costruire un ecosistema tecnologico autonomo, liberare le energie imprenditoriali, attrarre capitali e talenti, dare forma a un’Europa che non si limita a reagire ma che innova, guida e compete. Smontare un totem ideologico può essere l’inizio di una politica industriale più coraggiosa e moderna. Perché non ci serve più un’Europa che punisce chi innova altrove: ci serve un’Europa che sappia innovare qui.