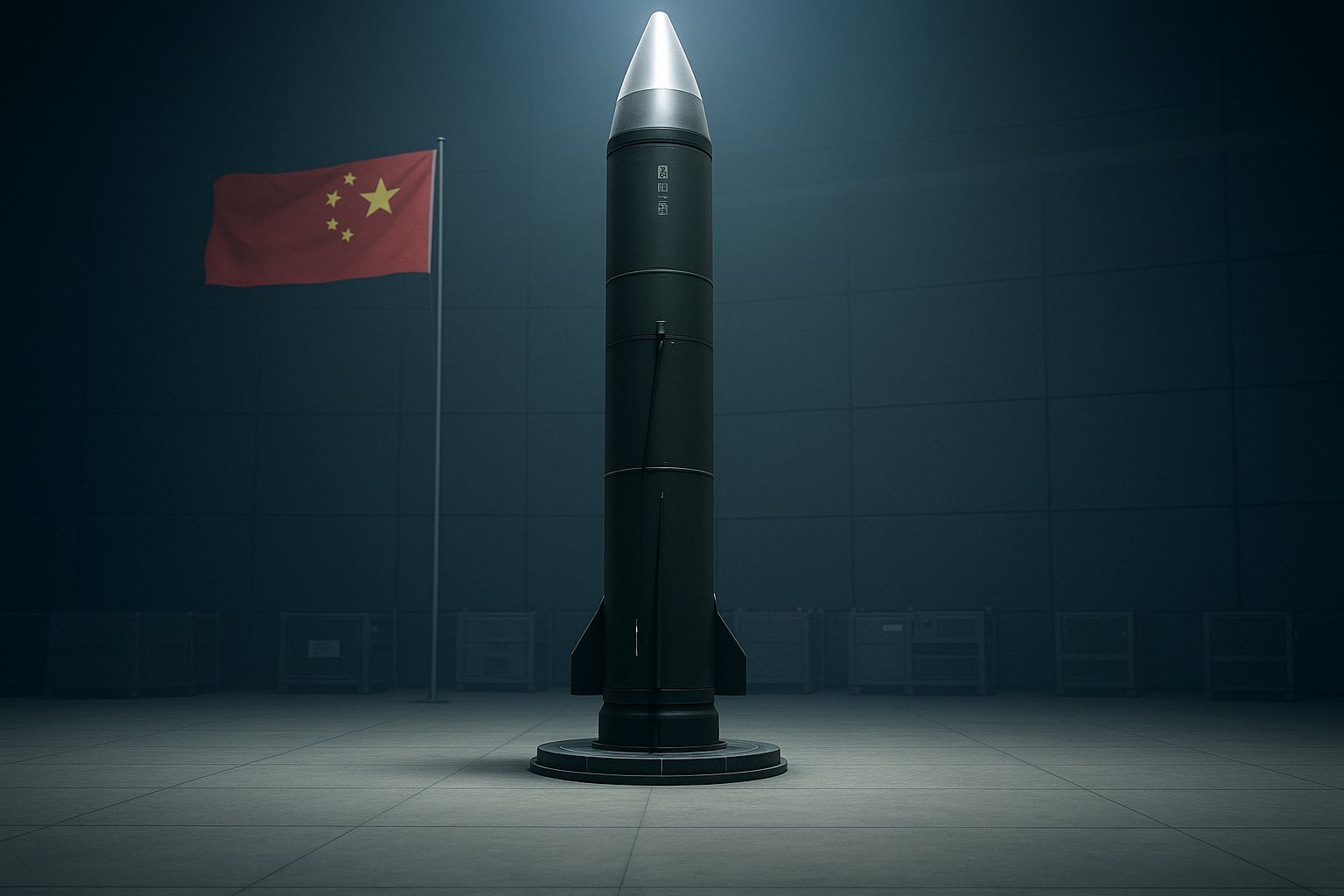La resa lenta: come Putin sta piegando l’occidente senza trattare

Il conflitto in Ucraina è ormai diventato lo specchio di una transizione geopolitica che ridefinisce non solo gli equilibri militari sul terreno, ma anche le relazioni di forza transatlantiche e la capacità dell’Europa di concepirsi come attore strategico autonomo. A più di tre anni dall’invasione su larga scala, è sempre più evidente che la Federazione Russa – sotto la guida di Vladimir Putin – ha un solo esito in mente: una vittoria strategica, anche a costo di pagare un prezzo umano e militare altissimo.
Questa prospettiva si consolida in un contesto in cui gli Stati Uniti manifestano segni di disimpegno selettivo, costretti da limiti industriali, da scelte politiche interne e da un’agenda globale che non può più concentrare risorse illimitate sul solo fronte europeo. Lo stesso Donald Trump, pur mantenendo una retorica di sostegno condizionato a Kyiv, ha segnalato la priorità di preservare le scorte strategiche americane e di ribilanciare la postura globale di Washington, lasciando l’Europa a misurarsi con la realtà di un sostegno sempre meno garantito.
Al tempo stesso, l’Unione Europea e la NATO vivono una fase di ambiguità strategica: dichiarazioni di fermezza e solidarietà continuano a susseguirsi, ma il sostegno reale – militare, economico e politico – si fa più fragile e più condizionato da logiche interne. L’assenza di un’autentica autonomia strategica si rivela drammatica proprio quando la pressione russa cresce ai confini e la leadership di Kyiv chiede un impegno non simbolico ma materiale, strutturale, sostenibile sul lungo periodo.
In questo quadro, il rischio non è solo quello di una sconfitta militare ucraina sul campo, ma di un fallimento strategico collettivo dell’Occidente, che potrebbe vedere riaffermato il modello putiniano di potenza: uso calibrato della forza, capacità di sostenere guerre di logoramento, controllo dell’opinione pubblica interna e sfruttamento delle divisioni altrui. Una vittoria di Putin, anche parziale e territorialmente limitata, segnerebbe un precedente devastante per la sicurezza europea e per la credibilità della deterrenza occidentale.
Questo articolo si propone di analizzare in profondità le ragioni e le conseguenze di questo scenario. Esamineremo da un lato la strategia di Putin, determinata a non trattare su nulla che non sancisca le sue condizioni, e dall’altro il graduale distacco americano e la crisi di coesione europea che, di fatto, stanno consegnando all’autocrate russo la leva per ridefinire l’ordine di sicurezza del continente.

La logica della diplomazia putiniana: trattare senza concedere
Per comprendere davvero la strategia di Vladimir Putin nella guerra in Ucraina, bisogna accettare una premessa: il negoziato non è per Mosca un’alternativa alla guerra, ma un suo strumento funzionale. La diplomazia russa non mira a un compromesso paritario, ma a imporre le proprie condizioni mascherandole da proposte di pace. È una pratica che intreccia coercizione militare, propaganda strategica e negoziazione manipolata.
Le recenti telefonate tra Putin e leader come Donald Trump ed Emmanuel Macron ne sono un esempio lampante. Ogni dialogo diplomatico viene usato per ribadire una posizione rigida: nessuna rinuncia agli obiettivi dichiarati dell’“operazione speciale”, nessuna concessione territoriale, nessun riconoscimento dell’Ucraina come alleato occidentale indipendente. Mosca insiste sul concetto di “cause profonde” del conflitto, che tradotto significa: l’Ucraina deve accettare uno status neutrale, disarmato e subordinato alla sfera di influenza russa.
In questa strategia, il negoziato serve a molteplici scopi:
- Legittimare la propria posizione agli occhi della comunità internazionale, presentandosi come parte ragionevole e pronta al dialogo;
- Dividere il fronte occidentale, esacerbando le differenze tra chi vuole continuare a sostenere Kyiv senza condizioni e chi teme l’escalation;
- Guadagnare tempo militare, consolidando le linee sul terreno e preparando offensive locali.
Questa diplomazia coercitiva è un tratto consolidato della politica estera russa post-sovietica. La Russia ha raffinato nel tempo un modello di guerra ibrida che alterna la forza convenzionale, la guerra dell’informazione e il negoziato strumentale. Nei casi di Transnistria, Abkhazia, Ossezia del Sud e soprattutto Crimea e Donbas, Mosca ha dimostrato di saper congelare i conflitti per anni, trasformando occupazioni militari in fatti compiuti sul piano politico.
La narrativa russa gioca un ruolo decisivo in questa strategia. Ogni apertura diplomatica è accompagnata da un discorso costruito con grande cura semantica: pace giusta, cause profonde, denazificazione, protezione delle popolazioni russofone. Termini vaghi, volutamente interpretabili, che offrono alla diplomazia russa margini di manovra e alla propaganda interna argomenti per giustificare la guerra come necessaria e difensiva.
L’uso della diplomazia come strumento di guerra si manifesta anche nella scelta degli interlocutori. Con Macron, Putin si presenta come statista disponibile al dialogo, accreditando la Francia come partner privilegiato e sfruttando la storica ambizione francese di guidare la diplomazia europea. Questo indebolisce la percezione di un fronte occidentale monolitico e rafforza la narrativa russa di un’Europa divisa e poco incline al sacrificio strategico.
Con Trump, la logica è ancora più sottile. L’amministrazione americana ha già segnalato un rallentamento significativo nel sostegno militare a Kyiv, ufficialmente per la necessità di ricostituire le scorte strategiche statunitensi. Trump stesso ha dichiarato di voler “aiutare” l’Ucraina ma solo nei limiti delle possibilità americane. Mosca legge queste parole come un segnale di stanchezza strategica e una porta aperta per ottenere almeno una neutralizzazione del sostegno americano.
La pressione militare continua sul campo è il secondo pilastro di questa diplomazia. Mentre si tengono telefonate cordiali e si evocano spiragli di dialogo, l’esercito russo continua a concentrare truppe lungo i settori più vulnerabili del fronte, come l’oblast’ di Sumy, minacciando offensive locali capaci di logorare le forze ucraine e di alterare i calcoli occidentali. Questa strategia “parallela” al negoziato è ciò che la dottrina militare russa definisce come escalation controllata: la minaccia di un’escalation serve non solo a scoraggiare aiuti occidentali più massicci, ma anche a condizionare i termini stessi di un eventuale accordo.
Non va trascurato il fattore interno. Putin gode di un consenso consolidato nella società russa, alimentato da una campagna di mobilitazione patriottica che ha normalizzato la guerra come “difesa esistenziale” contro l’Occidente. La capacità del Cremlino di reclutare centinaia di migliaia di soldati senza dichiarare una mobilitazione generale dimostra il successo di questa narrativa. Sul piano domestico, ogni vittoria – anche parziale – sul fronte esterno rafforza il potere personale di Putin e la legittimità del suo regime.
Infine, la diplomazia russa mira a un obiettivo più ampio: ridefinire l’ordine di sicurezza europeo. Mosca non tratta per tornare allo status quo ante 2022. Al contrario, cerca di consolidare un nuovo equilibrio che riconosca la sfera di influenza russa su ampie porzioni dello spazio post-sovietico, imponendo limiti concreti all’espansione della NATO e riducendo la capacità dell’Unione Europea di proiettare stabilità verso est.
Questa strategia si nutre delle debolezze occidentali: il calcolo politico a breve termine, la difficoltà di sostenere lo sforzo militare ed economico sul lungo periodo, la frattura tra l’opinione pubblica e le élite strategiche, la concorrenza di altre priorità globali come l’Indo-Pacifico.
In sintesi, la diplomazia putiniana è un’arma di pressione strategica. Non è concepita per arrivare a una pace condivisa, ma per forzare l’avversario a cedere progressivamente. E finché l’Occidente non comprenderà la natura di questa logica, continuerà a illudersi che il negoziato sia un sentiero verso la stabilità, quando in realtà è solo un altro campo di battaglia.
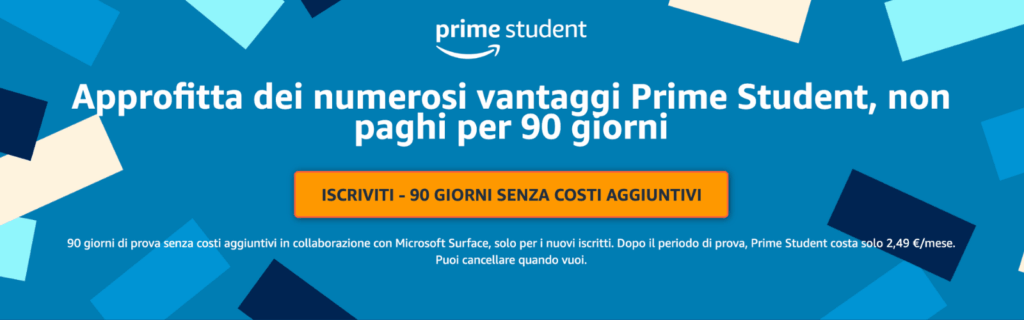
Il disimpegno americano e l’impasse europea: tra cinismo strategico e crisi morale
Nel panorama delle relazioni internazionali, la diplomazia non è solo un negoziato tecnico, ma una forma codificata di comunicazione strategica. In questo senso l’era Trump – pur con le sue varianti più recenti – ha consolidato una prassi di diplomazia performativa, che si muove tra la teatralità mediatica e la ricerca del consenso interno.
Il metodo trumpiano si regge su un doppio binario: pressione massima e spettacolarizzazione del dialogo. Che si tratti di telefonate pubblicizzate in conferenze stampa, di summit bilaterali messi in scena come reality geopolitici o di dichiarazioni roboanti sul «fare il deal», la cifra costante è la trasformazione del negoziato in evento comunicativo.
Ma questo stile incontra limiti strutturali quando si confronta con attori che non intendono partecipare allo stesso gioco semantico. È qui che il caso di Vladimir Putin risulta emblematico. Il presidente russo ha affinato negli anni una propria strategia negoziale fatta di ambiguità controllata, escalation calibrata sul terreno, e soprattutto di una disponibilità a sostenere costi umani e materiali che i suoi interlocutori democratici – e quindi sottoposti al giudizio elettorale – faticano a giustificare.
Il bluff trumpiano funziona solo se l’altro attore accetta di sedersi al tavolo con l’idea che esista un accordo possibile e negoziabile. Se, invece, come nel caso russo, l’interlocutore ha in mente un solo esito accettabile – la soddisfazione completa delle proprie condizioni – allora la diplomazia performativa si svuota. Diventa una recita per il pubblico interno americano, ma perde ogni capacità di incidere sugli equilibri strategici reali.
La telefonata Trump–Putin, commentata da Washington in termini di “nessun progresso” e dal Cremlino come riaffermazione degli obiettivi russi, è la dimostrazione plastica di questo fallimento. Non solo non c’è trattativa sostanziale, ma il contesto di comunicazione si frammenta in due narrazioni parallele: quella americana, concentrata sul proprio elettorato, e quella russa, focalizzata sul consolidamento del consenso interno e sul messaggio di forza verso l’Ucraina e l’Europa.
Accanto a questa crisi di metodo c’è una seconda faglia più profonda: la fragilità morale e strategica dell’Europa. Negli ultimi anni, la NATO – e l’Unione Europea al seguito – hanno progressivamente accettato di trasformarsi in strumenti retorici della politica interna statunitense. Si chiede agli alleati di alzare la spesa militare al 5% del PIL non tanto per un progetto strategico coerente, quanto per consentire al presidente americano di vantarsi di aver “messo in riga” gli europei.
In questo contesto, la crisi ucraina si rivela un banco di prova micidiale. Da un lato l’Europa parla di autonomia strategica, dall’altro delega la propria sicurezza a una potenza che alterna richieste di impegno finanziario a dichiarazioni di disimpegno. La recente sospensione americana delle forniture militari a Kyiv, giustificata con la scarsità di sistemi difensivi disponibili e la necessità di riservarli alla sicurezza nazionale americana, è un segnale inequivocabile.
Non si tratta solo di logistica. È un messaggio politico: se l’Europa crede davvero che la stabilità del suo confine orientale sia vitale, deve cominciare a sostenerla con mezzi propri. Ma l’Europa è in grado di farlo? Ad oggi, la risposta è drammaticamente negativa. La mancanza di coesione politica, la divaricazione degli interessi nazionali, la difficoltà di costruire un consenso pubblico su un aumento massiccio delle spese militari rendono l’Unione un attore sostanzialmente incapace di reggere un impegno prolungato e autonomo.
Il rischio è che, di fronte alla stanchezza americana, l’Europa si pieghi progressivamente alle condizioni russe, non dichiarandolo apertamente, ma lasciando semplicemente che Kyiv venga strangolata da una lenta riduzione del supporto. È la strategia del soffocamento logistico: non si firma alcun trattato di resa, ma si smette di inviare armi e fondi in misura adeguata.
Concedere una vittoria strategica – anche se parziale – a Putin avrebbe conseguenze dirompenti. Dimostrerebbe che la forza armata è uno strumento legittimo per risolvere controversie territoriali in Europa. Manderebbe un segnale devastante ad altri attori revisionisti nel vicinato europeo e globale. Rafforzerebbe la narrazione secondo cui le democrazie liberali non hanno più la volontà politica né la coesione morale per difendere i propri principi.
La diplomazia performativa americana, con i suoi limiti strutturali, e la crisi morale europea si intrecciano in questo scenario. Mentre Putin gioca una partita di lungo termine, sostenuto da un consenso interno blindato e da un apparato repressivo capace di assorbire costi elevati, l’Occidente rischia di dimostrare al mondo che le regole del diritto internazionale valgono solo finché non costano troppo.
E questo, più di qualsiasi mappa o trattato, è ciò che definisce davvero la postura strategica di un sistema di potere. In questo senso la guerra in Ucraina non è solo una questione di confini: è la battaglia per stabilire se la forza bruta possa ancora essere considerata un metodo accettabile di risoluzione delle crisi internazionali. Una battaglia che, se persa sul campo del sostegno e della coerenza politica, non avrà bisogno di alcuna dichiarazione ufficiale per essere ratificata.
Tra diplomazia svuotata e ridefinizione del potere
La crisi ucraina non è più solo un conflitto regionale: è un banco di prova per la tenuta strategica dell’Occidente e per la credibilità del sistema internazionale costruito dopo il 1945. Ciò che oggi accade sul fronte di Sumy o nella retorica di Putin non riguarda soltanto Kyiv: definisce i contorni di un nuovo equilibrio globale, in cui il ricorso alla forza militare e la capacità di sostenere i costi politici della guerra tornano a essere criteri di potenza.
Gli Stati Uniti, impegnati in un riassetto di priorità strategiche, mostrano la fragilità di un approccio fondato su diplomazia performativa e comunicazione spettacolare. La telefonata tra Trump e Putin – priva di progressi reali – è il simbolo di un metodo che funziona solo quando tutte le parti accettano di giocare sullo stesso terreno narrativo. Quando di fronte hai un attore deciso a imporre i propri termini non negoziabili, la diplomazia del “deal” si svuota di significato.
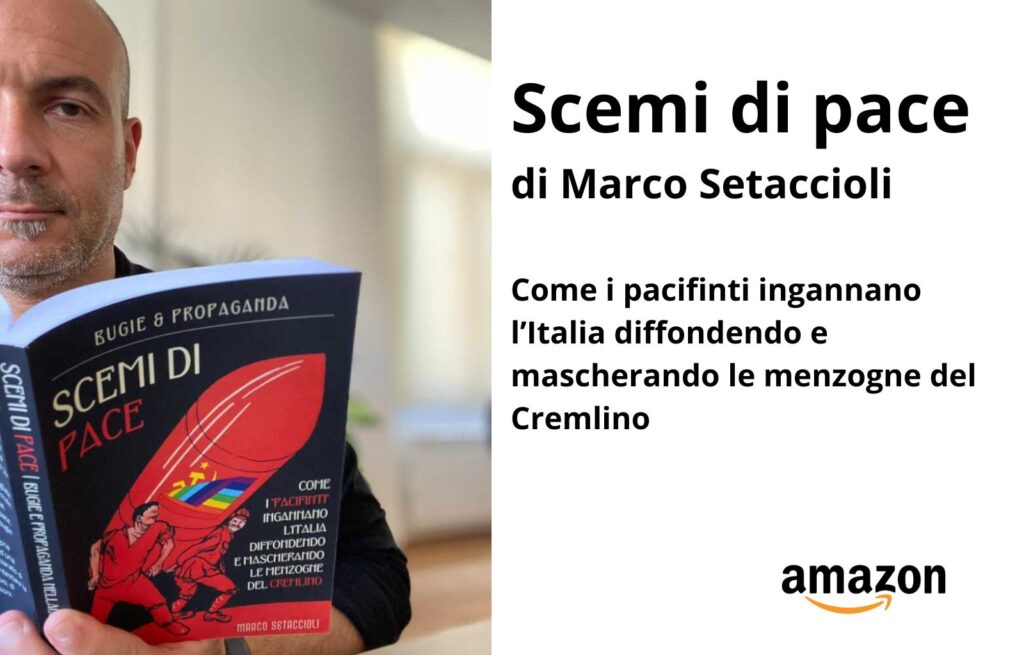
L’Europa, dal canto suo, mostra la difficoltà di trasformare la propria ambizione di autonomia strategica in una politica coerente. Sospesa tra dipendenza americana e dissonanze interne, rischia di essere testimone passiva di un graduale soffocamento dell’Ucraina. Un cedimento non dichiarato ma sostanziale, che legittimerebbe l’uso della coercizione militare come strumento di politica estera in Europa.
In questo quadro, Putin non cerca compromessi: punta a dimostrare che solo la forza – esercitata e sostenuta senza remore – garantisce risultati. Se l’Occidente accetterà questa logica, dichiarandolo o semplicemente lasciandola accadere, invierà un segnale ben oltre l’Ucraina. Un messaggio che sarà recepito da Mosca, Pechino e da ogni attore revisionista: i confini, le regole, le sovranità sono negoziabili solo in funzione dei rapporti di forza.
Il vero rischio non è la sconfitta militare di Kyiv. È la resa morale e strategica dell’Occidente. Una rinuncia silenziosa, ma devastante, alla pretesa di stabilire regole condivise per la gestione dei conflitti. Perché in diplomazia, come in guerra, la più grande vittoria è imporre i propri termini di legittimità. Ed è questa la posta in gioco oggi, nel cuore dell’Europa.