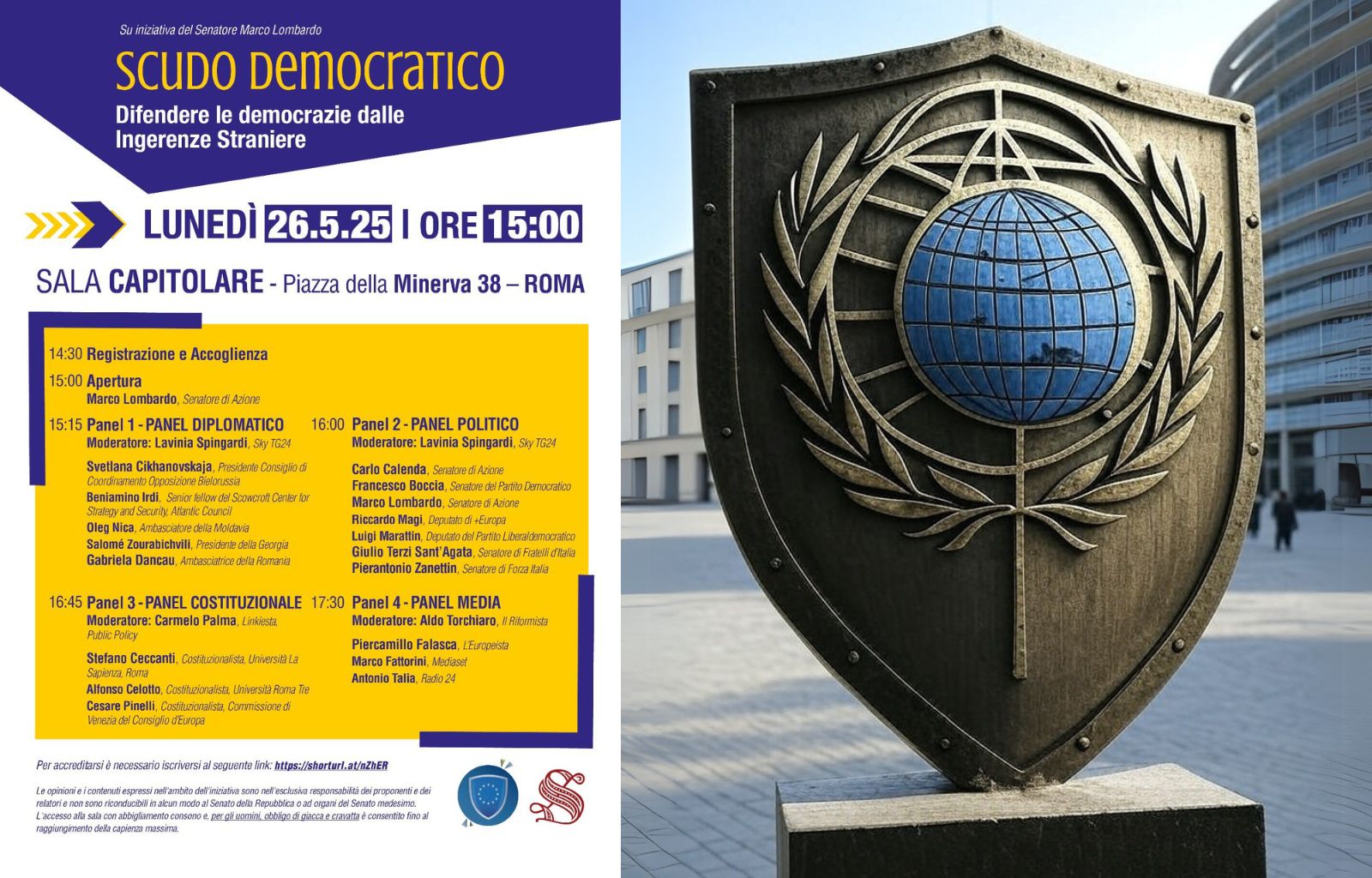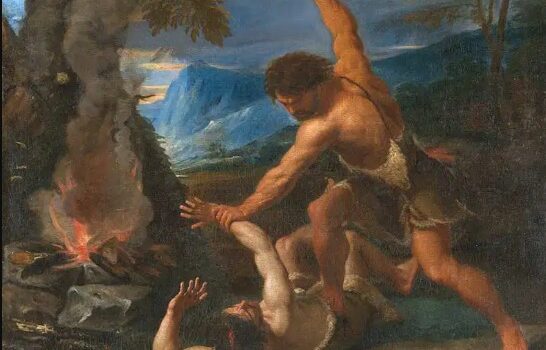Qualcuno parli del Portogallo. La fine del bipolarismo e la crisi della democrazia rappresentativa

Nei giorni in cui l’informazione europea, noi de L’Europeista in primis, ha dato risalto alle consultazioni elettorali in Polonia e Romania, si è votato anche in Portogallo, e l’esito non è stato per nulla scontato.
Le elezioni portoghesi del 2025 hanno segnato una rottura profonda e simbolicamente potente con l’architettura politica che aveva governato il Paese dal 1974, anno della Rivoluzione dei Garofani. La vittoria relativa della coalizione di centrodestra guidata da Luís Montenegro – l’Alleanza Democratica (AD) – è passata quasi in secondo piano rispetto all’exploit senza precedenti di Chega, il partito di estrema destra guidato da André Ventura. Con il 22,6% dei consensi e 58 seggi in Parlamento, Chega ha ottenuto lo stesso numero di rappresentanti del Partito Socialista, storico pilastro del centrosinistra lusitano, uscito sconfitto in maniera clamorosa e costretto a cambiare leadership.
L’affluenza significativa, il voto distribuito su tre poli e l’assenza di una maggioranza netta delineano un panorama parlamentare frantumato e instabile, che rischia di paralizzare la capacità di governo. Ma il vero terremoto non è numerico: è politico, culturale e comunicativo. Il Portogallo, ultimo bastione della resilienza socialdemocratica dell’Europa occidentale, ha visto emergere una destra radicale, populista, sovranista e capace di intercettare con successo le frustrazioni profonde di ampi settori della popolazione. Un segnale che conferma la saldatura tra crisi della rappresentanza, polarizzazione del dibattito pubblico e ritorno a forme semplificate di leadership carismatica.
Dall’alternanza alla tripartizione: la crisi del sistema e il successo dell’anti-sistema
Per cinquant’anni, il Portogallo ha conosciuto un sistema politico relativamente stabile, fondato sull’alternanza tra il Partito Socialista (PS) e il Partito Social Democratico (PSD), ora fulcro della coalizione AD. Questa architettura ha garantito un equilibrio istituzionale in un contesto segnato da importanti riforme economiche, un solido ancoraggio europeista e un certo grado di coesione sociale. L’erosione di questa dinamica ha radici profonde: la percezione di una convergenza tra i due partiti maggiori su molte scelte fondamentali, la crescente distanza dalle istanze popolari, la fatica delle classi medie nell’adattarsi ai nuovi paradigmi economici e tecnologici.
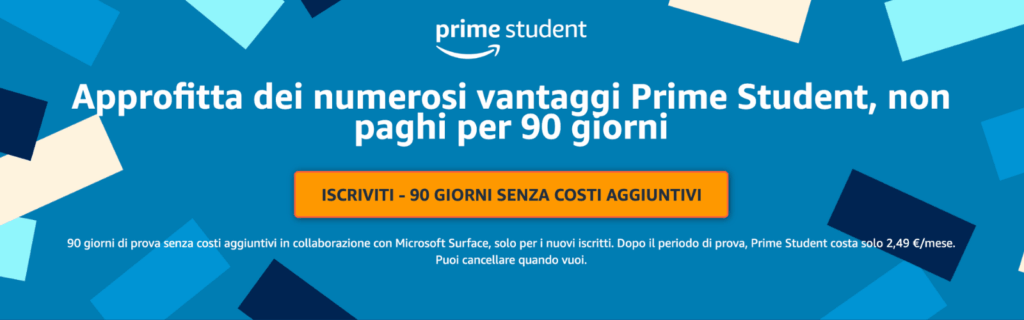
Chega ha saputo inserirsi in questo vuoto. Fondato nel 2019, è passato da un solo parlamentare a una forza capace di contendere l’egemonia politica del Paese. Il suo leader, André Ventura, è un ex commentatore calcistico che ha costruito il suo profilo pubblico su uno stile aggressivo, polarizzante, iper-semplificato. Ventura ha dichiarato di aver “ucciso il bipolarismo” e di voler rappresentare chi è stato “umiliato in questi 50 anni di regime”. La sua narrativa rifiuta la complessità, propone un nemico interno (i migranti, la corruzione, l’establishment) e un linguaggio di riscatto immediato.
Il voto a Chega è un voto di protesta, ma anche di proposta – per quanto estrema. Parla ai giovani disillusi, agli esclusi dalle traiettorie di crescita, ai nostalgici di un ordine più semplice. E lo fa in maniera diretta: con slogan efficaci, una presenza costante sui social media, un uso pervasivo della disinformazione e una grammatica emozionale. Le somiglianze con il trumpismo, con Bolsonaro e con alcune destre illiberali europee sono evidenti: Ventura si ispira apertamente a questi modelli, adottandone i codici comunicativi e le posture simboliche.
La comunicazione è la vera arma di Chega. Dove i partiti tradizionali faticano a imporsi nel circuito mediale, Ventura domina il ciclo informativo con dichiarazioni forti, provocazioni mirate e una capacità quasi chirurgica di alimentare lo scontro. Il suo lessico non conosce mediazioni: è il “basta” del nome del partito (“Chega” significa “Basta”). Il partito si struttura intorno alla sua figura, in una forma di verticalità autoritaria mascherata da partecipazione popolare. In questo contesto, le democrazie rappresentative diventano vulnerabili: non solo per l’instabilità numerica, ma per l’erosione della loro capacità di costruire senso condiviso.
Una democrazia in affanno tra instabilità e frustrazione sociale
Il Portogallo attraversa una fase di instabilità cronica. Le elezioni anticipate del 2025 arrivano a meno di un anno dalla caduta del governo Montenegro, provocata da un voto di sfiducia legato a possibili conflitti di interesse nella sua società privata. Un contesto di fragilità istituzionale che ha alimentato il senso di sfiducia verso la politica, già alimentato da anni di stagnazione economica, crisi abitative, gestione caotica delle politiche migratorie e percezione di corruzione diffusa.
Il governo che nascerà da queste elezioni sarà molto probabilmente di minoranza. AD ha ottenuto 88 seggi su 230, ben lontani dalla soglia della maggioranza assoluta (116). I possibili alleati – come Iniziativa Liberale, con 9 deputati – hanno già dichiarato di voler restare all’opposizione. Una grande coalizione con il Partito Socialista appare irrealistica, sia per ragioni numeriche sia per la distanza ideologica e per la campagna particolarmente dura tra i due schieramenti. Il risultato è un Parlamento bloccato, dove ogni misura dovrà essere negoziata a caro prezzo, con il rischio di paralisi decisionale e nuove elezioni.
Montenegro, dunque, si avvia così alla formazione di un nuovo governo di minoranza, destinato a navigare in acque agitate e con capacità di manovra estremamente limitata. A complicare ulteriormente il quadro è il fatto che, secondo la legge portoghese, non si potranno indire nuove elezioni anticipate nei prossimi sei mesi. Ciò significa che il governo che nascerà dovrà sopravvivere in un clima parlamentare fortemente polarizzato e privo di una maggioranza coesa, con le mani legate rispetto a qualsiasi iniziativa strutturale.
La crisi del Partito Socialista portoghese
Nel frattempo, il Partito Socialista vive una crisi di leadership profonda. Dopo nove anni al governo con António Costa, il passaggio di testimone a Pedro Nuno Santos si è rivelato fallimentare. Il PS ha perso oltre 400mila voti e 20 deputati. Nuno Santos si è dimesso subito dopo i risultati, lasciando il partito in una fase di transizione delicata. Il suo successore dovrà decidere se collaborare con Montenegro o mantenere una linea dura all’opposizione. In entrambi i casi, le scelte avranno ricadute profonde sulla stabilità del sistema.
Sul piano territoriale, la geografia del voto è eloquente: Chega ha vinto in regioni tradizionalmente socialiste come l’Algarve, Beja, Setúbal e Portalegre. Un segnale inequivocabile di mutamento delle basi sociali del consenso. Anche la diaspora ha premiato Chega, soprattutto nei Paesi dell’Europa occidentale – eccezion fatta per Scandinavia e Portogallo. Si conferma così una tendenza già vista in altri contesti: i cittadini espatriati, spesso in contesti socio-politici dominati dalla retorica sovranista, tendono a proiettarla nel voto del Paese d’origine.
Nel mezzo, la coalizione AD si presenta come forza moderata ma senza una strategia chiara per affrontare la sfida populista. Montenegro ha escluso alleanze con Chega, ma non ha i numeri per governare da solo. Il rischio è una ripetizione del passato: governi brevi, crisi ricorrenti, e un sistema politico che si logora sotto il peso della sua stessa indecisione. In assenza di un’opposizione credibile e di proposte pragmatiche, l’elettorato si rifugia nella radicalità.
Tutto ciò premia la strategia di Chega, che, a questo punto, appare chiara: sfruttare la fragilità dell’esecutivo di minoranza per porsi come unica alternativa credibile e, in prospettiva, come forza di maggioranza e la faglia dell’immobilismo di un esecutivo di minoranza alle prossime elezioni. I sei mesi diventano, in definitiva, un potenziale serbatoio per accrescere l’estenuante ma redditizia, retorica anti-establishment.
La crisi della sinistra sinonimo della crisi rappresentativa
Il caso portoghese si inserisce in un trend europeo ormai consolidato. Anche in Paesi dalla lunga tradizione socialista, come il Portogallo, la tenuta della democrazia rappresentativa è messa alla prova dalla crisi della fiducia, dalla fatica della complessità e dalla pervasività delle nuove destre. Chega non è più un outsider: è un attore strutturato, che comunica, si espande e ambisce a governare. E lo fa con gli strumenti del nostro tempo: polarizzazione, algoritmi, storytelling identitario.
Nel contesto portoghese, la crescita della destra radicale non è un’anomalia, ma il sintomo di un disagio più ampio: quello di cittadini che non si riconoscono più nei codici della mediazione, e che cercano scorciatoie identitarie per affrontare le sfide del presente. La comunicazione della destra portoghese ricalca modelli internazionali, ma li declina in forma locale: è nazionalista, ma anche municipalista; è aggressiva, ma capace di mimetizzarsi nel linguaggio quotidiano.
In questo quadro, l’Unione Europea ha un compito difficile: accompagnare i Paesi membri nella gestione della frattura tra istituzioni e società. Il Portogallo è solo l’ultimo esempio di una faglia che si allarga. Senza un nuovo patto sociale, nuove forme di rappresentanza e una comunicazione più efficace e partecipativa, la tentazione populista continuerà a crescere. E con essa, il rischio di una democrazia che, pur formalmente integra, perde il suo legame vitale con il popolo.
La lezione è chiara: non basta vincere le elezioni. Serve ricostruire un senso condiviso, una visione comune, e una capacità di ascolto che oggi, nella politica tradizionale, appare sempre più lontana.