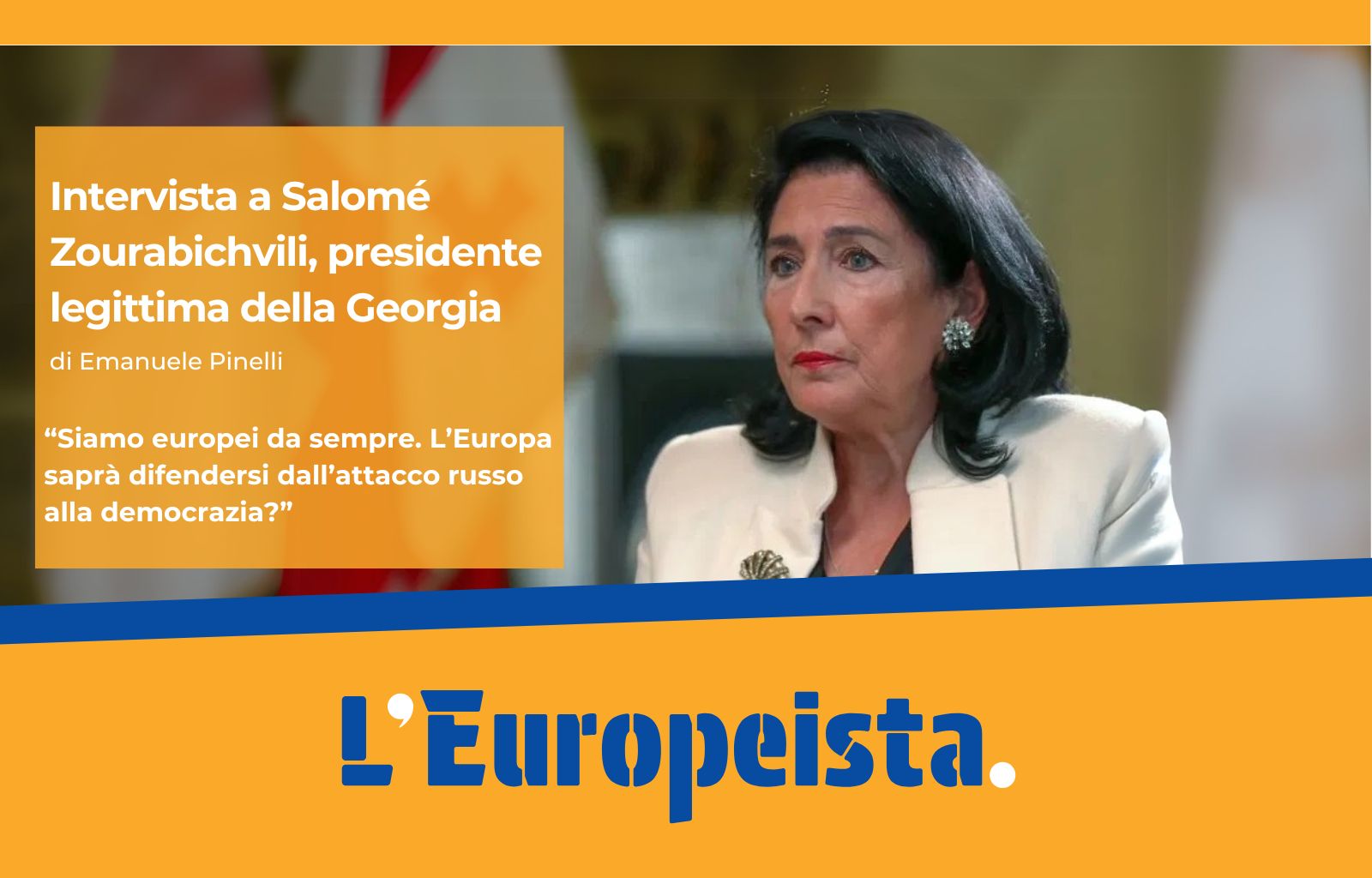Spazio, tallone d’Achille dell’autonomia strategica europea

Nel cuore della notte artica, lo scorso 30 marzo, un razzo europeo ha solcato per pochi istanti il cielo di Andøya, in Norvegia. Doveva essere il primo lancio orbitale interamente europeo — costruito da una start-up tedesca, lanciato da un sito nel Vecchio Continente, pensato per piccoli satelliti strategici. Dopo 40 secondi, lo Spectrum di Isar Aerospace è esploso in volo. Un fallimento tecnico, certo, ma anche il simbolo di una debolezza sistemica che affligge l’Europa: la dipendenza dagli Stati Uniti per tutto ciò che riguarda la dimensione spaziale della sicurezza e della difesa.
Lo hanno sottolineato Jo Inge Bekkevold e Jonas Vidhammer Berge in un articolo pubblicato il 5 maggio su Foreign Policy: senza capacità spaziali proprie, le forze armate europee sono “cieche e inchiodate a terra”. Lo spazio non è più soltanto il teatro di missioni scientifiche o il regno delle telecomunicazioni civili, ma il dominio invisibile da cui dipendono oggi intelligence, posizionamento, navigazione, comunicazioni sicure, capacità di deterrenza e condotta operativa nelle guerre moderne. Eppure, in questo campo cruciale, l’Europa è in ritardo.
Un confronto impietoso con le grandi potenze
Il confronto con gli altri attori globali è impietoso. Mentre gli Stati Uniti rafforzano la propria egemonia con la Space Force e la collaborazione pubblico-privato (SpaceX su tutti), e la Cina accelera la sua presenza con costellazioni da decine di migliaia di satelliti, l’Europa arranca. Anche la Russia, nonostante le sanzioni, dispone di una rete spaziale militare superiore a quella europea. L’unico vero progetto autonomo degno di nota è Galileo, il sistema di navigazione satellitare sviluppato dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA), alternativo al GPS americano. Ma non basta.
In termini di capacità di lancio, l’Europa resta indietro. Tra il 2022 e il 2024, su 672 lanci orbitali globali, solo 12 sono stati europei, e la maggior parte di questi è partita dalla base di Kourou nella Guyana francese — tecnicamente su suolo sudamericano. Il razzo Ariane 6, punta di diamante dell’ESA, ha volato per la prima volta nel marzo 2025, con cinque anni di ritardo rispetto alla tabella di marcia. Intanto, le start-up spaziali europee sono frammentate, sottofinanziate e scarsamente coordinate. Lo spazio commerciale è oggi dominato da attori americani e asiatici, capaci di attirare capitali e talenti su scala globale. Il confronto con SpaceX è sconfortante: Elon Musk ha già dispiegato oltre 7.000 satelliti in orbita bassa con Starlink, mentre l’UE punta a metterne in orbita 290 entro il 2030 con il progetto IRIS² — un’iniziativa che, nella migliore delle ipotesi, arriverà troppo tardi per incidere sulle crisi geopolitiche in corso.
Verso una dottrina spaziale europea
Eppure, qualcosa si muove. La Commissione Europea ha pubblicato a marzo il White Paper for European Defence – Readiness 2030, riconoscendo esplicitamente la necessità di colmare le lacune nel dominio spaziale. Il nuovo Space Act europeo, atteso per la seconda metà del 2025, dovrebbe dare un quadro normativo a un settore che fatica a decollare. Le società SES e Thales Alenia Space, insieme ad altre, si stanno mobilitando per fornire soluzioni alternative a Starlink, in particolare per garantire connettività in scenari di guerra o emergenza. Secondo Reuters, SES è già in trattativa con l’UE per fornire una copertura satellitare continua in Europa orientale e nel Mediterraneo.
C’è poi la questione strategica. Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca ha incrinato la fiducia europea nell’ombrello statunitense. Sebbene il nuovo Segretario di Stato Marco Rubio abbia rassicurato gli alleati europei sull’impegno americano verso la NATO, le ambiguità politiche rimangono. La vicenda di Starlink e dell’influenza esercitata da Musk sul conflitto ucraino — incluso il veto imposto all’uso dei satelliti in Crimea — ha dimostrato quanto sia rischioso affidare a operatori esterni (e in parte privati) strumenti così cruciali per la sicurezza.
Il futuro dello spazio sarà segnato dal confronto e dalla competizione. Lo ha dichiarato senza mezzi termini anche il comandante dello U.S. Space Command, il generale Stephen Whiting, a margine del Space Symposium tenutosi in Colorado ad aprile: “Lo spazio è ormai un dominio conteso. I satelliti saranno i bersagli del prossimo conflitto.” Parole che richiederebbero una risposta europea più netta, sul piano tecnologico, industriale e strategico.
Serve una dottrina spaziale europea, che integri le capacità civili e militari, promuova la resilienza delle infrastrutture critiche e investa nella possibilità — finora solo accennata — di sviluppare anche capacità anti-satellite difensive. Investire nello spazio, inoltre, non significa solo rafforzare la difesa: molte tecnologie spaziali hanno impatti civili e dual-use, come dimostra la storia stessa del programma Apollo, che ha accelerato lo sviluppo di microchip, imaging medicale e materiali avanzati.
L’Europa ha le risorse, il capitale umano e l’ambizione per diventare una potenza spaziale autonoma. Ma manca ancora una visione coerente. Se davvero il continente vuole esercitare una sovranità piena e credibile, non può restare spettatore nello spazio. Occorre una nuova stagione di politica industriale, una vera alleanza tra pubblico e privato, e soprattutto una volontà politica condivisa di proiettarsi — anche tra le stelle — come Unione. Perché, come scrivono Bekkevold e Berge, “una potenza militare senza capacità spaziali è cieca”. E oggi l’Europa, accecata dal suo stesso disincanto, rischia di restare ferma al suolo.