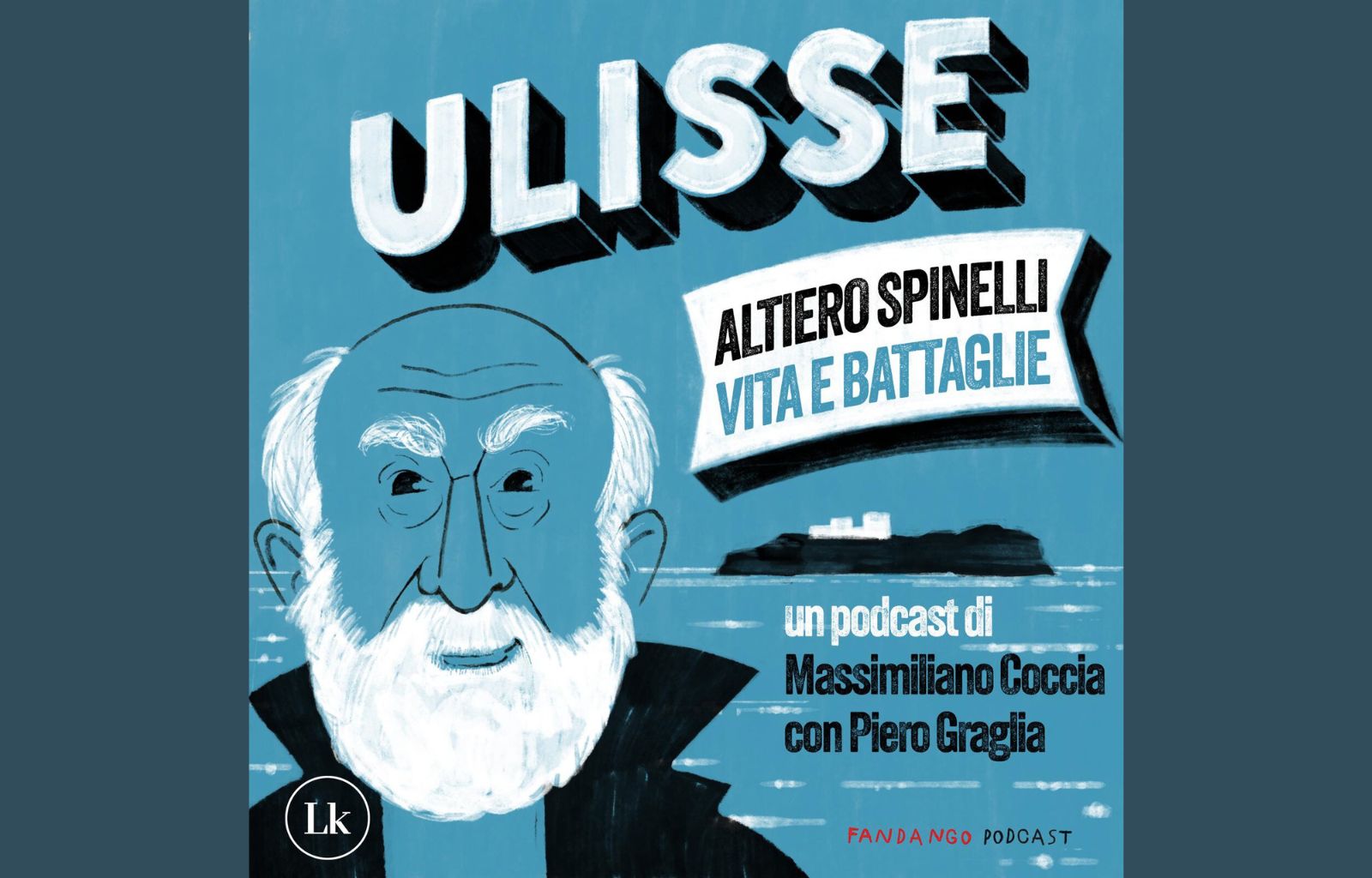Pagliara e la geopolitica del rischio: “Taiwan è il test di credibilità dell’Occidente”
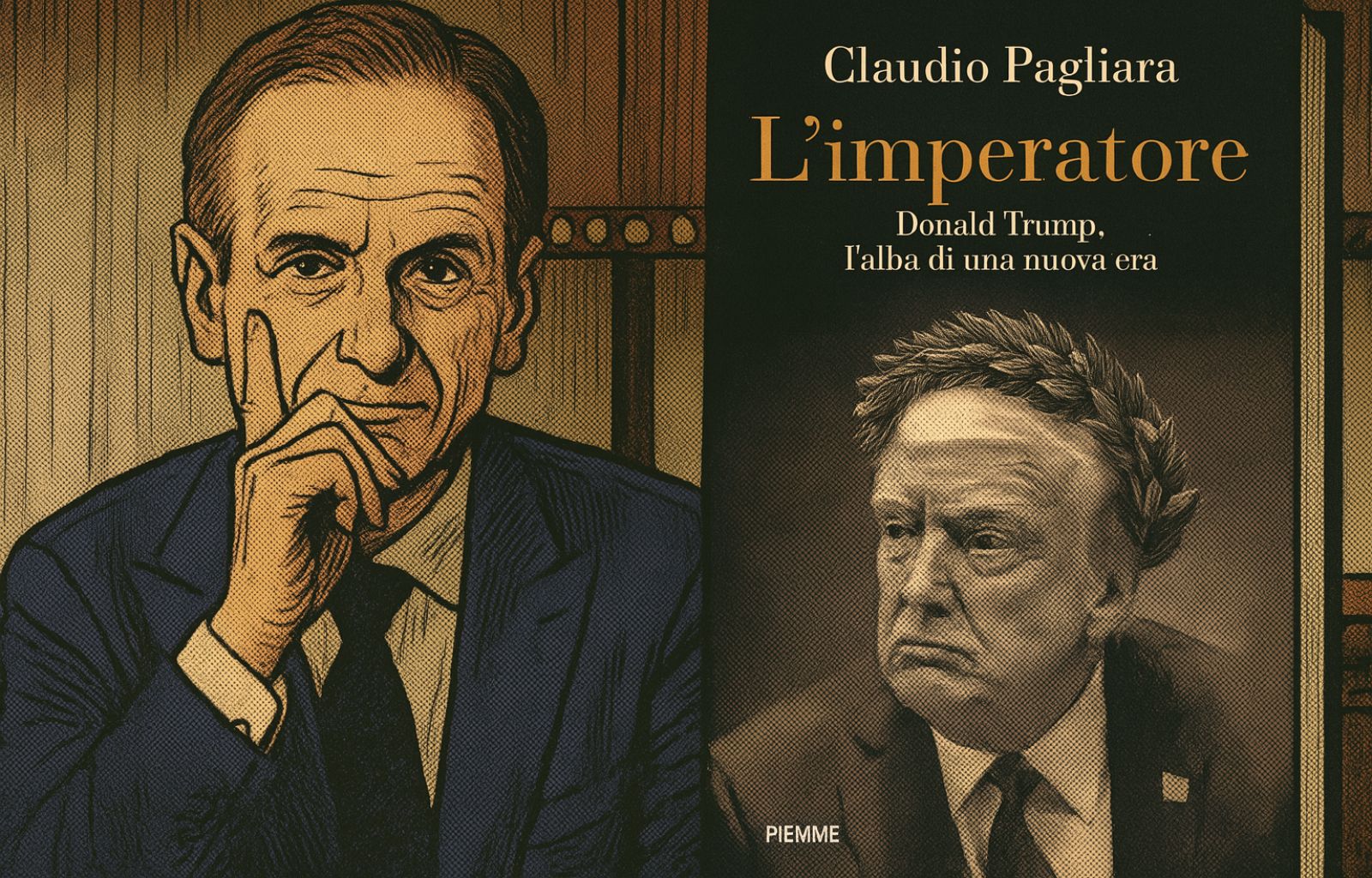
In un momento cruciale per gli equilibri internazionali, l’esperienza e l’analisi di Claudio Pagliara, giornalista e autore del libro “L’Imperatore. Donald Trump, l’alba di una nuova era”, offrono una chiave di lettura preziosa sulle tensioni tra Stati Uniti, Cina e Taiwan.
Nel corso dell’intervista, Pagliara affronta i temi più caldi della geopolitica attuale: dalle strategie di deterrenza americana alle sfide della democrazia taiwanese, passando per il ruolo crescente della NATO e le insidie della guerra ibrida. Un dialogo ricco di spunti per comprendere le dinamiche che stanno ridefinendo il futuro dell’Asia e dell’Occidente, con focus sul dossier Taiwan.
Ringrazio profondamente Claudio Pagliara per questa grandissima opportunità.
Oggi, alla luce dei mutati equilibri globali e di un clima di incertezza totale, quale potrebbe essere la postura di Trump verso Taiwan? Soprattutto nel caso in cui Pechino dovesse decidere di invadere l’isola.
Il punto di forza della presidenza Trump è la sua volontà di mantenere incertezza sui suoi comportamenti e questo è davvero un punto di forza e lo ha dimostrato recentemente anche nei confronti dell’Iran: dopo aver escluso un intervento contro l’Iran, in realtà lo ha compiuto, anche se in un modo limitato per evitare che ciò sfociasse in una guerra nella quale gli Stati Uniti venissero risucchiati.
Trump vuole evitare il coinvolgimento degli Stati Uniti in conflitti lontani e vuole usare la forza enorme e impareggiabile che ancora adesso gli Stati Uniti hanno, una forza militare come deterrenza e mantenere l’incertezza, cosa che è peraltro sancita nella politica che gli Stati Uniti hanno sempre perseguito nei confronti di Taiwan: l’incertezza strategica, non rivelare come reagirebbero.
Con Trump questa incertezza strategica acquista un nuovo stato perché davvero lui è imprevedibile e questa imprevedibilità è auspicabile che funga da deterrente nei confronti di un regime, quello cinese, che, come sappiamo, è molto determinato a ottenere la “riunificazione” (come viene chiamata a Pechino) con Taiwan, di fatto indipendente.
È un deterrente perché ovviamente nessuno davvero potrebbe dire oggi come reagirebbe Trump, probabilmente neppure lo stesso Trump lo sa, dipenderà da molte circostanze, da molte condizioni. Di certo la Cina sa che un passo del genere gli produrrebbe un danno economico globale enorme. Lo si è visto molto bene anche nei confronti della Russia. Con la Cina, le sanzioni sarebbero ancora più devastanti, certamente per tutto il resto del pianeta visto cosa rappresenta la Cina da un punto di vista economico, che è molte volte più grande di quanto lo rappresentava la Russia, ma lo sarebbe anche per la Cina stessa visto che l’economia cinese si basa sostanzialmente per il 65% sulle esportazioni e questo è anche un tallone d’Achille molto grosso. Dunque, è un passo possibile, ma certamente che i dirigenti cinesi andranno a ponderare con grande cautela e attenzione, ancora di più ora che alla Casa Bianca c’è un Trump le cui mosse non sono assolutamente prevedibili.
Ricordo che quando ero ancora a Pechino mi fu detto all’Università Beida, da un docente universitario considerato un grande esperto di relazioni tra Cina e Stati Uniti, che all’epoca della prima presidenza Trump molti giornalisti occidentali avevano scritto che Pechino faceva il tifo per Trump contro Hillary Clinton e lui mi disse: “non avete capito nulla, per Pechino Hillary Clinton era prevedibile”, ciò che nella mente della dirigenza comunista è veramente molto difficile da accettare. L’imprevedibilità nei rapporti con altri leader, questa imprevedibilità ancora accentuata nella seconda presidenza Trump e come si è visto molto chiaramente nella questione iraniana, costituisce a mio modo di vedere una deterrenza che forse sarà, speriamo, auspicabilmente sufficiente a scoraggiare Pechino da compiere questo passo.
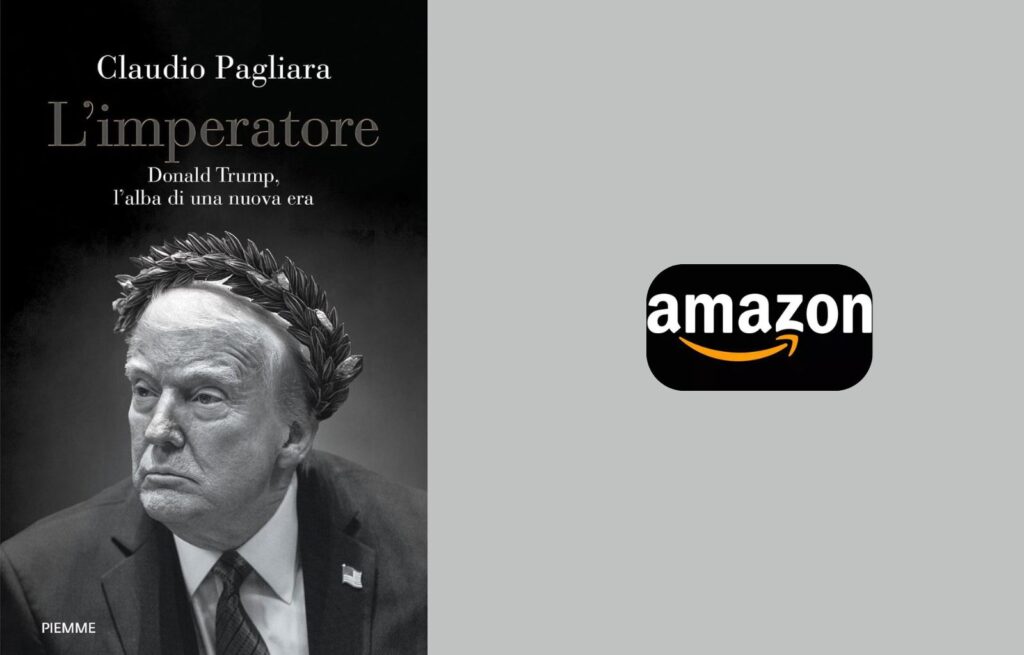
Secondo lei, è realistico, e soprattutto necessario, che Taiwan porti la spesa per la difesa al 5% del PIL, come indicato da Trump? E fino a che punto un tale investimento rappresenta una soglia strategica concreta per garantire la deterrenza nei confronti di Pechino?
Non esiste un numero magico che garantisca a Taiwan la certezza di non essere invasa da Pechino, esiste però una necessità ovviamente per un’economia industrializzata come quella di Taiwan di dimostrare ad un partner strategico come gli Stati Uniti che intende sacrificare una fetta della ricchezza nazionale nella sua difesa.
Gli Stati Uniti di Trump segnano una svolta nelle relazioni tra questo paese e tutto il resto del mondo.
Quando Trump dice “America first” lo dice a tutti, ai rivali, ma anche agli alleati strategici. È di queste ore la notizia dei dazi imposti alla Corea del Sud e al Giappone, quindi alleati strategici.
Trump ha vinto le elezioni perché è stato votato da un popolo, quello dei dimenticati, che sono stati messi ai margini dalla globalizzazione. A loro parla e quando dice anche a Taiwan “noi possiamo difendervi, ma voi (Taiwan) dovete aumentare la spesa”, è molto importante secondo me per Taiwan fare di tutto per rispondere a questa domanda in maniera positiva.
Ne va della sicurezza nazionale, qui non è questione se gli Stati Uniti interverranno o meno, gli Stati Uniti potranno anche intervenire, ma è chiaro che, come mostra il caso ucraino, deve essere poi la popolazione di Taiwan che si batte per difendere l’indipendenza nel caso più estremo di un’invasione e tutto ciò è ancora da provare. Tanti anni di “al lupo al lupo” probabilmente non sono stati chiaramente molto utili a creare una mentalità per cui la sicurezza ha un costo e credo che su questo i governi prima di Tsai Ing-wen e adesso del nuovo Presidente (Lai Ching-te) stanno facendo dei grandi passi avanti, ma molto resta da fare.
Aumentare le spese per la difesa significa anche aumentare le spese per l’autodifesa, per preparare la popolazione a come difendersi e, nel caso peggiore, per mettere nelle condizioni l’esercito di resistere il tempo necessario alle truppe americane per intervenire.
Dunque, uno Stato che ha una minaccia così grande, così vicina ovviamente non può che ascoltare il suo principale alleato e aumentare le spese per la difesa. Nessun dirigente può dire “non possiamo arrivare al 5%”, abbiamo visto in altri paesi come i baltici e la Polonia aumentare di molto le spese per la difesa, avvicinarsi al 5% proprio perché la minaccia per loro è molto più vicina di quanto non sia per l’Italia la minaccia russa. Nessun paese è più minacciato di Taiwan, dunque penso che il 5% non sia un obiettivo irraggiungibile per i taiwanesi.
Certo fa fatica, tutti fanno fatica ma bisogna capire che gli Stati Uniti non faranno più da poliziotto del mondo perché non se lo possono neanche più permettere, hanno problemi interni che ovviamente vengono prima di tutti gli altri.
La NATO di oggi guarda anche verso Taiwan?
Secondo lei, Taiwan è davvero entrata nel radar delle preoccupazioni strategiche della NATO? E questo può rappresentare un nuovo deterrente per Pechino?
Che ci possa essere un coordinamento secondo me è nei fatti, non sarà mica un caso che Xi Jinping e Putin hanno firmato un accordo che prevede un’amicizia senza limiti, poche settimane prima che le truppe russe invadessero l’Ucraina, come sappiamo.
Taiwan ha sempre visto nell’Ucraina un caso speculare al proprio, un successo dell’Occidente nel difendere l’Ucraina, ovvero un successo russo in Ucraina a mio modo di vedere darebbe il disco verde a Xi Jinping per tentare l’invasione di Taiwan; dunque, è necessario che la NATO faccia la sua parte assieme agli Stati Uniti ovviamente, però, anche i paesi europei con un ruolo maggiore come sta avvenendo per difendere l’Ucraina.
Certo, la NATO non ha tra i suoi compiti quello di difendere Taiwan, ma certamente può mandare un segnale molto forte. La determinazione della Nato nel difendere l’Ucraina è un deterrente nei confronti di Xi Jinping, il contrario, ovvero una disfatta dell’Ucraina ahimè, penso che sarebbe davvero interpretata a Pechino come il disco verde per poter portare a termine questo progetto che, come sappiamo, è scritto nei cromosomi del partito comunista cinese che fa riferimento alla Cina nel suo apogeo dell’impero Qing, quando comprendeva anche Taiwan e dunque la determinazione del partito comunista cinese nel conseguire questo obiettivo non può essere messa in discussione.
Per la NATO, fa già molto se riesce a fermare Putin in Ucraina e certamente con i suoi alleati, Corea del Sud e Giappone, c’è un coordinamento come sappiamo ad un altro livello. Ma è chiaro che la NATO non può essere estesa a Taiwan. Questa nasce come alleanza atlantica e dunque quella è un’altra area del mondo.
Certamente è molto importante per la NATO giocare un ruolo crescente in Ucraina perché abbiamo visto che gli Stati Uniti chiedono ai paesi NATO di aumentare le spese per la difesa e lo chiedono anche perché sanno che lo scontro reale di egemonia si gioca ormai sempre di più in Asia e dunque devono liberare risorse per quel teatro lì.
Guerra ibrida, spionaggio e destabilizzazione sociale: il nuovo fronte invisibile
La Cina ha ormai spostato parte del conflitto sul terreno ibrido? E quanto è solida, secondo lei, la società taiwanese nel resistere a questa costante pressione psicologica e culturale?
*È una sfida davvero molto importante, la guerra ibrida è parte a tutti gli effetti di quella tradizionale, nel senso può precederla e può servire a spianare la strada, indebolendo la capacità di resistenza, l’umore, la convinzione, quindi è una minaccia enorme.
Il governo taiwanese però è all’avanguardia in questo, anzi credo che l’Europa dovrebbe prendere esempio dal governo taiwanese nel contrastare gli attacchi informatici, le fake news.
(Riferito al governo di Taiwan) Hanno molti più strumenti di quanti non ne abbiamo noi in Italia per contrastare questa offensiva cinese, proprio perché la Cina utilizza questi strumenti in modo massiccio e senza precedenti per tentare di minare la resistenza psicologica dei taiwanesi.
Proprio per questo hanno sviluppato, anche grazie al fatto che sono una superpotenza tecnologica, degli strumenti per contrastarlo; quindi, da questo punto di vista credo che abbiano gli strumenti per resistere e anzi io auspico che su questo terreno ci sia un dialogo con i paesi europei perché noi siamo molto più permeabili alle campagne di disinformazione cinese e russa di quanto i taiwanesi non siano nei confronti di quella cinese, avendo sviluppato degli anticorpi che sono molto potenti.
Secondo lei, è proprio questa luce democratica che spaventa maggiormente Pechino? Taiwan dimostra che un’alternativa al sistema cinese è possibile – quanto è ideologico e quanto strategico l’obiettivo della Cina di spegnere questa luce?
Il nemico numero uno comunista cinese è ovviamente una democrazia di tipo liberale che ha trovato a Taiwan dopo gli anni bui di Chiang Kai-shek un terreno estremamente fertile, un paese profondamente radicato nella cultura asiatica, anche profondamente confuciano che non ha subito lo shock della rivoluzione culturale, pur tuttavia una democrazia che tutti gli indici indicano essere in cima alla lista dei paesi democratici del mondo. Dunque, essere un paese confuciano, parlare mandarino e vivere in una democrazia è possibile.
Questo certamente spaventa enormemente il regime comunista cinese che con crescente uso di tecnologie sempre più sofisticate sta e continua a restringere ogni spazio di possibilità democratica nel suo paese. La democrazia può essere contagiosa, dunque immagino che nel voler annettere Taiwan, il fatto di spegnere questo paese democratico sia in cima ai motivi per cui ciò viene ritenuto necessario.
Ce ne sono altre geopolitiche altrettanto importanti: la prima linea, l’influenza che ciò avrebbe su Giappone e Corea del Sud, lo spostamento dell’ago geopolitico dagli Stati Uniti alla Cina se andasse in porto un’annessione con la forza di Taiwan.
Tutto ciò ha un peso, ma non bisogna sottovalutare anche il fatto che questa democrazia che parla mandarino ed è confuciana, è una spina nel fianco del regime comunista cinese, che certamente Xi Jinping vorrebbe decisamente spegnere costi quel che costi.
Xi Jinping, un potere assoluto o in crisi interna?
Secondo lei, è davvero realistico immaginare una Cina post-Xi? E quanto l’instabilità interna può accelerare o frenare l’aggressività cinese verso Taiwan?
Grazie a Dio, nessuno è immortale, quindi una Cina dopo Xi non è solo possibile ma è una certezza, prima o poi chiunque di noi esce di scena in un modo o nell’altro. La stabilità politica del regime cinese ovviamente è descritta spesso come molto forte, i segnali in realtà ci dicono che le cose non stiano così sono molti.
La disoccupazione giovanile, la stessa repressione che continua ad aumentare. Un regime che si sente sicuro di sé stesso può anche tollerare un pochino anche altre voci al suo interno; invece, la tolleranza è sempre più vicina allo zero.
Dell’economista che aveva osato dire che la disoccupazione è maggiore delle statistiche ufficiali non si hanno più tracce da quando lo ha detto.
Qualunque voce anche basata su dati fattuali che non sia in linea con quello che è la propaganda del regime viene messa a tacere con mezzi sempre più sofisticati. Tutto ciò a mio modo di vedere non depone a favore di una stabilità del regime, ma al contrario, conferma le voci che questo regime non è stabile e non è riuscito ancora a mettere fine alla bolla immobiliare. Ciò significa che per decine di milioni di cinesi il futuro dopo il lavoro è quanto mai incerto. Il mercato immobiliare ha in Cina lo stesso valore che ha in America il mercato mobiliare.
I fondi pensioni in America si reggono su Wall Street, in Cina la terza età ha puntato sul mercato immobiliare per avere garanzie di sicurezza. Un mercato immobiliare che continua a perdere valore implica che una fetta crescente di popolazione si trova in crescente difficoltà e anche questo è un fattore che aumenta l’instabilità del regime, quindi disoccupazione giovanile, incertezza per i più anziani, una incapacità di portare a termine ciò che era stato detto dallo stesso gruppo dirigente comunista. È stato visto dunque come una necessità di spostare l’economia cinese dalle esportazioni ai consumi e continua a essere super dipendente dalle esportazioni (Cina) e quindi super vulnerabile ai dazi. Hanno un grande punto di forza che è quello delle terre rare e in effetti l’hanno abilmente utilizzato per imporre a Trump una retromarcia sui dazi, però come sempre quando i punti di forza sono così evidenti poi il mondo corre ai ripari un po’ dappertutto. Ormai si sta cominciando a riscoprire miniere di terre rare che costi quei che costi bisogna attivare; dunque, non è un punto di forza eterno della Cina.
I punti di debolezza invece sono moltissimi e poi ci sono segnali che sono stati rivelati e l’ho anche scritto nel libro, molti, decine, centinaia di dirigenti a livelli locali che erano stati nominati da Xi Jinping negli ultimi mesi sono stati accusati da vari organismi locali di corruzione, questo normalmente era accaduto al contrario, erano dirigenti non legati a Xi Jinping, che erano stati epurati, accusandoli di corruzione.
Questo viene visto da molte fonti come un segno che il potere imperiale di Xi Jinping in molte province comincia a traballare. Ora non siamo allo sgretolamento, nessuno può prevedere un crollo. Certamente immagino che all’interno del gruppo dirigente comunista che non è monocratico come sembra, ma che altro sembra una società per azioni, ci sarà una componente che chiede conto a Xi Jinping dei risultati economici, strategici della sua ormai quindicennale presidenza e dunque è anche probabile che dall’interno un giorno qualcuno, una maggioranza del gruppo dirigente gli chieda di farsi da parte o gli impone di farsi da parte. È una probabilità, è una possibilità, non sappiamo veramente dire se questo accadrà tra un mese, un anno, tra dieci anni, ma per ora non vedo molti successi della presidenza Xi Jinping.
Sul piano economico, sì ci sono auto elettriche che costano meno di quelle della Tesla. C’è questa nuova ondata di prodotti ipertecnologici e certamente ben fatti e super finanziati dallo Stato che stanno invadendo i mercati occidentali. Però attenzione, tutto ciò è estremamente vulnerabile con i dazi e Donald Trump ha fatto una marcia indietro tattica, ma l’obiettivo di Donald Trump è quello di costringere la Cina ad applicare regole di mercato, sapendo benissimo che se lo facesse, il regime crollerebbe; quindi, non lo farà e io prevedo nel prossimo futuro un nuovo scontro molto duro sui dazi dove la Cina potrebbe essere molto in difficoltà.
E forse anche la leadership di Xi Jinping, che ha puntato tutto su spingere l’economia high-tech con finanziamenti pubblici, senza fare quelle riforme interne che erano necessarie e che poi avrebbero probabilmente prodotto una società un po’ più libera.
Xi è convinto che l’interesse del partito comunista di perpetuarsi come partito unico al potere viene prima di qualunque altra questione, compresa l’interesse più a lungo termine.
La storia dimostra che i dittatori alla fine cadono in modo imprevisto e spesso violento. Nessuno può prevedere quando ciò accada, ma la storia è piena di dittatori che sembravano potentissimi fino al giorno prima e che poi improvvisamente sono stati defenestrati. Non è che debba avvenire come una presa del palazzo d’inverno. Per i dittatori sono molto più pericolose le rivolte che avvengono all’interno delle stanze dei bottoni.
Penso che Xi Jinping abbia un po’ esagerato nell’accentrare i poteri, nel tornare indietro su tutte le riforme, nel riportare la Cina di fatto all’epoca di Mao, nel chiudere il paese agli investimenti esterni e nel non volere attuare nessuna riforma politica e sociale.
Non vedo risultati eccellenti dal punto di vista della vita quotidiana dei cinesi e questo forse prima o poi porterà anche alla fine del suo potere.
Quanto è importante oggi, anche simbolicamente, il riconoscimento internazionale per Taiwan? E può davvero influire sulla sicurezza strategica dell’isola?
Purtroppo, la One China Policy da quando è stata adottata è una spada di Damocle su Taiwan dalla quale non potrà mai sottrarsi. Fino a che vige questa regola, è chiaro che nessun paese ormai si può permettere di tagliare i ponti con Pechino per riconoscere Taiwan.
È importante mantenere con Taiwan rapporti economici, culturali molto stretti, sempre più stretti. Ovviamente i rapporti diplomatici, fino a che vige la regola di One China Policy, non vedranno altro che assottigliarsi come è accaduto in questi ultimi decenni: il numero di stati che riconosce diplomaticamente Taiwan cala costantemente, ma non ne farei una tragedia francamente.
La battaglia va fatta sugli organismi internazionali. Nulla vieta a Taiwan di essere presente in molte organizzazioni internazionali come l’Organizzazione Sanitaria Mondiale, altre organizzazioni come Paese Osservatore, pur non avendo lo status di paese riconosciuto, come è stato in passato e come invece la Cina è riuscita con successo a evitare. Su questo forse Europa e Stati Uniti potrebbero fare di più.
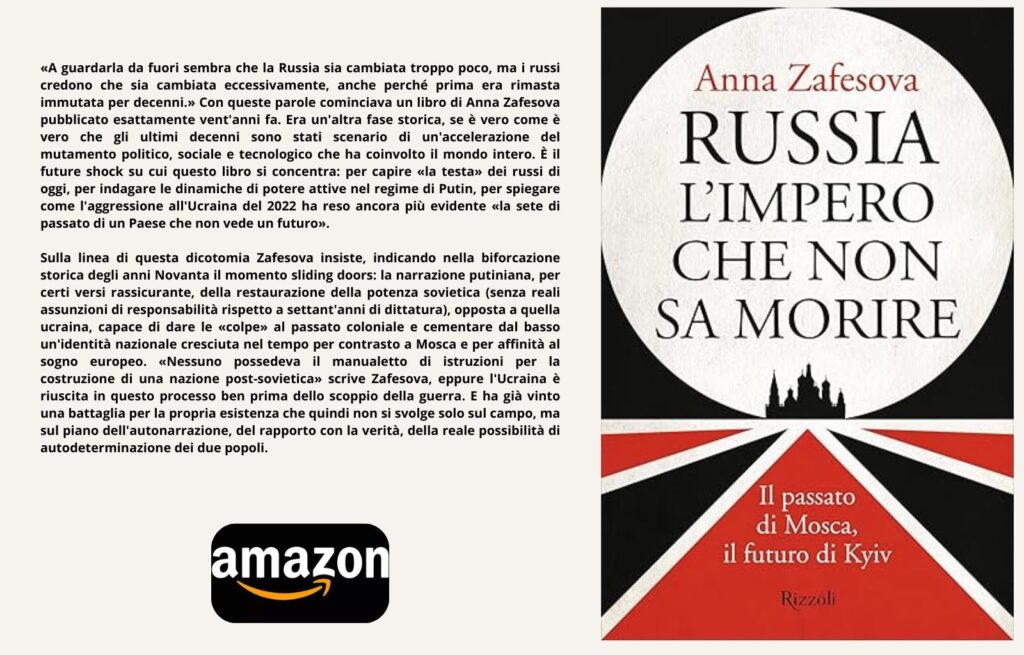
Trump, dazi e Cina, e allora, fino a che punto Pechino può essere dissuasa?
Crede che Washington abbia ancora margini reali per dissuadere Pechino da un’azione militare? E quale potrebbe essere oggi la vera linea rossa americana sul dossier Taiwan?
Io credo che la dissuasione sia ancora possibile. Certamente siamo ad un crocevia molto pericoloso della storia. Ci sono delle forze che vogliono cambiare l’ordine mondiale, Russia e Cina in testa. In questo frangente in cui il regime cinese è in difficoltà all’interno, la carta del nazionalismo con una avventura militare a Taiwan è un rischio concreto. Sull’altro piatto della bilancia, ci sono i costi di un passo del genere.
La conquista lampo di Taiwan non è possibile e lo sanno molto bene gli strateghi cinesi. La probabilità che gli Stati Uniti interverrebbero è molto alta. Tutto ciò pesa come forte deterrenza. Io credo che ci siano ancora forti margini per la deterrenza. Certo, se il regime si trovasse alle corde per ragioni che magari neanche noi conosciamo fino in fondo, potrebbe tentare come in passato un’avventura del genere.
Ciò che può fare l’Occidente è difendere lo status quo e far capire che la violazione di quest’ultimo avrebbe conseguenze molto gravi per Pechino. Questo lo deve dire con forza, senza violare i principi e le regole della diplomazia internazionale. Questa è una cosa che purtroppo spesso l’Occidente, per ragioni utilitaristiche, non dice.
Ricordo l’infelice espressione di Macron quando tornò da un viaggio da Pechino: disse che “Taiwan non è un nostro problema” e penso che queste dichiarazioni andrebbero evitate. Sappiamo che su questo l’Europa è molto divisa.
Però forse una riflessione più accurata su cosa significherebbe una caduta di Taiwan andrebbe fatta a livello collettivo. Chiunque aiuti a comprendere che le cose sono interconnesse e che una conquista da parte della Cina di Taiwan avrebbe ripercussioni anche in Europa, spingerebbe Putin ad essere ancora più aggressivo nei confronti degli altri paesi europei.
Capire che c’è un asse che vuole cambiare gli equilibri usciti dalla Seconda guerra mondiale, che non sono certamente equilibri eterni, ma sono equilibri che si fondavano sul rispetto della legge internazionale, sul rispetto della democrazia.
Paesi che hanno a cuore il futuro delle democrazie liberali dovrebbero essere un po’ più chiari sul fatto che ci sono delle linee rosse. La linea rossa vera che l’Europa può tracciare senza rompere con Pechino è quella di una soluzione diplomatica. Che non si usi la forza per alterare lo status quo di Taiwan.
Questa è la linea rossa che andrebbe affermata in tutte le occasioni possibili con estrema chiarezza, che l’uso della forza andrebbe considerato inaccettabile e avrebbe delle conseguenze gravissime su Pechino come ce le ha avute per la Russia quando ha invaso l’Ucraina. Questo passo aiuterebbe ad aumentare la deterrenza ed evitare che si scivoli in un conflitto che a quel punto sarebbe necessariamente globale e dunque, questa terza guerra mondiale a pezzi, risulterebbe purtroppo in un conflitto totale.