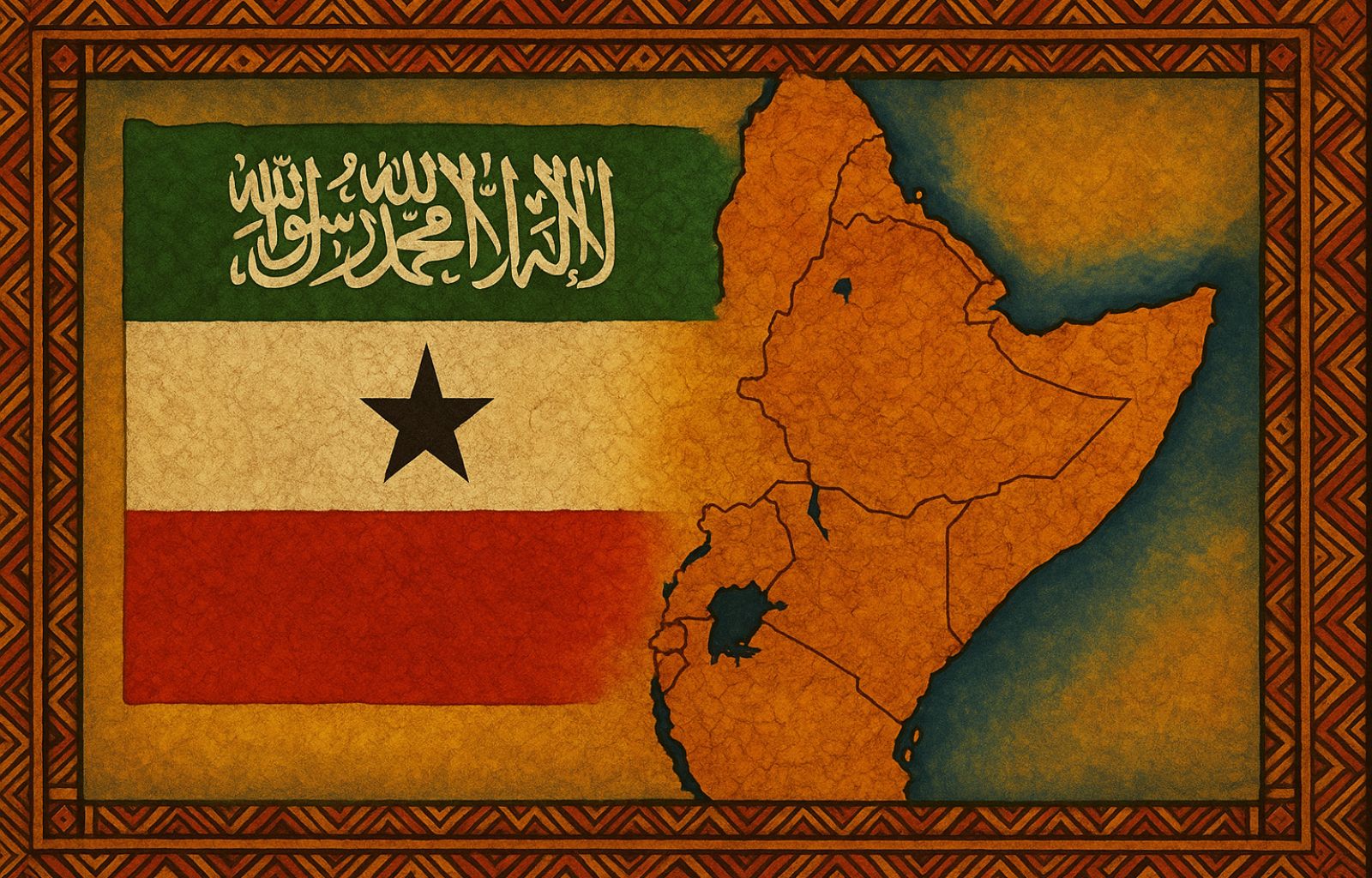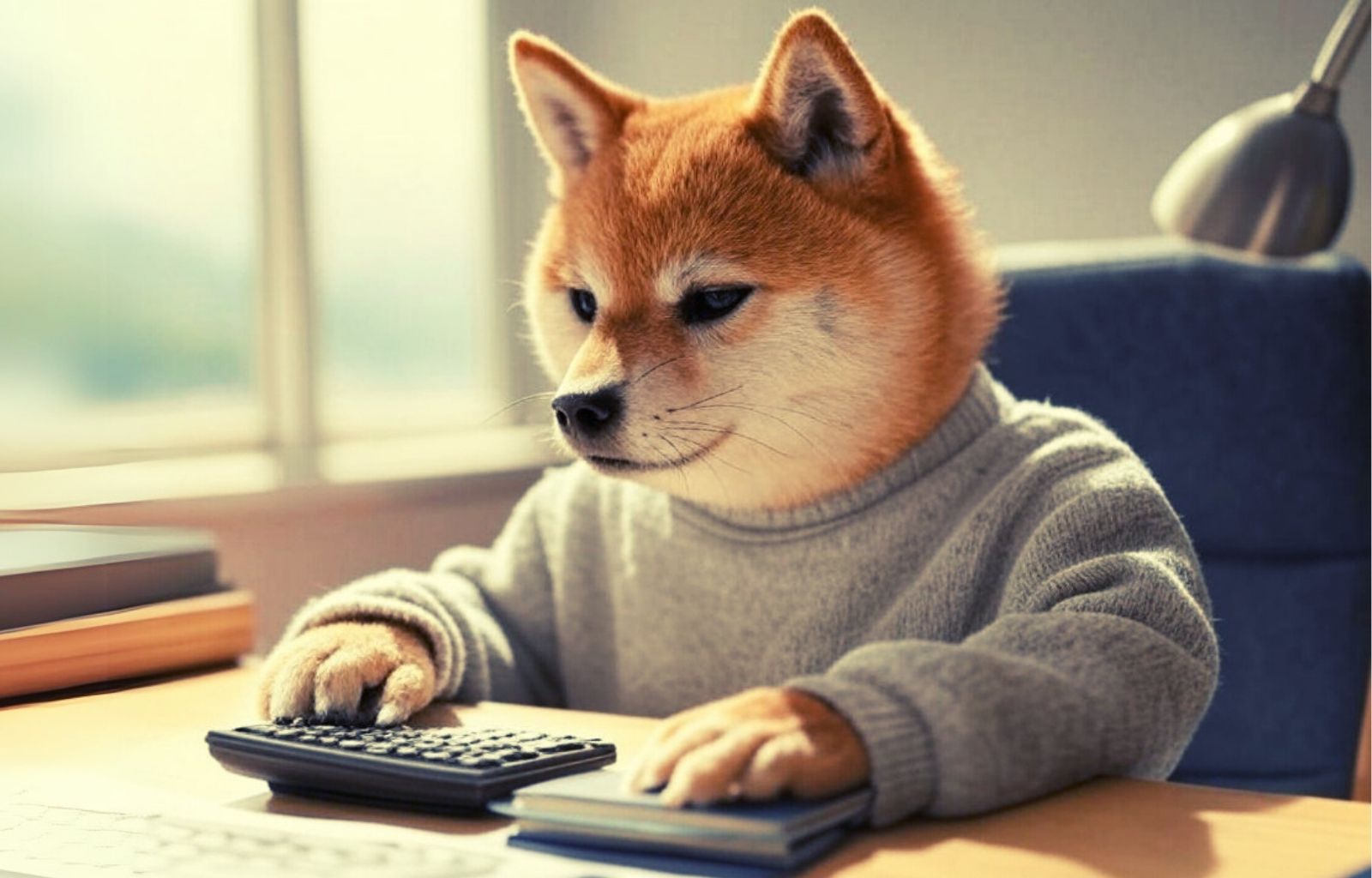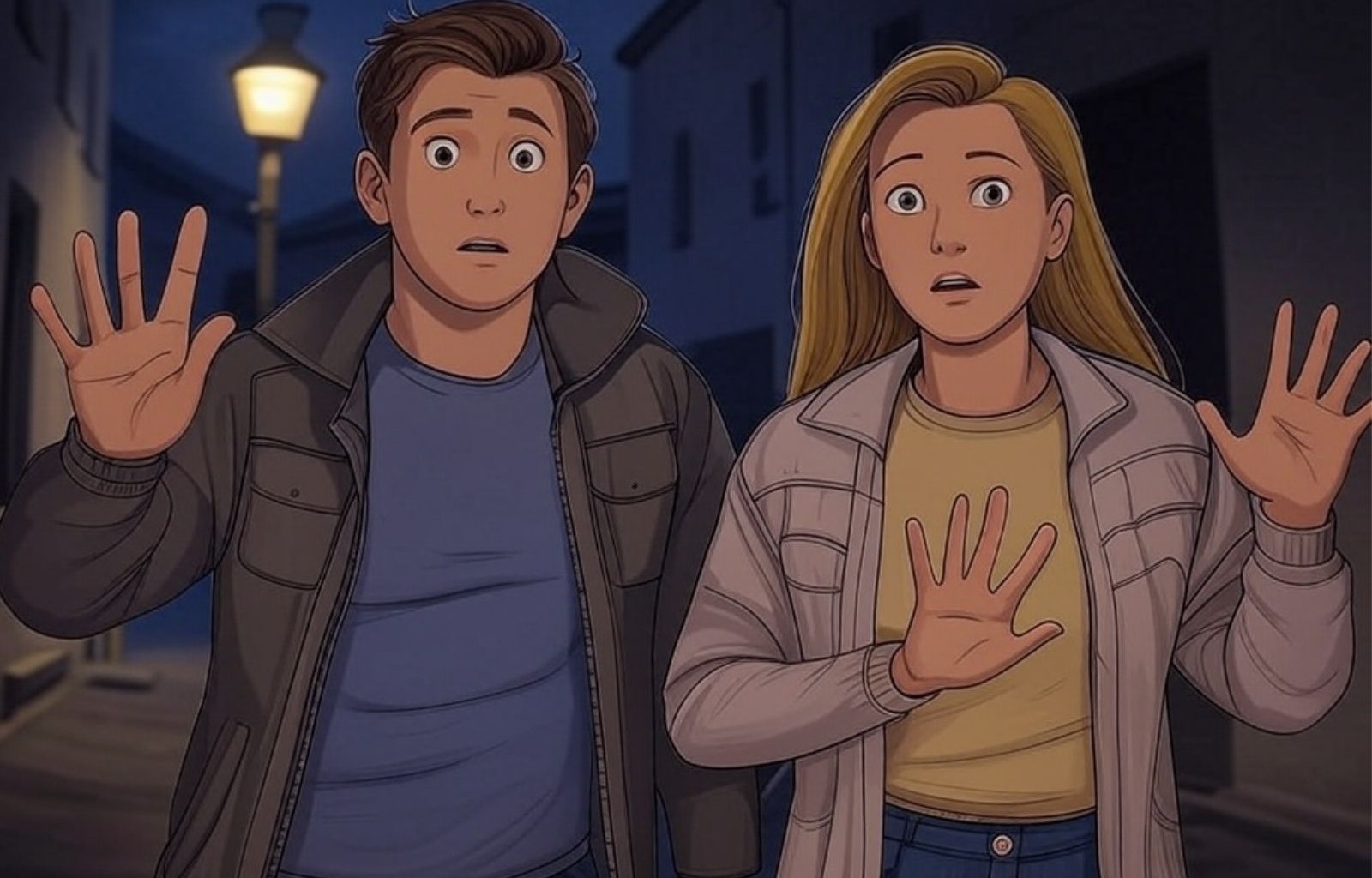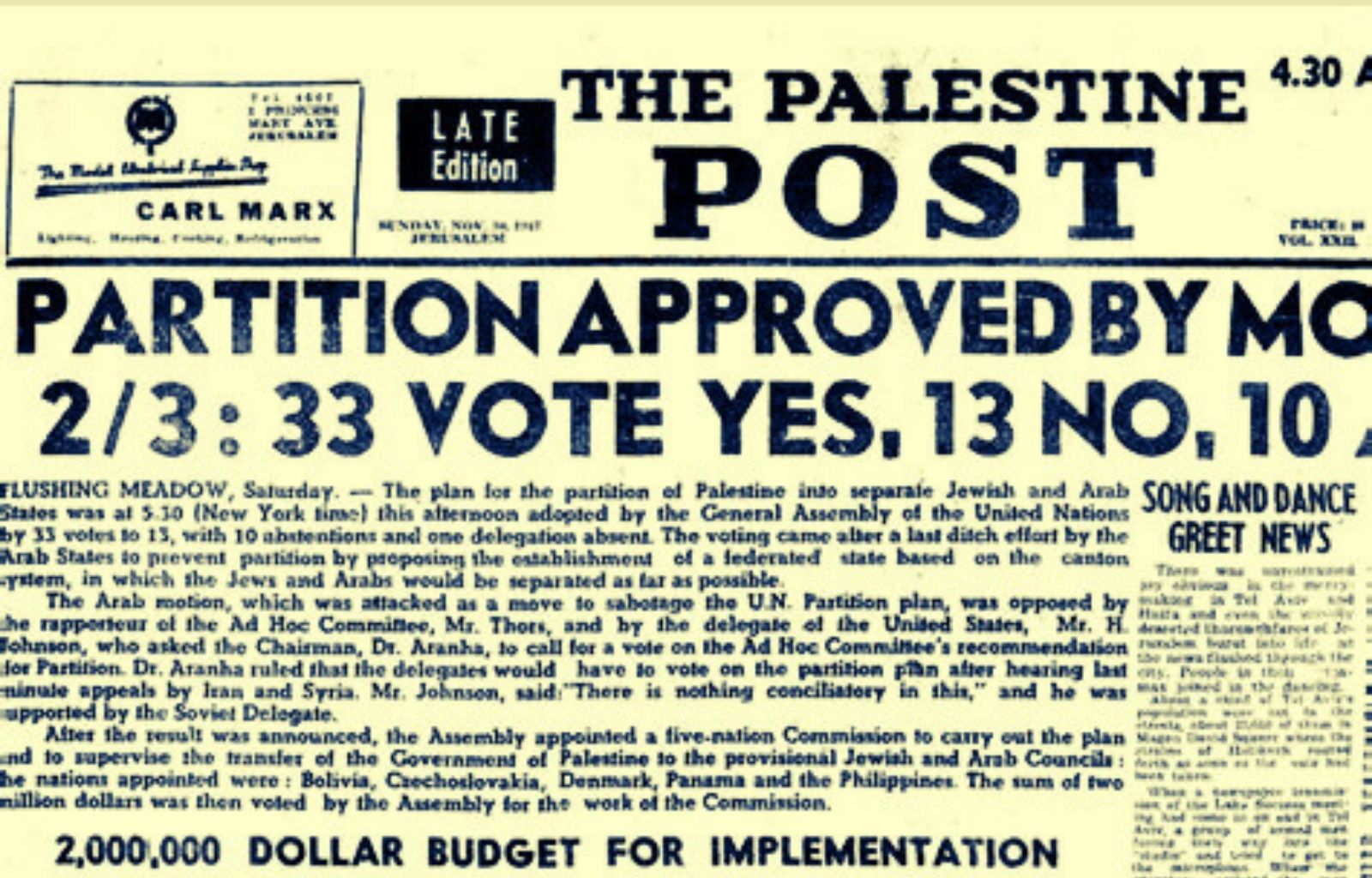Misure cautelari e Stato di diritto: una sfida per la giustizia italiana ed europea

Il dibattito sul processo penale e sulle misure cautelari in Italia non riguarda soltanto gli addetti ai lavori o il nostro ordinamento nazionale. Si inserisce infatti in una riflessione più ampia sullo Stato di diritto, che coinvolge l’intera Unione Europea. Le garanzie individuali, l’equilibrio tra sicurezza e libertà, l’effettività e l’imparzialità della giustizia sono temi che, oggi più che mai, definiscono la qualità democratica di un sistema. In un contesto europeo in cui il rispetto dei valori fondamentali sanciti dall’articolo 2 del Trattato sull’Unione Europea è oggetto di monitoraggio e discussione, anche le riforme interne ai sistemi giudiziari nazionali assumono rilievo sovranazionale. Le scelte procedurali e le garanzie applicate ante iudicium toccano, quindi, non solo il diritto interno, ma anche la credibilità del nostro Paese all’interno dello spazio giuridico europeo.
È da questo punto di vista che va letto il seguente contributo, che esplora alcuni nodi critici della disciplina cautelare e delle sue recenti evoluzioni italiane: un terreno delicato, dove la funzione sociale del processo penale si intreccia con i diritti fondamentali della persona.
Giustizia cautelare tra garanzie, rischi e riforme: un’analisi critica del sistema italiano
L’inquadramento valoriale e l’impostazione del procedimento cautelare rappresentano il termometro della “temperatura” del sistema prevalentemente accusatorio dell’ordinamento processuale. La privazione della libertà ante iudicium è uno strumento di sicurezza generale ma anche di preoccupazione sociale.
Il processo di cognizione passa in secondo piano rispetto alla sofferenza personale ed alla mediaticità di un provvedimento cautelare.
Il tema è “bollente” e dunque le modifiche alla disciplina cautelare diventano (come molti argomenti) un tema che spacca la società.
Da un anno circa il panorama delle opinioni si mescola di interpretazioni rispetto alla possibilità in sede di applicazione di una valutazione collegiale per le sole misure custodiali in carcere (e non come adesso: valuta il giudice competente funzionalmente, e quindi dipende dalla fase e dal grado in cui pende il procedimento), rispetto all’analisi delle esigenze cautelari e rispetto all’interrogatorio preventivo (prevenire è diverso da garantire).
Il collegio cautelare (tre membri) in sede di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è una garanzia di precisione o una deresponsabilizzazione dato il mancato obbligo di verbalizzazione delle singole posizioni e delle opinioni individuali dei giudici. Delle due, una.
Se aumentano “gli occhi” in prima istanza, aumentano anche i “visori” con i mezzi di impugnazione? A quanto pare la normativa delle impugnazioni non è stata rivisitata.
Lascia perplessa anche l’attribuzione di competenza in prima battuta al tribunale del riesame e per poi passare la devoluzione alla Corte d’appello dello stesso distretto.
La mancata composizione di un organo collegiale ex novo in prima “battuta” (e si lascia l’applicazione al tribunale del riesame) genera necessariamente l’esigenza di garantire l’impugnazione in Corte d’appello seguendo i criteri dell’art. 11 c.p.p. in modo da evitare l’emissione ed il primo grado cautelare attribuiti al medesimo ufficio giudiziario se pur in funzione diversa.
Genera un interrogativo importante la sperequazione in concreto sulle diverse modalità tra custodia in carcere e le altre misure personali e reali.
La gerarchia delle sofferenze, prima del processo di merito, nella nostra società capitalistica si ribaltano e di conseguenza un sequestro di beni potrebbe essere visto come più afflittivo (ad. esempio un conto di una società). Si è sicuri che il collegio va evitato per un sequestro?
L’interrogatorio di garanzia (tranne che per le esigenze di pericolo di fuga e per la tutela degli elementi di prova) viene anticipato con un metodo preventivo rispetto all’applicazione della misura.
Si dice che prevenire è meglio che curare, ma prevenire è meglio di garantire?
Si è sicuri, al netto della cautela ed al netto del termine di indagine, che questo tipo di interrogatorio possa realmente essere di garanzia e non diventare uno strumento di conoscenza troppo anticipato delle indagini al tal punto da pregiudicarle?
Il bilanciamento degli interessi in gioco, durante tutto il procedimento penale, è l’esercizio più complesso del giurista a presidio della funzione sociale del processo penale e dell’esercizio del diritto di difesa.
Una riflessione europea
Queste riflessioni sul sistema cautelare italiano non sono isolate, né indifferenti al contesto europeo. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte sottolineato come la custodia cautelare debba essere uno strumento eccezionale, giustificato da motivazioni concrete e proporzionate, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza sancito dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Anche la Commissione europea, attraverso il Rule of Law Report annuale, monitora con crescente attenzione le garanzie offerte dagli ordinamenti giudiziari nazionali in tema di diritti della difesa, imparzialità dei procedimenti e durata delle misure restrittive. L’Italia, come tutti gli Stati membri, è chiamata a dimostrare che le sue riforme processuali non compromettano l’equilibrio tra le esigenze investigative e la tutela delle libertà fondamentali.
In molti ordinamenti europei, del resto, esistono modelli di controllo più strutturati e multilivello per l’applicazione delle misure cautelari, che possono offrire spunti di confronto utili per il legislatore italiano. Ad esempio, in Germania e in Spagna, l’intervento del giudice è spesso incardinato in una procedura collegiale o comunque soggetta a revisione più articolata fin dalle prime fasi.
In conclusione, la disciplina della custodia cautelare non è una questione meramente tecnica, ma un indicatore cruciale della qualità democratica e giuridica di uno Stato di diritto. È su questo terreno che si misura non solo la solidità della nostra giustizia, ma anche la nostra credibilità come membri di una comunità politica fondata sulla tutela dei diritti e delle libertà: l’Unione Europea.