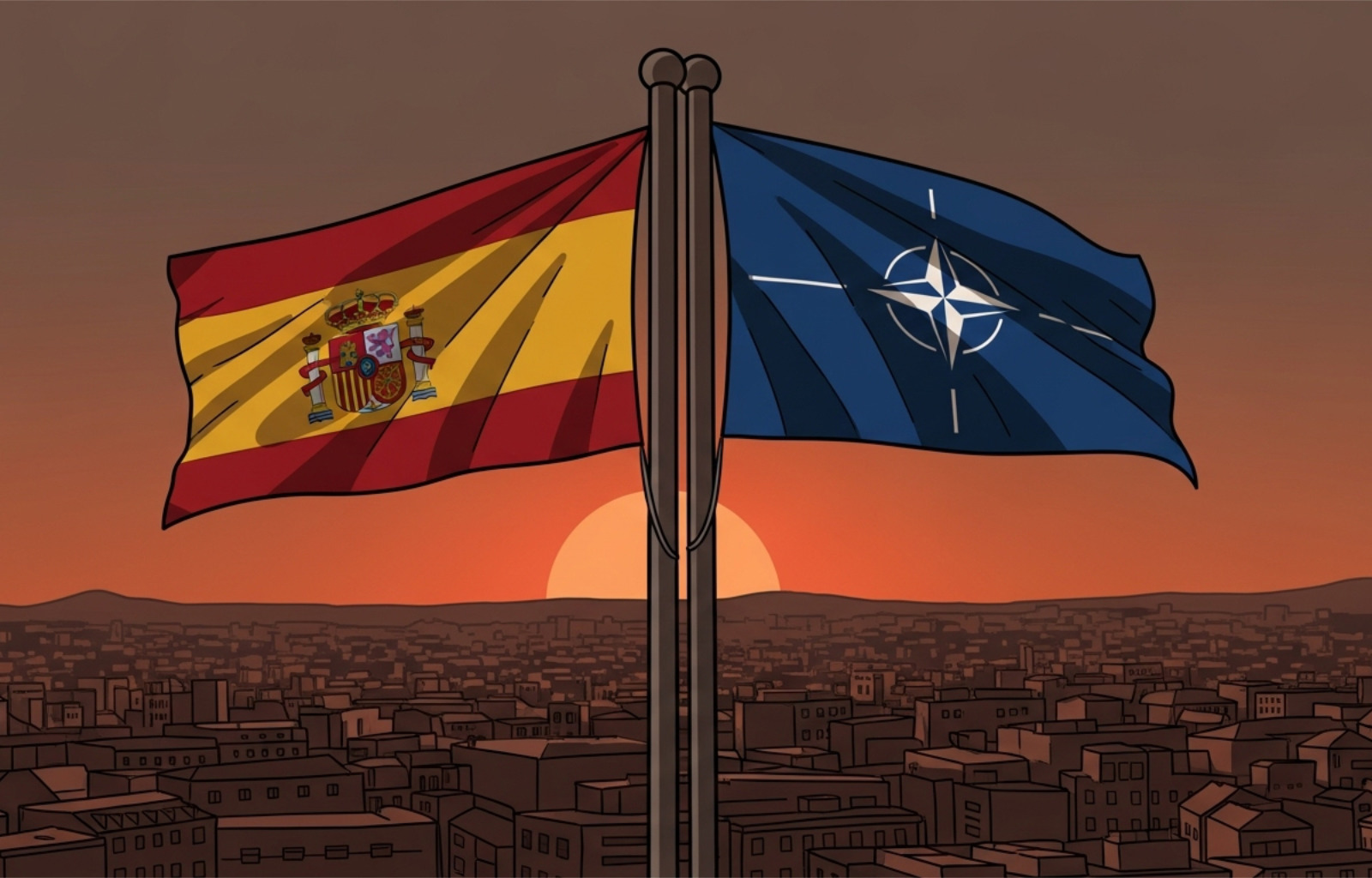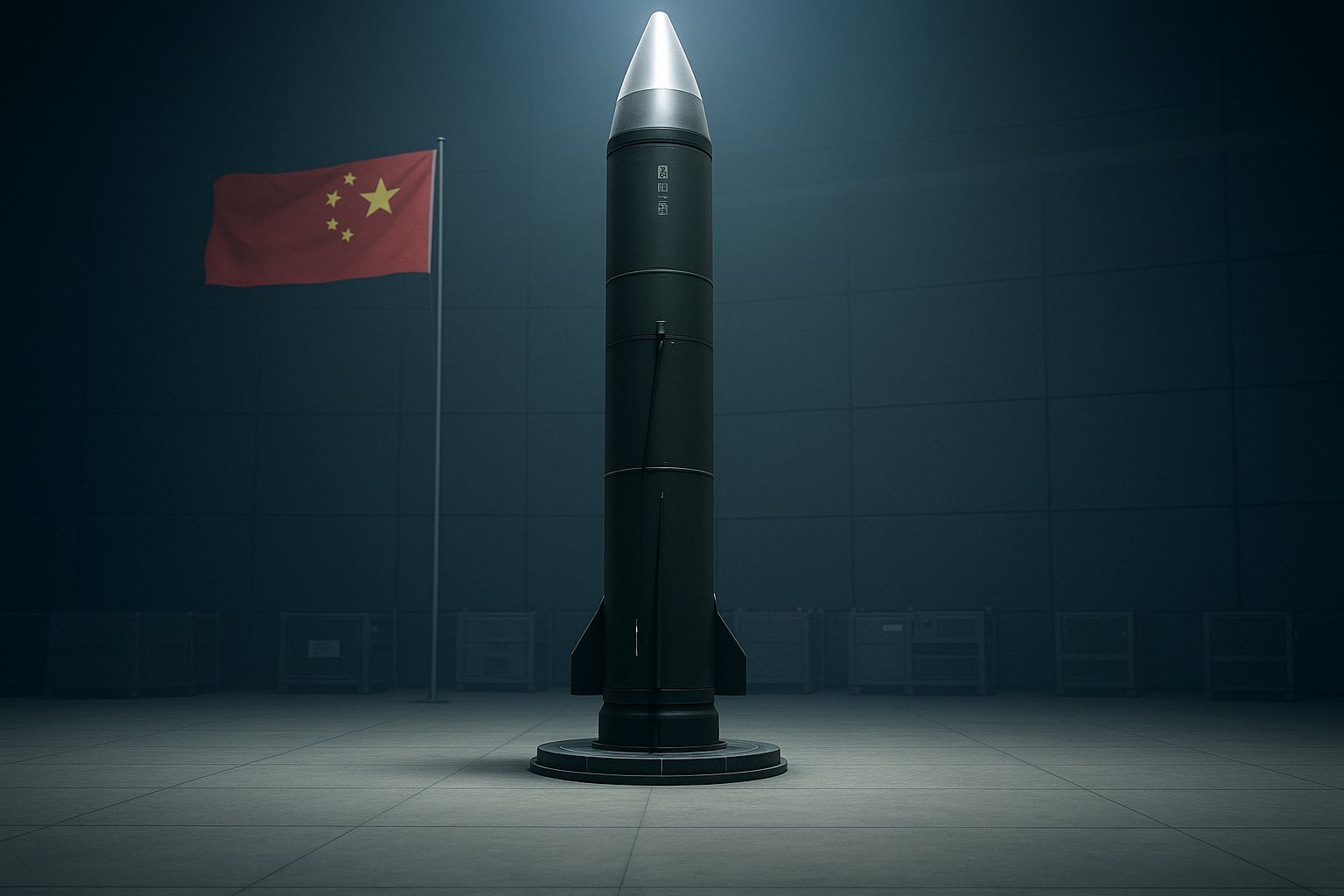Dopo la guerra dei 12 giorni: Israele, Iran, Stati Uniti e il teatro della deterrenza

Nel panorama mutevole delle relazioni internazionali, il conflitto tra Israele e Iran dell’estate 2025 ha rappresentato una cesura simbolica e operativa nel teatro mediorientale. Più che una vera guerra, si è trattato di una crisi ad alta densità comunicativa, dove l’azione militare è stata integrata e quasi subordinata alla costruzione di una narrazione strategica. Una guerra ibrida e spettacolare, non tanto per le armi impiegate ma per la sua capacità di condensare simboli, messaggi e percezioni in uno spazio temporale brevissimo: dodici giorni.
In questo contesto, l’intervento degli Stati Uniti, orchestrato da un Donald Trump al massimo della sua espressività comunicativa, ha evidenziato una mutazione profonda nelle forme della proiezione di potenza: la guerra non è più solo il prolungamento della politica con altri mezzi, ma una forma evoluta di comunicazione strategica, di teatro globale dove gli attori principali recitano ruoli calibrati per auditori multipli.
Israele ha cercato di ribadire la propria supremazia militare e di riaffermare la propria dottrina di pre-emption, nel timore che Teheran potesse superare la soglia critica dell’arricchimento dell’uranio. L’Iran, da parte sua, ha dovuto dimostrare di saper rispondere, pur mantenendo il controllo della propria vulnerabilità interna. Gli Stati Uniti, infine, hanno risposto all’ennesima chiamata di Tel Aviv, tentando però di limitare l’escalation e mantenere un equilibrio tra deterrenza e disimpegno.
La “guerra dei 12 giorni” è stata quindi molto più di una semplice fiammata bellica: è stata un esperimento di gestione simbolica della forza, un banco di prova per una nuova grammatica geopolitica in cui la performance conta quanto – se non più – dell’effetto militare reale. Il seguente articolo si propone di analizzare le dinamiche di questo conflitto attraverso due lenti principali: da un lato, le strategie di Israele e la tenuta della sua logica pre-emptive; dall’altro, il modello trumpiano di diplomazia teatrale, fra comunicazione iperpersonalizzata e deterrenza coreografica.
I calcoli di Israele e l’effetto boomerang della pre-emption
La dottrina israeliana della pre-emption strategica – concepita per neutralizzare minacce esistenziali prima che diventino operative – è uno dei cardini storici della sicurezza nazionale dello Stato ebraico. Tale principio, ereditato da operazioni iconiche come l’attacco al reattore nucleare iracheno Osirak nel 1981 e al sito siriano di Deir ez-Zor nel 2007, è stato applicato nuovamente nell’offensiva del giugno 2025 contro l’Iran. La convinzione operativa del governo Netanyahu era chiara: la Repubblica Islamica stava attraversando la “zona grigia” che separa un programma nucleare civile da uno militare, e la soglia del breakout – la capacità tecnica di costruire un ordigno nucleare nel giro di poche settimane – si stava avvicinando pericolosamente.
In quest’ottica, i raid aerei su siti chiave come Isfahan, Natanz e Parchin hanno avuto una funzione eminentemente deterrente, non distruttiva. L’intento non era solo fisico – ovvero danneggiare infrastrutture sensibili – ma anche psicologico e strategico: riaffermare la superiorità operativa israeliana, dimostrare la penetrazione della propria intelligence nei meccanismi interni iraniani, e lanciare un messaggio chiaro a Teheran e agli attori regionali. Tuttavia, questa operazione si è scontrata con una realtà operativa più complessa.
Secondo valutazioni dell’intelligence statunitense, condivise informalmente con partner NATO e filtrate sulla stampa internazionale, l’efficacia degli attacchi è risultata operativamente contenuta. In particolare, sono stati identificati movimenti di materiali nucleari nelle ore precedenti ai bombardamenti, che hanno portato alla sparizione di circa 400 kg di uranio arricchito al 60%. La tempistica e la logistica del trasferimento fanno sospettare un preavviso ricevuto tramite canali diplomatici indiretti o un’intelligence preventiva particolarmente acuta da parte iraniana.
Dal punto di vista difensivo, Israele ha dimostrato una capacità di intercettazione superiore al 90% nei confronti dei missili iraniani – un dato che riflette l’efficacia della combinazione Iron Dome, David’s Sling e Arrow 3, ma che solleva interrogativi sulla sostenibilità a lungo termine di un tale ritmo operativo in caso di conflitto prolungato. Le forze armate israeliane hanno operato con prontezza, ma la pressione su riserve logistiche, catena di comando e supporto politico interno rischia di diventare insostenibile in scenari futuri di escalation.
A livello sistemico, il dividendo strategico per Israele risulta dunque ambiguo. Se da un lato la capacità di colpire con precisione chirurgica è stata confermata, dall’altro la reazione iraniana ha attivato dinamiche destabilizzanti: la sospensione della cooperazione con l’AIEA, la possibile uscita dal Trattato di non proliferazione nucleare (TNP) e una rinnovata legittimità interna al programma nucleare militare come forma di deterrenza “finale”.
L’effetto boomerang della pre-emption è, in questo senso, tanto politico quanto strategico: l’azione militare non ha disinnescato la minaccia, ma l’ha ridefinita, intensificando la corsa iraniana alla soglia critica e mettendo a nudo i limiti di un approccio preventivo non supportato da una cornice diplomatica credibile e multilaterale.
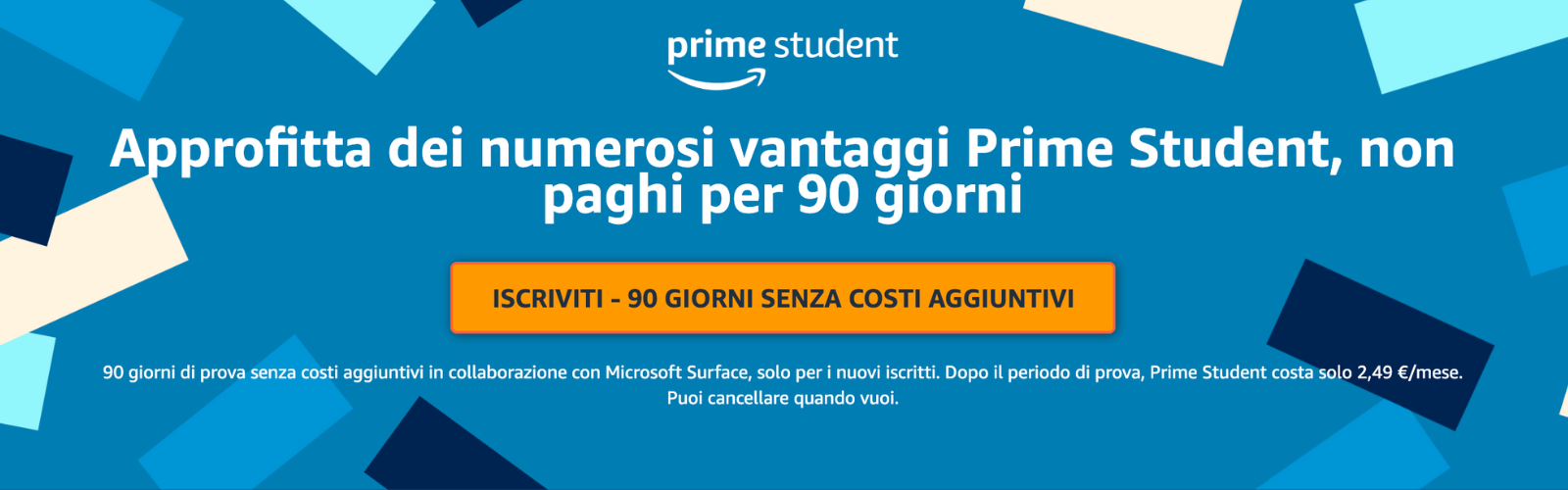
Trump e la nuova arte della guerra teatrale
La risposta statunitense al conflitto israelo-iraniano ha rivelato una grammatica bellica radicalmente nuova, fortemente influenzata dalla personalità e dallo stile comunicativo del presidente Donald Trump. L’attacco aereo ai siti di Fordow, Natanz e Isfahan, formalmente concepito come operazione di precisione contro obiettivi nucleari, si è in realtà configurato come un esempio sofisticato di escalation concordata. La diplomazia performativa americana ha seguito un copione coerente: fornire preavviso a Teheran, consentire lo sgombero dei siti strategici, lanciare l’attacco, e infine dichiarare vittoria.
L’operazione ha beneficiato di canali di comunicazione riservati — Oman, Qatar, e indirettamente la Svizzera — per sincronizzare le fasi del confronto. Così, l’Iran ha potuto avvisare Doha del lancio dei suoi 19 missili verso la base USA di al-Udeid, e Doha ha trasmesso il messaggio a Washington: la base è stata evacuata, i missili intercettati, i danni nulli. Un’aggressione simbolica, calibrata a rientrare nella categoria del “colpo dimostrativo”.
In parallelo, Trump ha condotto un’abile regia narrativa: uscito dalla Situation Room, ha chiamato Netanyahu per imporre lo stop ai bombardamenti e ha inviato il negoziatore Steve Witkoff a contattare il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. Il giorno seguente, ha annunciato il cessate il fuoco via Truth, dichiarando la fine della guerra e autoproclamandosi garante della stabilità regionale.
Questo modus operandi incarna pienamente i dettami del suo celebre volume “The Art of the Deal”: la negoziazione non è solo una questione di contenuto, ma di narrazione, di frame e di percezione del potere. Trump ha applicato alla politica estera la logica del brand: colpire duramente, amplificare il gesto, incassare il dividendo mediatico e dichiarare vittoria. La guerra, in questa cornice, si trasforma in una performance mediatica a beneficio della base elettorale e degli interlocutori internazionali.
Tuttavia, questo approccio produce conseguenze paradossali. La spettacolarizzazione della guerra, e soprattutto il fatto che se ne siano rese palesi le coordinate simboliche — con avvisi preventivi, attacchi evacuati, missili intercettati — rischia di intaccare proprio ciò che intende rafforzare: la deterrenza. In un ambiente geopolitico come quello mediorientale, dove la percezione della credibilità della minaccia è decisiva, rivelare che lo scontro è stato in gran parte messo in scena riduce l’efficacia intimidatoria delle future proiezioni di forza.
L’arte di Trump è dunque un’arte teatrale ma anche iper-trasparente, e questa trasparenza strategica è una lama a doppio taglio. Da un lato consente a ogni attore di salvare la faccia; dall’altro, espone la dimensione di fiction della diplomazia muscolare, lasciando intendere che le regole del gioco sono note, condivise e, quindi, manipolabili.
Questa dinamica ricorda i codici di comportamento delle superpotenze nella Guerra Fredda, ma li reinterpreta in chiave populista e ipermediata. La differenza è che la gestione della crisi non mira a stabilizzare un ordine, bensì a rafforzare la centralità narrativa di chi ne orchestra la sequenza. Trump non vuole negoziare una pace duratura: vuole monopolizzare il racconto della pace, anche
Conclusione
La “guerra dei 12 giorni” tra Israele, Iran e Stati Uniti ha mostrato il volto di un nuovo paradigma operativo: la guerra come performance, la diplomazia come improvvisazione registica, la strategia come comunicazione personalistica. In questo modello, ogni attore recita una parte per pubblici differenti: Israele per i suoi elettori securitari, l’Iran per il suo apparato religioso-militare, Trump per il suo zoccolo elettorale interno.
Tutti hanno dichiarato vittoria. Netanyahu ha rivendicato il successo militare; Khamenei ha mostrato resistenza e compattezza; Trump ha monopolizzato la narrativa con il consueto stile iperbolico. Ma sul piano strutturale, nessuno ha davvero vinto: il programma nucleare iraniano resta attivo, la deterrenza israeliana è esposta a nuove sfide, e gli Stati Uniti rischiano di rimanere invischiati in un quadrante che volevano abbandonare.
La “grande illusione” è che basti un attacco calibrato e un cessate il fuoco improvvisato per stabilizzare una regione in ebollizione. Ma il Medio Oriente 2025 è tutto fuorché stabile: è un campo di tensioni post-imperiali, connesso a dinamiche globali che vanno dal contenimento della Cina alla gestione delle risorse energetiche. Ogni intervento americano nel teatro mediorientale è una distrazione strategica dalla partita indo-pacifica, e ogni rinvio della questione nucleare iraniana è un debito strategico che prima o poi dovrà essere saldato.
In sintesi, la guerra dei 12 giorni è stata una pausa tra due crisi, non una soluzione. Un affresco sofisticato di leadership post-strategica, dove la sostanza cede spesso il passo alla messa in scena. Ma le sabbie del Golfo sanno soffocare anche i più abili illusionisti. La geopolitica, quella vera, non perdona mai le scorciatoie narrative.