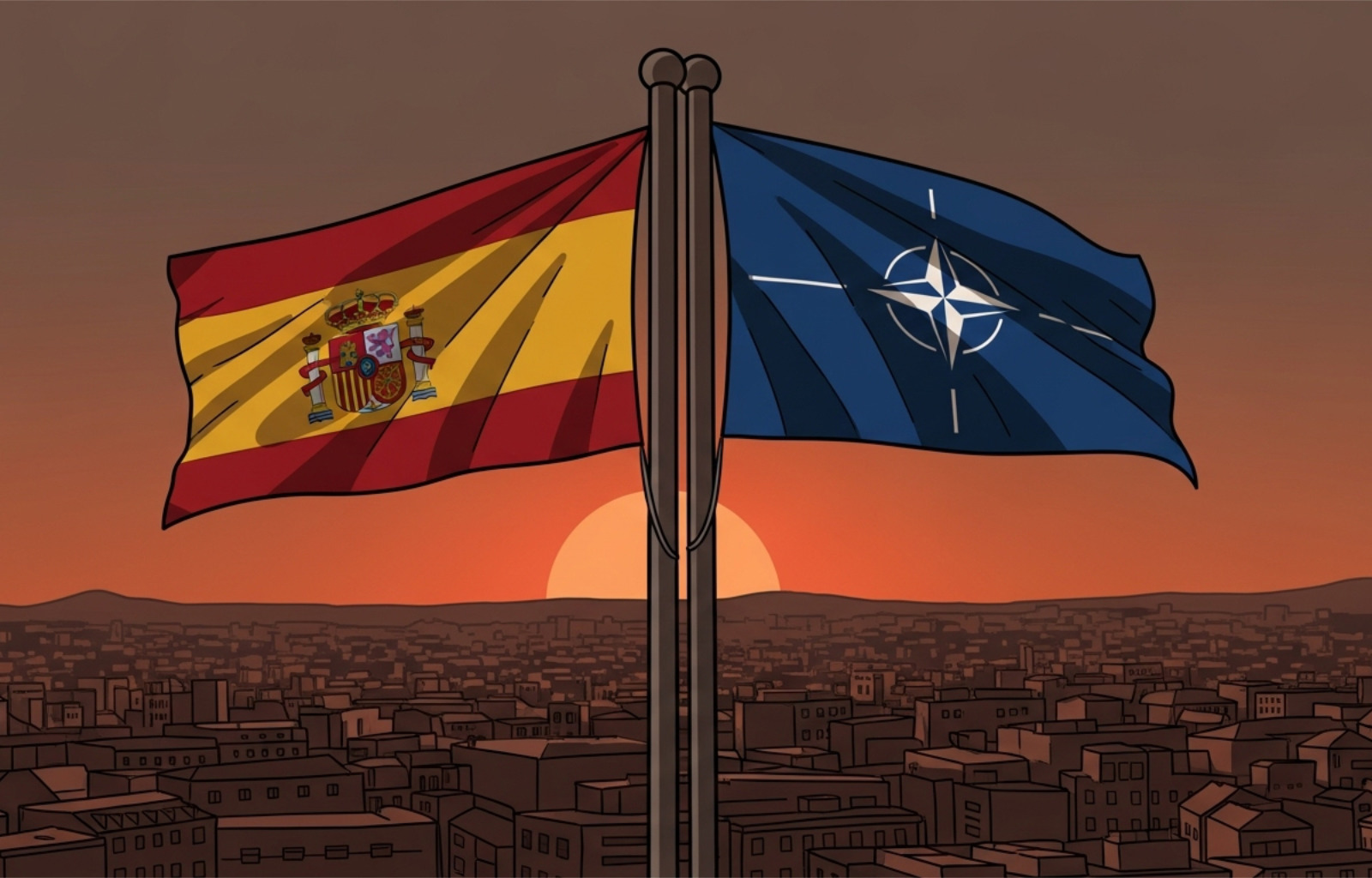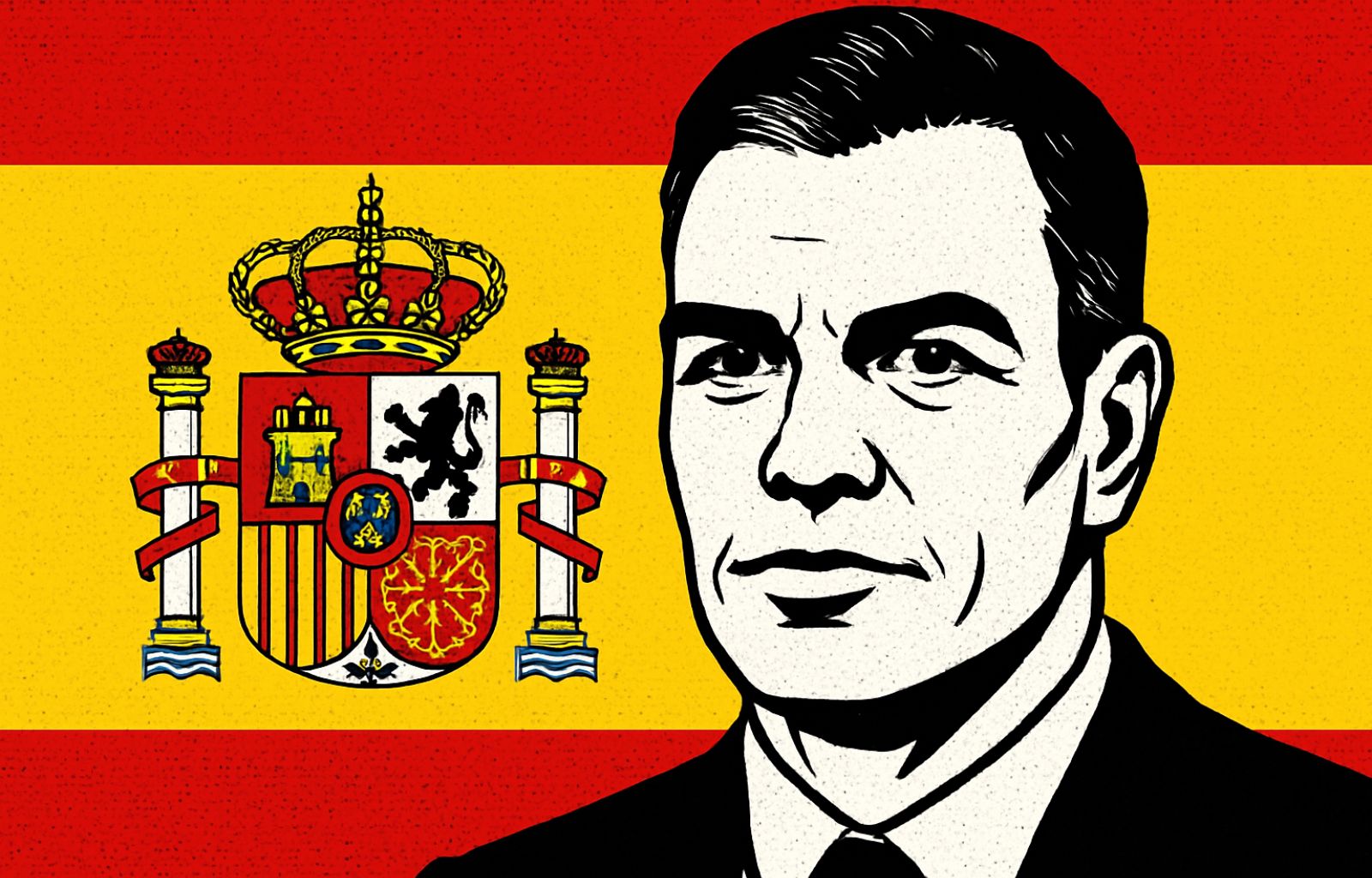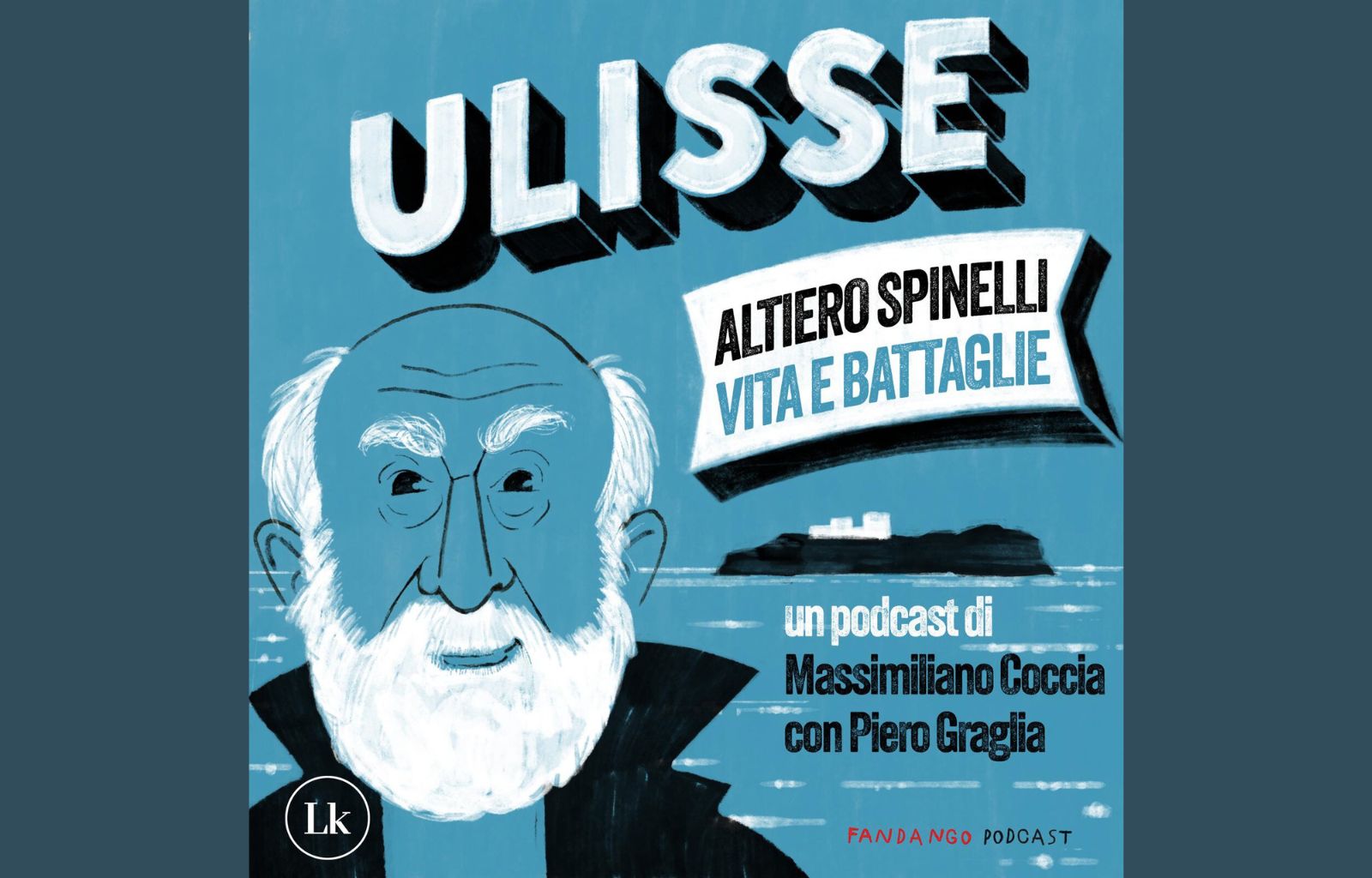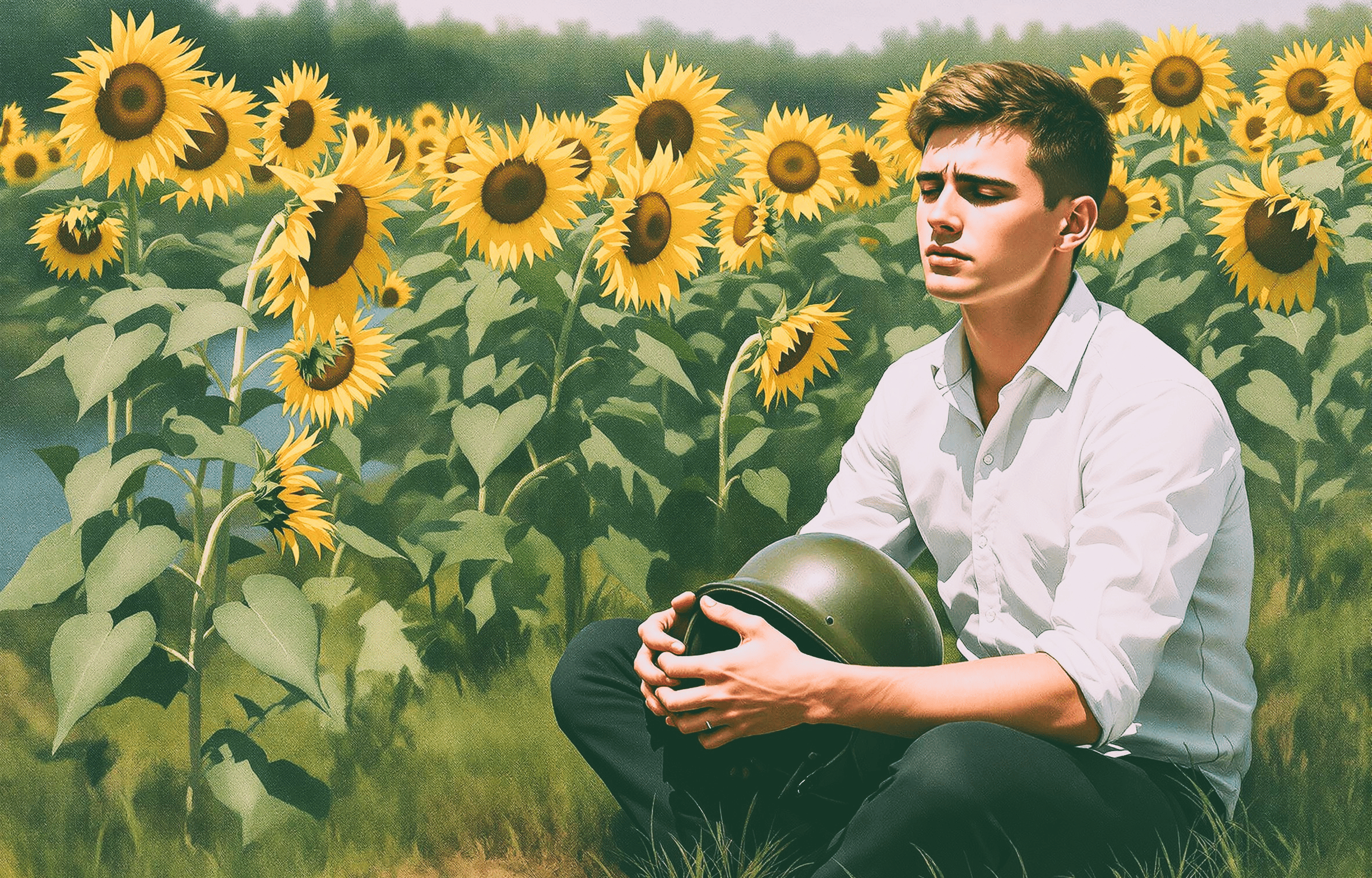Come è finita la corona della Madonna dentro la bandiera europea?

La corona di dodici stelle viene descritta per la prima volta in una delle visioni dell’Apocalisse, il libro che conclude la Bibbia cristiana rivelando cosa dovrebbe accadere alla fine del tempo.
La indossa una donna “vestita di sole” e “con la luna sotto i piedi”, che dà alla luce un bambino “destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro”. Dopo il parto, la donna deve affrontare l’assalto di un drago.
Affreschi con questa visione dell’Apocalisse erano molto diffusi già nel tardo Medioevo, ma è nella prima modernità che la donna coronata di stelle ha cominciato ad essere identificata stabilmente con Maria nell’immaginario popolare.
La Vergine è stata dipinta con le dodici stelle dai più celebrati pittori del Barocco, tra cui Rubens, Guido Reni e Velazquez. Innumerevoli statue devozionali in quasi ogni parrocchia d’Europa la ritraggono con questo ornamento.
I romani sono abituati a vederla dal 1615 in cima alla colonna di piazza s. Maria Maggiore e dal 1857 in cima alla colonna di piazza di Spagna, mentre i milanesi la vedono svettare dal 1769 sulla guglia più alta del Duomo. Quanto ai napoletani, conoscono bene la Madonna di Pompei, anche lei con l’immancabile corona.
Il perché di questa scelta si intuisce. Da un lato i protestanti avevano messo in discussione il culto della Vergine, accusandolo di essere una superstizione pagana: perciò i cattolici, per tutta risposta, esaltarono ancora di più la regalità celeste di Maria rivestendola dei possenti simboli dell’Apocalisse.
Dall’altro lato, i regni cristiani europei erano sopravvissuti all’aggressione dei turchi e dei loro alleati minori con alcune epocali vittorie difensive, prima fra tutte quella di Lepanto (7 ottobre 1571, a tutt’oggi la più grande battaglia navale della storia per numero di navi e di uomini).
Papa Pio V attribuì la vittoria all’intervento miracoloso della Madonna del Rosario, che da allora venne festeggiata il 7 ottobre e venne raffigurata sempre più spesso incoronata con le dodici stelle.
Più tardi, nell’Europa centrale, i sovrani polacchi ritualizzarono l’incoronazione con le dodici stelle dell’icona di Częstochowa, alla quale davano il merito del loro trionfo storico sui turchi (avvenuto l’11 settembre 1683 a Vienna).
In tempi più recenti, i polacchi hanno attribuito alla stessa icona la vittoria contro l’armata rossa di Trotzkij nel giorno dell’Assunta del 1920: una battaglia poco conosciuta ma decisiva, che impedì al comunismo sovietico di dilagare nel vecchio continente stremato dalla guerra.
Insomma: la diffusione dell’immagine di Maria con le dodici stelle ha avuto un’accelerazione ogni volta che qualcuno ha sentito che la civiltà europea, presa nel suo insieme, aveva superato un pericolo esistenziale.

L’icona di Częstochowa con le corone apposte
Dodici stelle in milioni di tasche
Non fa eccezione, almeno dal punto di vista dei suoi protagonisti, la vicenda della “medaglia miracolosa” di rue de Bac.
La Vergine avrebbe iniziato ad apparire alla giovane suora Catherine Labouré nel luglio del 1830, lo stesso mese in cui una fortunata rivoluzione trasformò la Francia in una monarchia costituzionale ponendo bruscamente fine alla Restaurazione cattolica. Il terrore di un nuovo sterminio come quello degli anni di Robespierre doveva essere palpabile tra i credenti.
Come sappiamo non avvenne nulla del genere, ma ormai le apparizioni c’erano state, la medaglia che le commemorava venne presto coniata e la sua enorme circolazione assicurò definitivamente la popolarità della Madonna con le dodici stelle.
Se sono affidabili le stime per cui ne è stato coniato oltre un miliardo di esemplari già solo durante la vita di Catherine Labouré, le persone che hanno visto le dodici stelle sul bordo di quella medaglia potrebbero essere numerose quanto quelle che le hanno viste sul retro di una moneta da un euro.
Ecco perché, se a metà del ‘900 avessimo chiesto a una qualsiasi delle nostre nonne e bisnonne: “A che cosa ti fa pensare una corona di dodici stelle?”, la risposta più probabile sarebbe stata: “Alla Madonna”.
Molte di loro, magari, davanti a un’immagine di Maria coronata di stelle, avevano pianto, pregato, fatto voti per ciò che avevano di più caro, cercato risposte e trovato la forza per aiutare persone sofferenti, tanto più in anni terribili come quelli delle guerre mondiali. Chiamare tutto questo “superstizione pagana” con aria sussiegosa non ne annulla necessariamente il valore.
Ed era questo l’immaginario nel quale erano immersi il grafico Arsène Heitz e buona parte dei suoi conoscenti quando venne bandito il concorso per scegliere una bandiera europea.

Fronte e retro della “medaglia miracolosa” di Rue de Bac
La bandiera
Ci sono diverse ipotesi su dove Heitz abbia preso l’idea per la bandiera con le dodici stelle.
Che fosse devoto alla “medaglia miracolosa” lo rivelò lui stesso in un’intervista, successiva però alla nascita della bandiera e quindi non del tutto affidabile.
Qualcuno sostiene che possa essersi ispirato a una vetrata in una chiesa di Strasburgo. Altri hanno visto un richiamo alla sontuosa volta di palazzo Barberini, affrescata da Pietro da Cortona, dove nel 1950 era stata firmata la Carta Europea dei diritti umani.
A quel tempo, a dire la verità, il progetto europeista non se la passava bene. Nel 1954 erano state bocciate la Comunità Europea della Difesa e la Comunità Politica Europea: restavano un accordo commerciale sul carbone e sull’acciaio, che vincolava sei paesi, e un blando Consiglio d’Europa senza alcun potere decisionale, esteso a una quindicina di paesi. Era proprio quest’ultimo che la bandiera avrebbe dovuto rappresentare.
La giuria presieduta da Paul Lévy dovette scegliere tra dozzine di bozzetti con i simboli più svariati: dalle croci alle rose dei venti, dal sole agli scudi, da una grande “E” agli anelli di una catena, fino alle più classiche bande orizzontali. Solo con le stelle ce n’erano 15 modelli.
Arrivarono in finale due bandiere con le stelle su sfondo blu.
Quella che le disponeva in una corona sembrava la più bella ed efficace, ma sul loro numero la giuria non si riusciva ad accordare.
Dal 14 in su avrebbe rischiato di coincidere col numero di stati dell’Europa, scatenando interminabili litigi su quali stati andassero riconosciuti e quali no. Il 13, a parere degli italiani, portava sfortuna.
La versione con dodici stelle, invece, non sollevò alcuna obiezione. Tutti i membri della giuria, a quanto pare, ci si trovavano a proprio agio.
Nel candidare il suo simbolo, Heitz ne aveva illustrato il significato con riferimenti vaghi e generici: a suo dire, il 12 avrebbe rimandato alle costellazioni dello zodiaco e quindi alla perfezione, alla completezza e all’unità tra i popoli.
È fin troppo scontato notare che le stesse virtù avrebbero potuto venire espresse altrettanto bene da altri numeri, come il 10 (numero perfetto e sacro per la tradizione pitagorica, alla quale si deve l’abitudine europea di contare in base dieci), l’8 (che nel Medioevo aveva ispirato infinite costruzioni ottagonali come simboli della totalità cosmica) o il classicissimo 3. La numerologia è un’arte piuttosto flessibile e può fornire più o meno qualunque significato a qualunque cifra.
La dotta poesia pagana dell’età ellenistica, ad esempio, aveva narrato di come Bacco, nel rendere immortale Arianna, avesse lanciato in cielo la sua corona trasformandola in una costellazione con nove astri.
Infine, perché non l’1? (La bandiera blu con un’unica stella, peraltro, era stata tra quelle in gara, ed era stata scartata con la scusa che era troppo simile a quella del Congo).
È innegabile, insomma, che fra tante combinazioni proprio la corona con dodici stelle facesse risuonare qualcosa di familiare nei membri della giuria – persone, lo ricordiamo, nate quasi tutte a fine ‘800 in paesi cristiani.
Questo potrebbe anche spiegare la bizzarra coincidenza per cui la risoluzione ufficiale sulla bandiera, che avrebbe potuto essere approvata il 7 dicembre 1955 nel primo giorno della seduta del Consiglio d’Europa (la scelta era già stata fatta due settimane prima), venne invece ritardata all’8, il giorno dell’Immacolata.
La blogosfera cattolica tradizionalista lo ritiene un evento accidentale voluto dall’alto per dare un segno divino: noi, con scettica umiltà, preferiamo immaginare che sia stato fatto apposta da alcuni dei signori lì presenti per dare un segno molto umano.

La vetrata che il grafico A. Heitz avrebbe visto a Strasburgo nella chiesa di Nostra Signora della Pace.
Le origini ebraiche del simbolo
Ma chi era davvero la donna coronata di stelle che partoriva il Messia e affrontava il drago, nelle intenzioni dell’autore dell’Apocalisse?
Dalla fine dell’800 se ne sono occupati i filologi che hanno studiato i testi biblici secondo il metodo storico-critico. E l’ipotesi più accreditata è che la madre del Messia, come anche le altre due donne descritte nel libro (la Prostituta e la Sposa), rappresentasse il popolo ebraico.
I grandi profeti come Isaia ed Ezechiele, infatti, avevano spesso descritto Israele come una donna e il suo rapporto con Jahvé come una storia d’amore. In Ezechiele, addirittura, Jahvé dice alla donna amata: “Posi una splendida corona sul tuo capo”.
Quanto al numero 12, richiama i figli di Israele in tutta l’Apocalisse, come anche nei Vangeli: dodici sono gli apostoli, dodici sono le ceste di avanzi dopo la moltiplicazione dei pani, dodici sono le porte di gemme della città celeste, 144.000 (12×12 migliaia) sono i beati di origine ebraica.
Così, quella che la devozione popolare e la “Lepanto-mania” trasformarono in un’insegna della Madonna era nata, con ogni probabilità, come emblema del popolo scelto da Dio, e dunque aveva avuto un valore politico, oltre che religioso, fin dal suo principio.
Il pasticcio di Tajani
Di questa storia affascinante, ben documentata in ogni suo passaggio e oggetto di studi rigorosi, il nostro ministro degli esteri Antonio Tajani ha evidentemente percepito solo qualche stralcio confuso col passaparola.
Così, qualche giorno fa, ha pubblicato un tweet imbarazzante in cui esaltava la bandiera europea “blu come il manto della Madonna con le dodici stelle delle tribù d’Israele disposte in cerchio”.
Un’affermazione sconclusionata che non sta né in cielo né in terra e che, anche se fatta in buona fede, stride col suo ruolo istituzionale.
Un conto è riconoscere la continuità tra un millenario e amatissimo simbolo cristiano (che è la corona, non il colore blu) e la bandiera dell’esangue Europa postmoderna. Un conto è riconoscere che quel millenario e amatissimo simbolo cristiano aveva, come ogni altro, delle origini ebraiche poi cadute nell’oblio.
Ma lasciar intendere che l’araldica ufficiale della bandiera europea consista nel manto della Madonna e nelle tribù di Israele è un’insensatezza.
Certo, peggio ancora del tweet di Tajani sono stati i tweet dei detrattori di Tajani, dei fact-checker improvvisati che hanno messo toppe peggiori del buco e mostrato un’ignoranza maggiore della sua.
Suvvia: davvero nel 2025 c’è ancora chi reagisce con fastidio, con disprezzo o con odio all’idea che il simbolo dell’Europa attuale provenga dalla civiltà cristiana (come pressoché qualunque cosa dell’Europa attuale, a partire dallo stato laico)?
Se la risposta è sì, non ci resta che dispiacerci per loro e augurargli una rapida e lieta uscita dall’adolescenza.