Capire i due giganti: Cina e India specchi divergenti della potenza asiatica

Nel mondo multipolare del XXI secolo, l’asse indo-pacifico si è trasformato da semplice orizzonte geoeconomico a cuore pulsante delle tensioni globali. In questo scenario, Cina e India occupano posizioni antitetiche ma inevitabilmente complementari: la prima si presenta come potenza strutturata, che punta a rimodellare l’ordine internazionale in chiave sinocentrica; la seconda come superpotenza demografica in costruzione, incerta tra ambizione regionale e velleità globale.
Entrambe pretendono un ruolo da protagoniste, ma lo fanno con approcci profondamente diversi: la Cina agisce da sistema, ambiziosa e ordinatrice; l’India si muove da attore fluido, oscillando tra cooperazione e sovranismo, tra rivendicazione identitaria e incertezza strutturale.
Dove Pechino propone modelli e infrastrutture, Nuova Delhi cerca alleanze e visibilità. Dove la Cina punta a riscrivere le regole, l’India cerca ancora un posto al tavolo.
Questo confronto – economico, politico, simbolico – non riguarda solo l’Asia, ma interroga direttamente l’Occidente. Perché se Washington vede in Pechino il vero rivale sistemico, l’Europa si trova di fronte a un dilemma strategico: quale ruolo giocare in questo equilibrio instabile? Appoggiarsi ciecamente agli Stati Uniti o costruire una propria traiettoria tra le due potenze emergenti?
In questa partita, la comunicazione non è dettaglio ma leva di potere. La Cina si proietta come architettura globale; l’India si guarda allo specchio e racconta la propria ascesa come destino. Capire queste differenze non è solo utile: è necessario per orientarsi in una geopolitica fatta sempre più di parole, immagini e narrazioni in competizione.
Cina, la potenza che pretende di essere vista
La Cina è oggi l’unica potenza non occidentale ad avere una visione strategica coerente, a lungo termine e articolata su scala globale. La Repubblica Popolare si propone come alternativa sistemica agli Stati Uniti non solo per capacità economica o forza militare, ma per la propria capacità di strutturare alleanze, regole, infrastrutture e narrative parallele a quelle occidentali. La sua influenza non è più quella di una potenza emergente: è una potenza consolidata che si comporta da architrave di un ordine diverso.
Sul piano economico, la Cina rimane la seconda economia mondiale in termini di PIL nominale, ma ha già superato gli Stati Uniti in parità di potere d’acquisto (PPP). I dati del 2024 evidenziano una crescita rallentata, ma costante, attorno al 4,6%, accompagnata da un’espansione delle esportazioni high-tech e dal consolidamento del renminbi nei sistemi di pagamento internazionali (con una crescita dell’utilizzo del 2,3% nel commercio globale, secondo dati SWIFT). Le tensioni commerciali con Washington hanno accelerato il processo di autarchia tecnologica, con massicci investimenti statali nei semiconduttori, nell’intelligenza artificiale e nell’industria della difesa.
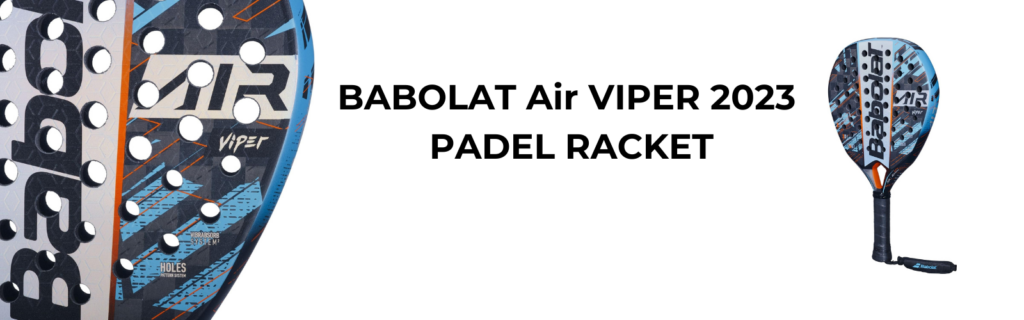
Pechino punta a rafforzare il suo ruolo di hub finanziario e commerciale alternativo a New York e Londra, sfruttando il partenariato BRICS+ e le connessioni logistiche costruite attraverso la Belt and Road Initiative, ora entrata nella sua “fase 2.0” che predilige accordi meno infrastrutturali e più strategici, come il supporto alle valute locali e ai pagamenti digitali tra paesi del Sud globale.
A livello diplomatico, la Cina si presenta come stabilizzatore razionale in un mondo frammentato. Non si propone come “mediatore terzo”, ma come potenza ordinatrice. Lo dimostrano le intese separate con Arabia Saudita e Iran, l’approccio ambiguo ma costante sul dossier russo-ucraino, e la crescente influenza in Africa e America Latina, dove Pechino ha superato l’UE per numero di accordi bilaterali firmati nel biennio 2023-2024.
Militarmente, l’aumento del budget per la difesa – cresciuto del 7,2% nel 2025 – va di pari passo con la proiezione navale e con il potenziamento delle capacità cibernetiche. Ma la vera leva cinese è l’interdipendenza economica, che utilizza con metodo per ottenere concessioni politiche, dividere alleati e inibire sanzioni.
La Cina non è solo un attore internazionale: è un sistema in espansione che mette in discussione l’idea stessa di ordine liberale. Il suo limite? Una crescente diffidenza nei confronti della trasparenza e della cooperazione multilaterale vera. Se da un lato riesce a costruire alleanze per esclusione dagli altri, dall’altro non è ancora in grado di attrarre consenso diffuso, soprattutto in ambito democratico. Il suo soft power rimane limitato, e la gestione autoritaria interna – tra sorveglianza digitale e repressione del dissenso – mina la sua credibilità morale, rendendo fragile ogni sua proposta di governance condivisa.
L’India come potenza incompiuta
L’India, con oltre 1,4 miliardi di abitanti, è oggi il paese più popoloso del mondo e la quinta economia globale per PIL nominale. Eppure, la distanza tra la sua massa critica e la sua influenza geopolitica rimane evidente. Delhi aspira a un ruolo di grande potenza regionale con proiezione globale, ma i limiti infrastrutturali, la debolezza industriale e la frammentazione interna continuano a ostacolarne la traiettoria.
L’economia indiana ha mantenuto nel 2024 un tasso di crescita superiore al 6%, guidata dal settore terziario e dall’export di servizi IT. Tuttavia, oltre il 90% della forza lavoro è impiegata nel settore informale, caratterizzato da bassa produttività, scarsa protezione sociale e altissima vulnerabilità agli shock esterni. La produzione manifatturiera – che il governo Modi ha cercato di rilanciare con il piano “Make in India” – fatica a decollare, soprattutto per mancanza di infrastrutture adeguate, corruzione sistemica e incertezza normativa.
In campo strategico, l’India ha rafforzato i legami con gli Stati Uniti (soprattutto sotto l’amministrazione Trump), sia per contrastare la crescente assertività cinese, sia per diversificare le proprie fonti di approvvigionamento energetico e tecnologico. Tuttavia, continua a mantenere una postura ambigua nei principali scenari globali, come dimostrato dalla neutralità sulla guerra in Ucraina e dalla storica riluttanza a schierarsi apertamente nei consessi multilaterali.
La diplomazia indiana, per quanto attiva, è ancora perlopiù reattiva e opportunista. Si muove bene nel bilanciamento delle potenze (vedi la partecipazione al Quad, ai BRICS e all’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai), ma raramente è promotrice di architetture internazionali. La retorica del “Sud globale” è spesso più una rivendicazione simbolica che una politica coerente.
In ambito militare, l’India vanta un esercito imponente e un programma nucleare autonomo, ma soffre di una cronica inefficienza logistica e di un apparato di difesa obsoleto, come dimostrato dalla gestione poco brillante delle crisi con la Cina lungo la Linea di Controllo Effettivo o con il Pakistan in Kashmir. La sua forza militare è dissuasiva sul piano regionale, ma ancora non credibile su scala globale.
Infine, dal punto di vista istituzionale, la deriva autoritaria del governo Modi – marcata da attacchi alla stampa, restrizioni alla libertà accademica e marginalizzazione delle minoranze – limita l’appeal dell’India come leader democratico, nonostante le sue pretese di guidare il fronte alternativo all’Occidente. L’India è un paese complesso, frammentato e in trasformazione. Ha un enorme potenziale, ma anche una fragilità sistemica che le impedisce, per ora, di presentarsi come vera alternativa alle potenze egemoni.
Cina-India: comunicazione a confronto
Nel confronto tra Cina e India, la comunicazione diventa cartina di tornasole delle rispettive visioni di potere. Non si tratta solo di strategie mediatiche, ma di modelli di governance, cultura politica e proiezione geopolitica. Le due potenze asiatiche parlano linguaggi diversi, non solo per forma ma per funzione: la Cina per affermare un ordine, l’India per costruire un’identità.
La Cina contemporanea non comunica: orchestra. La sua è una comunicazione integrata di Stato, dove il messaggio non è mai isolato ma sempre inscritto in una coreografia complessiva, disciplinata, simbolica. Dai vertici del Partito Comunista agli apparati locali, passando per le agenzie statali (Xinhua, CGTN), la comunicazione cinese è un sistema chiuso, altamente centralizzato, che punta a proiettare forza, stabilità e inevitabilità. Non esiste improvvisazione, né frammentazione.
Sul piano interno, il messaggio dominante è quello del “sogno cinese” (Zhongguo Meng), una visione di prosperità collettiva sotto la guida del Partito. L’individuo è narrativamente secondario: protagonista è la Nazione, intesa come comunità organica. Il dissenso viene rappresentato come disordine o tradimento. Non c’è spazio per la pluralità di visioni: solo gradi diversi di adesione.
Verso l’esterno, la Cina adotta una narrazione diplomatica bifronte: pacifica ma assertiva, amichevole ma sorvegliata. Il lessico della “cooperazione win-win”, dei “nuovi percorsi della seta”, e del “rispetto reciproco” cela una forma di egemonia a bassa intensità, esercitata attraverso contratti, infrastrutture e presenza commerciale. La “neutralità” è strategica: consente alla Cina di apparire come potenza non coloniale, alternativa all’unilateralismo americano, ma dietro questa facciata si muove un apparato propagandistico imponente, più seduttivo che persuasivo, che non cerca empatia, ma acquiescenza.
La comunicazione cinese non vuole generare dibattito, ma modellare l’ambiente informativo. Si basa sulla ripetizione, sull’estetica dell’ordine, sullo sguardo della stabilità. Vuole essere ammirata, ma non discussa. Ed è proprio questa estetica dell’incontestabilità che ne rappresenta oggi sia la forza che il limite: potente in contesti dove la forma è sostanza, fragile laddove la legittimità passa dal confronto aperto.
L’India, al contrario, non orchestra: amplifica. È il Paese dove il rumore è parte integrante della comunicazione politica, e dove l’assenza di un centro coordinante genera una pluralità di voci che si intrecciano, si sovrappongono, si smentiscono. Ma dietro questo apparente disordine, il governo Modi ha costruito una narrazione fortemente ideologizzata, nazionalista, tecno-populista e visivamente seducente.
Il racconto pubblico dell’India è centrato sul “New India”: moderno, potente, digitale, spirituale e “post-coloniale”. Modi è il volto di questa narrazione: onnipresente, mediatizzato, protagonista di una comunicazione diretta, iper-personalizzata e fatta di slogan, appelli emotivi e simboli religiosi reinterpretati politicamente. L’“Induismo civile” diventa veicolo retorico di unità nazionale, al costo di emarginare minoranze, dissidenti e voci critiche.
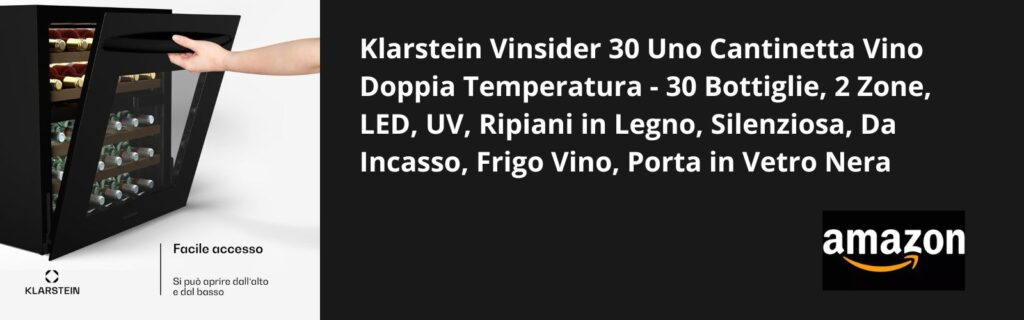
Il soft power indiano – tradizionalmente fondato su diaspora, Bollywood, yoga e spiritualità – è stato assorbito nel nazionalismo comunicativo del BJP, che ha ibridato tradizione e marketing digitale, dando vita a una macchina comunicativa che mescola propaganda e influencer, mitologia e storytelling politico. Ma è una comunicazione che parla principalmente al “sé”: orientata all’interno, autoreferenziale, più ossessionata dalla percezione che dalla realtà.
Nel contesto internazionale, l’India appare meno coerente: alterna aperture globaliste a richiami sovranisti, linguaggi da potenza moderatrice a posture da vittima del sistema. L’immagine esterna è costruita più per suggestione che per coerenza, e se funziona è perché il sistema globale cerca disperatamente un’alternativa alla Cina. Ma la comunicazione diplomatica indiana non è ancora in grado di sostenere il peso delle proprie ambizioni: non controlla il racconto, lo subisce.
La sua fragilità sta qui: troppo “viva” per essere credibile come potenza ordinatrice, troppo divisa per imporsi come egemone simbolica. Mentre la Cina impone una grammatica globale della forza, l’India offre un lessico dispersivo dell’ambizione. Entrambe usano la comunicazione come strumento di potere, ma con una differenza sostanziale: la Cina comunica per dissuadere, l’India per esistere.
Le due diverse architetture di potenza
Nel confronto fra Cina e India, emergono due modelli profondamente diversi di potenza in costruzione. Da un lato, la Cina: attore sistemico con un’idea strutturata del proprio ruolo globale, dotata di una visione, di un arsenale diplomatico, economico e narrativo coerente, e soprattutto capace di articolare la propria presenza internazionale in forme riconoscibili, disciplinate, spesso persuasive.
La Cina non solo sa dove vuole arrivare, ma ha anche iniziato a scrivere le regole della partita. Ed è proprio questa chiarezza strategica a renderla una potenza comunicante: la sua diplomazia parla, la sua economia scrive, il suo apparato simbolico – dal soft power al linguaggio dei vertici multilaterali – agisce in modo coordinato. È una superpotenza che non cerca solo di essere ascoltata: vuole essere capita, accettata, temuta.
La Cina non si muove nel caos, ma in un ordine internazionale alternativo che va metodicamente costruendo da oltre un decennio. Attraverso la Belt and Road Initiative, l’Asian Infrastructure Investment Bank e le nuove piattaforme multilaterali asiatiche, Pechino propone un modello che sfida l’universalismo occidentale senza bisogno di proclami ideologici: offre infrastrutture, connessioni, investimenti. Più che alleanze, costruisce dipendenze strategiche. Il suo allineamento tattico con la Russia, la vicinanza crescente all’Iran, i rapporti asimmetrici con l’Africa subsahariana e l’America Latina sono tutti tasselli di un mosaico coerente. La Cina vuole essere al centro di un nuovo ordine mondiale. E agisce, comunica, negozia esattamente in questa direzione.
Dall’altro lato, l’India. Una democrazia in tumulto, un’economia in crescita, una massa critica imponente. Ma ancora una potenza potenziale, non sistemica: senza dottrina, senza un disegno riconoscibile, senza una narrazione stabile. L’India oggi non ha ancora deciso cosa vuole diventare. Oscilla tra l’essere il pilastro asiatico dell’Occidente e il difensore di un Sud globale plurale, ma senza mai assumere pienamente nessuno dei due ruoli. Di fatto, non detta le regole del gioco perché non le ha ancora interiorizzate, né le ha mai volute davvero sovvertire. Si muove in base alla convenienza immediata: si è avvicinata alla Russia nonostante la guerra in Ucraina, ha rafforzato i rapporti con Israele mentre invoca la decolonizzazione del mondo, e partecipa al Quad senza abbandonare lo SCO. È una diplomazia volubile, fatta più di posizionamenti reattivi che di visioni proattive.
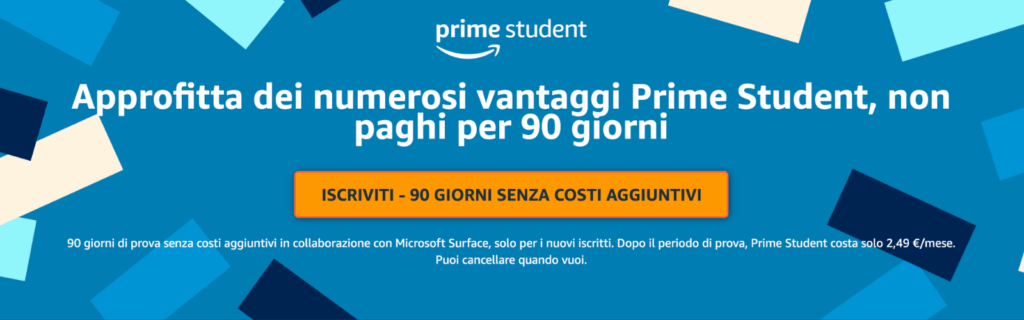
Proprio per questo, il suo status di potenza emergente resta sospeso. L’India comunica solo a tratti, e spesso più per riflesso che per strategia: non fa sistema, non costruisce un modello esportabile, non stabilisce cornici narrative proprie. Si comporta come un grande alleato, non come un leader. È più comoda nella posizione di numero due della potenza egemone che nella responsabilità di agire come attore autonomo. Fa rumore, ma non orienta.
In un mondo sempre più definito dalla capacità di comunicare potere, la Cina avanza con coerenza e intenzione. L’India attende di capire da che parte stare davvero. E finché questa ambivalenza non sarà sciolta, la distanza tra volume e visione – tra potenza dichiarata e potenza reale – continuerà a definire il grande divario strategico tra i due giganti asiatici.












