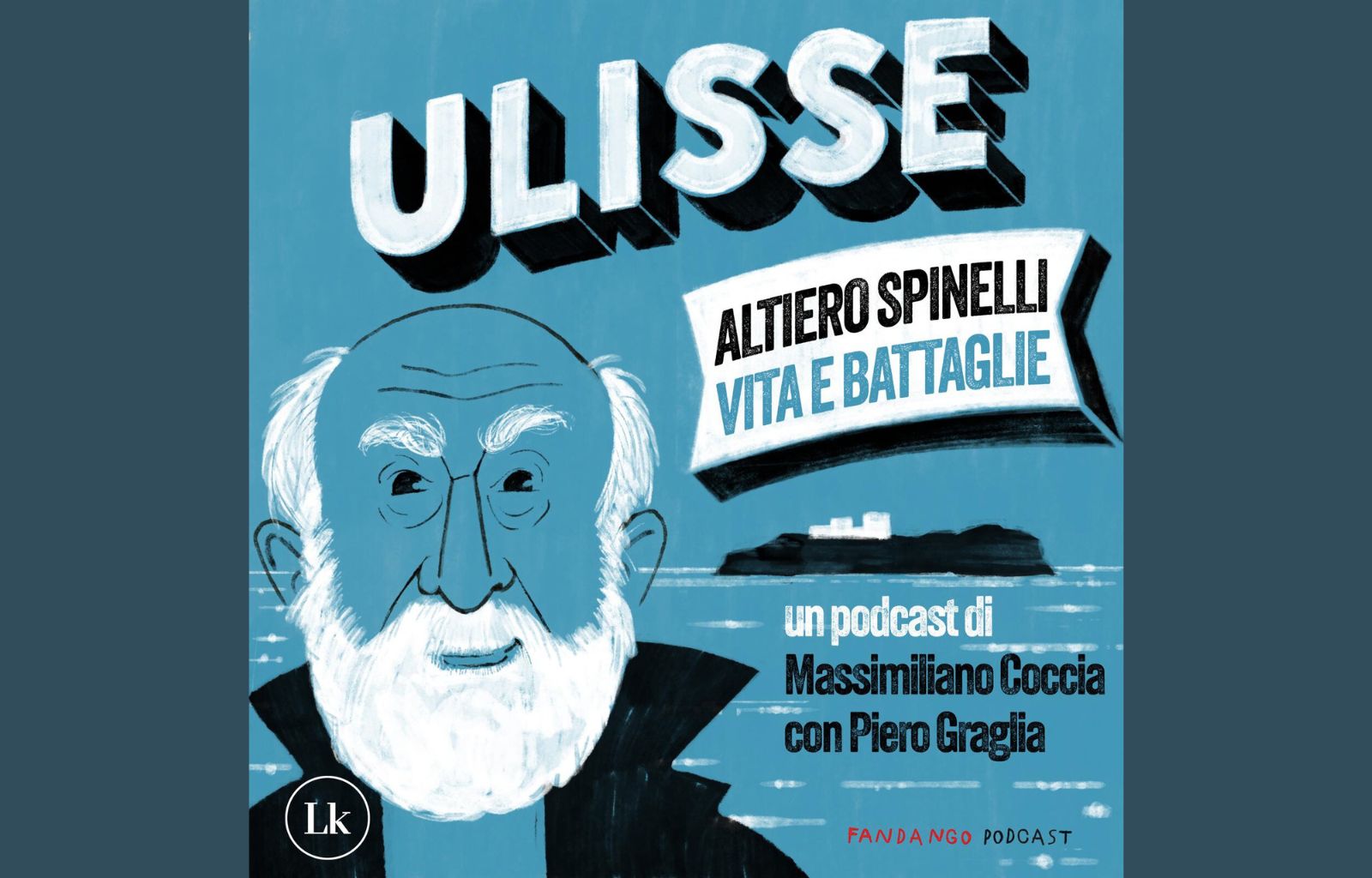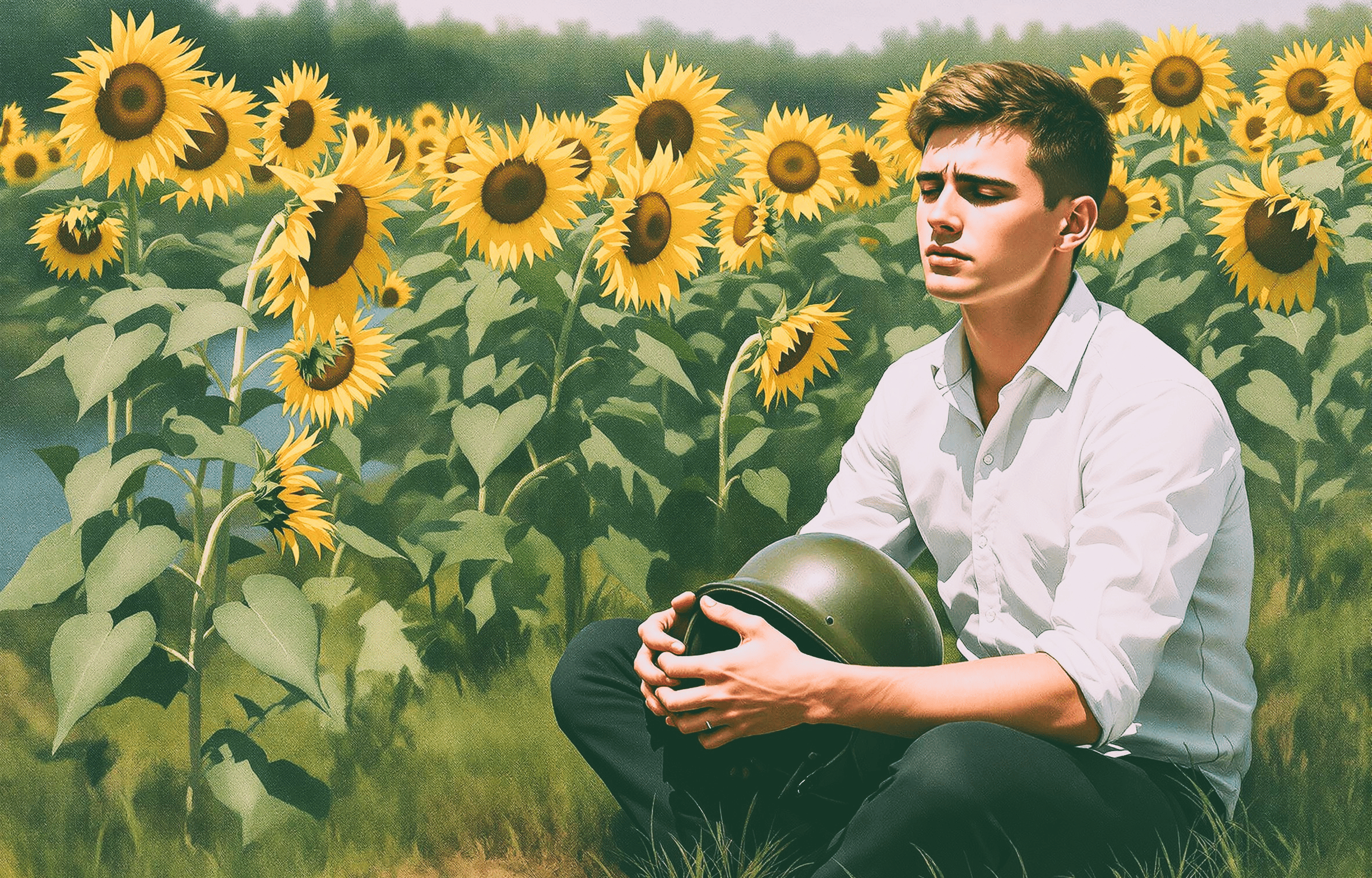A Canterbury torna il rito cattolico per Thomas Becket. Un eroe da riscoprire

Le note del Salve Regina, accompagnate dall’organo, si sono innalzate verso le vertiginose arcate gotiche della cattedrale di Canterbury nella sera del 7 luglio.
È raro veder celebrare una liturgia cattolica nell’edificio simbolo della riforma anglicana, ma stavolta l’occasione lo meritava.
Approfittando del Giubileo, infatti, è stata ripetuta per la prima volta da quasi mezzo millennio una cerimonia alla quale un tempo gli inglesi erano affezionatissimi: la traslazione del corpo di Thomas Becket dalla cripta sotterranea ad un altare della cattedrale, dove veniva offerto alla venerazione popolare.
Questa tradizione era stata bruscamente interrotta da re Enrico VIII, che, dopo essersi staccato dalla chiesa di Roma, aveva comandato persino di distruggere l’altare, come parte di un attacco su vasta scala contro il culto dei santi.
Fra tutti i santi, poi, Becket, assassinato nel 1170 per ordine di un re al quale si era rifiutato di piegarsi, era particolarmente scomodo.
In tempi più recenti, gli anglicani hanno ricominciato a commemorare Becket tra i loro santi (anche se non venerano le sue reliquie né invocano il suo nome come fanno i cattolici). Infine, i rapporti tra anglicani e cattolici si sono distesi a tal punto che è stato possibile compiere il bel gesto di fratellanza del 7 luglio.
Del resto, Becket non è soltanto un martire cattolico, e non è neanche soltanto un eroe nazionale inglese, ma è una personalità che ha cambiato il corso dell’intera storia europea sacrificandosi per ciò che gli europei hanno di più caro: la libertà della coscienza di fronte ai soprusi del potere.
Un campione dell’indipendenza della chiesa
Nato nel 1118, Becket fu scelto alla metà del secolo come Lord cancelliere dal giovane re Enrico II.
Era il tempo in cui le casate regnanti europee cercavano di limitare il potere dei feudatari e di conquistare un controllo effettivo sul proprio territorio, e l’Inghilterra, come tutte le creazioni politiche dei normanni, era piuttosto avanzata sotto questo aspetto.
Esperto nella giurisprudenza e leale al suo sovrano, Becket lo aiutò in questo processo.
Era, però, anche il periodo della riforma gregoriana, con la quale la chiesa aveva aspirato a una maggiore purezza di costumi e a una più stretta fedeltà al vangelo: per essere in grado di imporle, si era dovuta dare un’organizzazione gerarchica e centralizzata che in breve tempo l’aveva resa pressoché indipendente dai monarchi terreni, anzi, spesso in grado di influenzarne i destini.
(I pellegrinaggi armati, prima in Spagna e poi in Terra Santa, che oggi chiamiamo “crociate” nacquero proprio dal tentativo di imporre una rudimentale disciplina religiosa al ceto dei cavalieri feudali).
Così, quando nel 1162 Enrico II propose a Becket di diventare arcivescovo di Canterbury, nella speranza che il suo fedele amico addomesticasse il clero inglese per lui, Becket all’improvviso mutò pelle.
Da quel momento in poi, il suo dovere non era più servire il trono, ma servire l’altare. E con la stessa determinazione con cui fino al giorno prima era stato il braccio destro di re Enrico, iniziò ad opporsi a ogni sua singola pretesa.
Non lo fece da fanatico, né senza ragionare. Quando Enrico pretese che i chierici accusati di un crimine venissero processati secondo “le consuetudini del regno”, ossia da tribunali laici, Becket lo contrastò nel merito su alcuni punti di quelle “consuetudini”, non sul principio generale.
Quando però, con le Costituzioni di Clarendon, Enrico pretese di avere l’ultima parola sulla nomina dei vescovi, cioè di trasformare la chiesa in uno strumento del sovrano per controllare la coscienza religiosa dei sudditi, Becket si rifiutò di firmare e fu mandato in esilio.
L’assassinio
Becket cercò l’appoggio del papa, ma per Alessandro III Bandinelli erano tempi duri: la lotta per le nomine dei vescovi gli era entrata in casa insieme alle armate di Federico Barbarossa, infuriava la guerra tra l’imperatore tedesco e i comuni italiani, e l’amicizia delle altre capitali europee, a cominciare da Londra, gli era indispensabile.
Così Becket dovette accettare un compromesso col re e rientrare in Inghilterra da sconfitto.
L’entusiasmo popolare per il suo ritorno, però, fu immenso. Quando Enrico, per sminuirlo, fece celebrare l’incoronazione di suo figlio da un altro sacerdote, Becket denunciò in una predica tutti i preti e i baroni che avevano partecipato a questo oltraggio, scatenando l’indignazione della folla.
A quel punto Enrico, secondo la leggenda, avrebbe pronunciato la frase: “Chi mi libererà da questi preti turbolenti?”
E quattro cavalieri della sua corte, dei quali conosciamo nome e cognome, seguirono Becket nella cattedrale dove stava andando a cantare i Vespri e lì lo uccisero a sangue freddo.
Dalla storia al mito
Come spesso accade, la commozione per il morto fu tanta quanta era stata la diffidenza per il vivo.
Alessandro III lo fece santo in tempo record (1173, tre anni dopo il suo omicidio). Quanto a re Enrico, indebolito di fronte ai suoi nemici interni, dovette fare penitenza sulla tomba del martire con il capo cosparso di cenere.
Una generazione più tardi, suo figlio Giovanni Senzaterra si trovò in una situazione ancora più precaria dopo una brutta sconfitta contro i francesi, e dovette arrendersi a tutte le richieste di autonomia che provenivano dai sudditi, a partire ovviamente dalla chiesa.
Nella Grande Carta delle Libertà, che Giovanni firmò nel 1215, il primo principio a venire affermato fu proprio la libertà della chiesa, seguita dal diritto di ogni suddito libero a venire giudicato da un tribunale di suoi pari in un processo regolare e dal diritto per i Parlamenti di pronunciarsi sulle scelte fiscali del re.
Era l’alba del mondo moderno. E il ricordo di Thomas Becket, ravvivato ogni anno dalla cerimonia della traslazione del suo corpo nel luogo stesso in cui era stato ucciso, aveva contribuito a farlo nascere.
E tra i giovani britannici il “papismo” non è più tabù
Il coraggio di Becket è un patrimonio di tutti gli europei, compresi quelli secolarizzati e atei. E proprio il Regno Unito è stato uno dei paesi dove il declino della religiosità è stato più marcato negli ultimi decenni.
Tuttavia, è interessante notare come di recente ci sia stata una piccola fiammata tra i giovani dai 18 ai 24 anni: rispetto a prima della pandemia, quelli che si dicono cristiani sono passati dal 6% al 18% (22% tra i maschi) e il cattolicesimo è diventato di gran lunga la scelta preferita (41%, il doppio degli anglicani e dei puritani).
Possiamo discutere a lungo sul come e sul perché: background migratorio più frequente, liturgia più tradizionale e suggestiva, coinvolgimento più forte nel volontariato, immaginario più adatto all’epoca dei social.
Ma è un segnale che forse, sotto la cenere della società contemporanea, qualcosa si muove, antiche ferite si rimarginano e vecchi tabù vengono superati. D’altronde, in un regno che ha il sindaco della capitale musulmano e fino a poco fa ha avuto il primo ministro induista, un ritorno in grande stile dei “papisti” è meno sconvolgente di quanto sarebbe sembrato ai nostri nonni.
Una in diversitate, dice il motto dell’Europa, nella lingua che fu di Becket e del clero medievale.