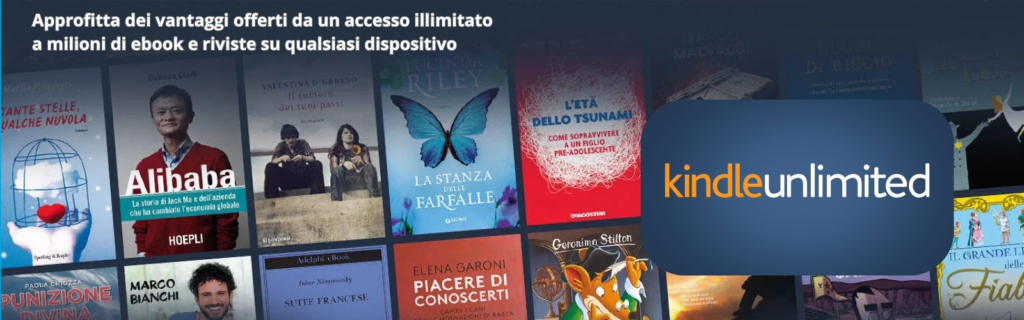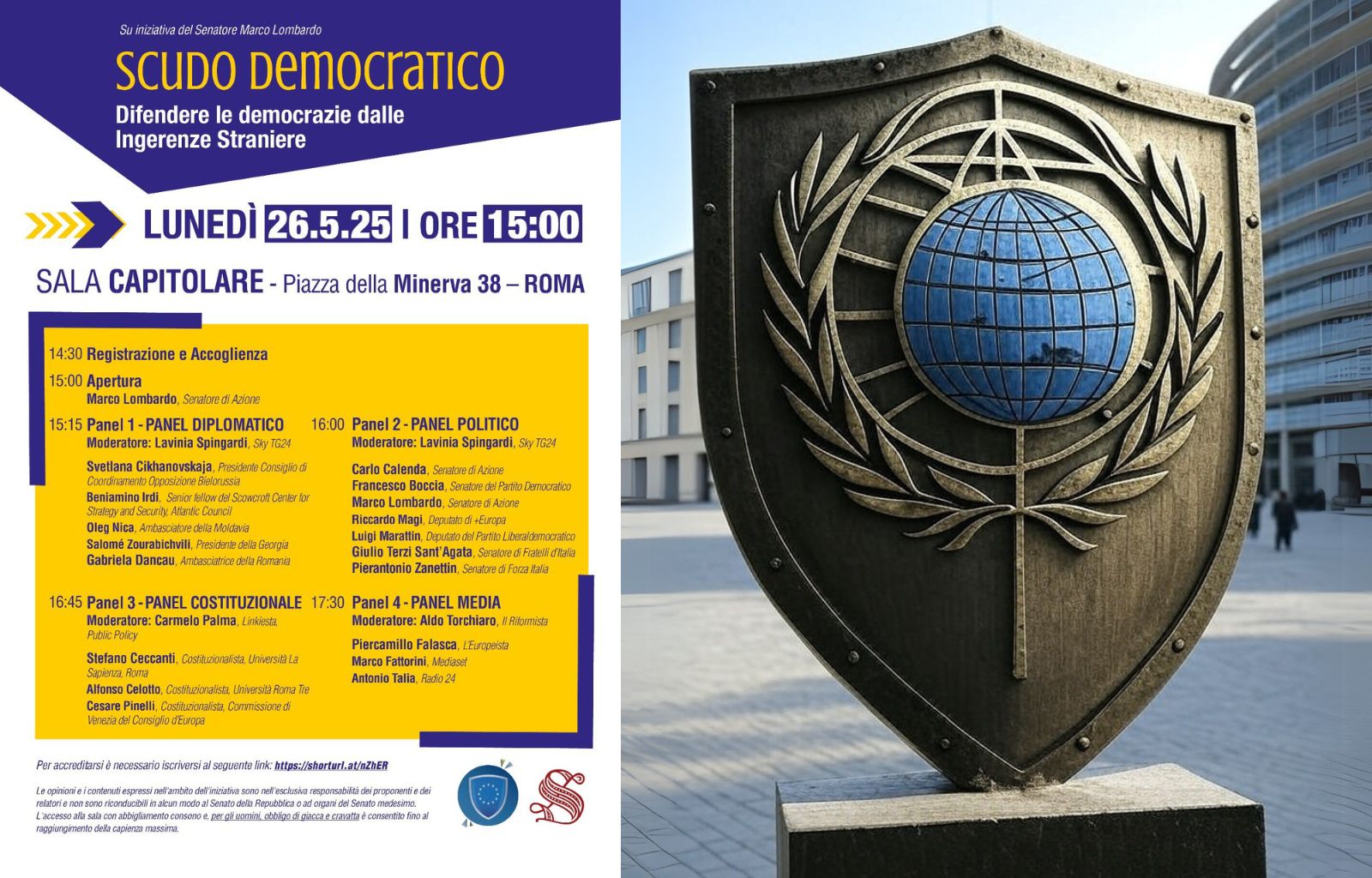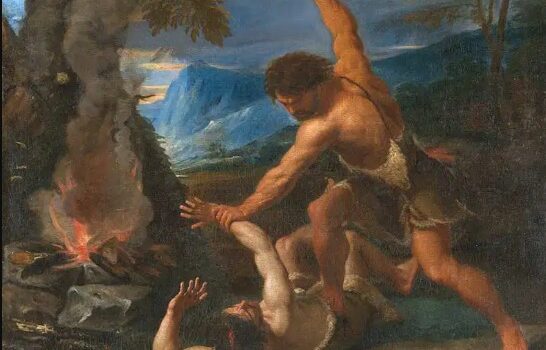La Romania è la prova che il modello Trump non è esportabile

Le elezioni presidenziali in Romania del 2025 si sono rivelate molto più che una semplice consultazione elettorale nazionale. Sono diventate un laboratorio comunicativo, un test strategico
per i rapporti fra narrativa populista e tenuta europeista, e un osservatorio per misurare l’efficacia dell’esportazione del trumpismo in un contesto non americano. La vittoria di Nicușor Dan contro George Simion, al ballottaggio con un sorprendente 53,6% contro il 46,4% dell’avversario, ha rivelato uno scenario molto più complesso di quanto fosse apparso al primo turno, chiuso da Simion in netto vantaggio. Più che un risultato elettorale, è stata una risposta culturale.
L’affluenza record (64,72%) – la più alta dal 1996 – ha evidenziato quanto la sfida tra europeismo e sovranismo, tra istituzioni e radicalismo, tra moderazione tecnica e populismo identitario, abbia
mobilitato un elettorato che nel primo turno era parso rassegnato. Ma la posta in gioco non era solo la presidenza romena: era il ruolo della Romania nello scacchiere europeo, l’impatto delle ingerenze russe, la capacità della comunicazione politica di influenzare la percezione dell’Occidente, e la credibilità dell’establishment democratico in una regione sempre più ibridata da disinformazione, revanscismo geopolitico e polarizzazione digitale.
Tra europeismo pragmatico e nazionalismo performativo
Il duello tra Nicușor Dan e George Simion è stato uno scontro narrativo più che ideologico. Dan, indipendente con un passato da attivista civico e sindaco di Bucarest, ha costruito la sua campagna attorno alla parola d’ordine “Romania onesta”. La sua è stata una comunicazione fondata su sobrietà, contenuti tecnici, e rivendicazione di uno stile amministrativo basato sulla trasparenza e la responsabilità. Simion, al contrario, ha puntato tutto sulla retorica della Grande Romania, sulla denuncia di un presunto complotto delle élite europee e sull’affiliazione comunicativa a modelli populisti occidentali, in primis quello di Donald Trump.
Il voto diaspora, che avevamo analizzato in un precedente articolo, è stato un campo rivelatore. I romeni dell’Est Europa hanno premiato Dan, riconoscendone l’impegno istituzionale e la visione euroatlantica. Al contrario, nella diaspora dell’Europa occidentale – eccezion fatta per i Paesi nordici, Olanda, Svizzera, Portogallo e Lussemburgo – Simion ha ottenuto consensi significativi, sfruttando la frustrazione migrante, il malessere economico, e la narrativa identitaria. Proprio tra queste comunità, la disinformazione e le fake news hanno trovato terreno fertile, alimentate da una campagna di amplificazione mediatica
vicina agli ambienti dell’estrema destra internazionale.
I toni delle rispettive campagne elettorali
Simion ha costruito una campagna “da reality show”. Ha disertato i confronti televisivi, preferendo tour nei paesi dell’est europeo dove si è fatto fotografare con leader e militanti
sovranisti. Ha ricevuto l’appoggio esplicito di Steve Bannon, Marine Le Pen, Viktor Orbán, oltre che dell’estrema destra polacca e italiana (con Salvini e Vannacci in prima fila). Anche Giorgia
Meloni gli ha espresso sostegno: un gesto che, alla luce della sua sconfitta, rappresenta un altro boomerang della politica estera personalizzata del governo italiano.
La comunicazione di Dan ha puntato sull’assenza di spettacolarità. Nessun grande comizio, pochi slogan, molta sostanza: nei confronti tv si è spesso trovato solo, con il podio vuoto dell’avversario trasformato in meme virale. Ma proprio in quella solitudine ha costruito credibilità.
Ha fatto dell’assenza di retorica un atto politico. Ha messo al centro il legame con la città, l’esperienza da sindaco, e una visione della presidenza come argine istituzionale, non come palco.
Infine, la questione UE e NATO. Simion, pur senza proporre l’uscita formale dai due organismi, ha fatto campagna con toni anti-occidentali, alimentando una narrativa revisionista (incluso il ritorno delle terre “perdute”) che ha suscitato forti reazioni a Kiev e Bruxelles. Dan, al contrario, ha rivendicato il radicamento euroatlantico del paese, posizionandosi come garante del rispetto costituzionale e delle alleanze strategiche. La sua è stata una campagna di rassicurazione istituzionale in un tempo di frattura.
Va sottolineato che, a modo suo, anche Nicușor Dan si è imposto come figura antisistema: indipendente, tecnocratico, poco incline al compromesso partitico e critico della classe politica tradizionale. La sua campagna non ha cercato l’appoggio dei grandi partiti, ma si è nutrita di un capitale reputazionale costruito attraverso l’attivismo civico, l’esperienza amministrativa e una
narrazione basata su competenza, onestà e visione pragmatica.
Tra errori comunicativi, ingerenze russe e modello trumpiano fallito
La seconda fase dell’analisi è quella più strettamente geopolitico-comunicativa. Le presidenziali del 2025 non arrivano in un vuoto: seguono l’annullamento del voto del novembre precedente, vinto
dall’ultranazionalista Călin Georgescu e poi invalidato per interferenze russe. Proprio Georgescu, escluso dal voto attuale, aveva promesso di diventare premier in caso di vittoria di Simion. Il legame tra i due è stato sfruttato con intelligenza dalla campagna di Dan, che ha enfatizzato il rischio di una deriva filorussa e autoritaria. Ed è stato anche usato da Bruxelles e da alcune cancellerie occidentali per mobilitare risposte pubbliche a sostegno della democrazia romena.
Ma è la comunicazione sbagliata a raccontare meglio il fallimento del modello Simion. Il candidato
sovranista ha pubblicato su X (ex Twitter) un post di rivendicazione della vittoria con la bandiera del Ciad, identica a quella rumena ma con sfumature differenti. L’errore, divenuto virale, ha
rafforzato l’immagine di una campagna superficiale, simbolicamente disallineata. Non è stato solo un errore grafico: è stato un errore narrativo. In una campagna fondata sulla simbologia nazionale, sbagliare bandiera è come sbagliare partitura in un concerto. È un fallimento
performativo.
Altro elemento chiave: il ruolo della disinformazione. La Romania è uno dei paesi più vulnerabili all’influenza delle narrative russe. Proprio per questo, la scelta di Dan di mantenere un profilo sobrio, verificabile, e di affidarsi a media indipendenti è stata una contromisura efficace. Simion, invece, ha dato ampio spazio a fonti dubbie, rilanciando frame cospirazionisti, attacchi alla magistratura e al deep state, teorie sull'”invasione LGBTQ” e sulla “romanizzazione forzata” dei bambini. Retoriche che funzionano in contesti polarizzati, ma che qui hanno generato rigetto.
In questa dinamica, l’Europa ha avuto un ruolo chiave.
L’endorsement implicito di Bruxelles a Dan
Il supporto delle istituzioni europee nei confronti di Dan, ha rappresentato un argine fondamentale. Così come la reazione dell’Ucraina, che ha salutato con favore la sua vittoria, considerando Simion “persona non grata” per le sue dichiarazioni revansciste.
Nonostante qualche polemica interna, Dan ha saputo tenere un profilo credibile, evitando le trappole delle pressioni ideologiche.
L’effetto domino per l’Italia è inevitabile. L’appoggio espresso da Giorgia Meloni a George Simion va letto nel quadro delle dinamiche interne al gruppo dei Conservatori e Riformisti
Europei (ECR), di cui Meloni è stata presidente e Simion è attualmente vice-presidente esecutivo. In caso di vittoria del sovranista, il peso politico dell’ECR all’interno del Parlamento europeo ne sarebbe uscito rafforzato, permettendo al gruppo di negoziare da una posizione più solida in vista della prossima legislatura europea.
L’operazione era pensata in chiave strategica, come tassello di un più ampio tentativo di rilegittimazione delle destre sovraniste su scala continentale. Tuttavia, il risultato finale ha evidenziato i limiti di un’equazione troppo automatica tra trumpismo e consenso europeo: ciò che si traduce in forza elettorale negli Stati Uniti, grazie a una struttura istituzionale e informativa peculiare, non trova automaticamente riscontro nel contesto europeo, dove l’elettorato tende a penalizzare le alleanze percepite come destabilizzanti o troppo inclini a narrative revisioniste. Il caso romeno ha mostrato con chiarezza questo scarto.
La comunicazione post-elettorale di Simion
La comunicazione post-elettorale di George Simion si è inserita coerentemente nel solco di una
retorica populista, muscolare e talvolta maldestra, che ha caratterizzato tutta la sua campagna. Dopo la sconfitta, Simion ha cercato di rivendicare comunque un ruolo simbolico, pubblicando un tweet
in cui celebrava una presunta vittoria. Il post, che avrebbe dovuto esibire la bandiera romena, mostrava invece quella del Ciad – identica per disposizione di colori, ma distinta da un’interpretazione visiva che nel contesto politico ha assunto un tono comico e paradossale. Questo errore, divenuto rapidamente virale, ha scatenato un’ondata di ironia sui social media e ha ulteriormente incrinato la sua immagine di leader credibile sul piano internazionale.
La gaffe comunicativa riflette un approccio all’arena pubblica dominato più dall’impulso propagandistico che da una strategia consapevole. Simion ha impostato l’intera narrativa della sua candidatura sulla centralità identitaria, la difesa della “Grande Romania” e il contrasto alle élite globali, senza però riuscire a trasformare questa impostazione in una comunicazione istituzionalmente efficace. La scelta di disertare i confronti televisivi, mentre Dan si mostrava
disponibile al dibattito e alla visibilità argomentativa, ha accentuato l’impressione di un candidato
forte nei proclami, ma debole nella gestione dei momenti decisivi.

Anche nella gestione del risultato elettorale, il tono di Simion è rimasto improntato al vittimismo e alla delegittimazione implicita degli avversari. I suoi riferimenti alle “interferenze” e alla “partitocrazia” si sono saldati a una narrativa più ampia, che da tempo mira a sovrapporre l’immagine dell’establishment nazionale con le strutture sovranazionali – in particolare Bruxelles – dipingendole come ostacoli all’autodeterminazione popolare. Questa narrativa, tuttavia, ha mostrato limiti evidenti quando confrontata con l’affluenza record del secondo turno, che ha premiato proprio l’antitesi europeista rappresentata da Dan.
Cosa impariamo noi europei da queste Presidenziali
La conclusione di questa tornata elettorale fornisce indicazioni chiare non solo sul futuro della Romania, ma su quello dell’intera architettura democratica dell’Est Europa. In un contesto segnato dall’espansione della propaganda filorussa, dalla polarizzazione tra spinte sovraniste e vincoli europeisti, e da una crisi strutturale dei partiti tradizionali, la vittoria di Dan rappresenta un caso di
studio.
Il ballottaggio romeno non è stato solo lo scontro tra due candidati, ma la rappresentazione plastica di due idee di nazione e di futuro europeo. Simion ha incarnato una visione nostalgica, identitaria, vicina alle istanze dell’ultradestra trumpiana e sostenuta da un network internazionale apertamente
sovranista. Dan, al contrario, ha saputo mobilitare un consenso civico, transgenerazionale e pragmatico, senza cedere al populismo ma parlando a un elettorato stanco di corruzione e retorica
vuota.
La Romania esce da queste elezioni con un presidente indipendente, tecnocratico, europeista e non ideologico – ma anche con un’avvertenza chiara: il voto non è univoco, e le forze illiberali restano in agguato. L’Europa dovrebbe leggere con attenzione questa lezione, perché non sempre l’onda populista si arresta da sola. Servono candidati credibili, strutture narrative solide e una strategia comunicativa che restituisca fiducia nella democrazia rappresentativa. Nicușor Dan ha
fornito una possibile via. Non definitiva, ma necessaria.