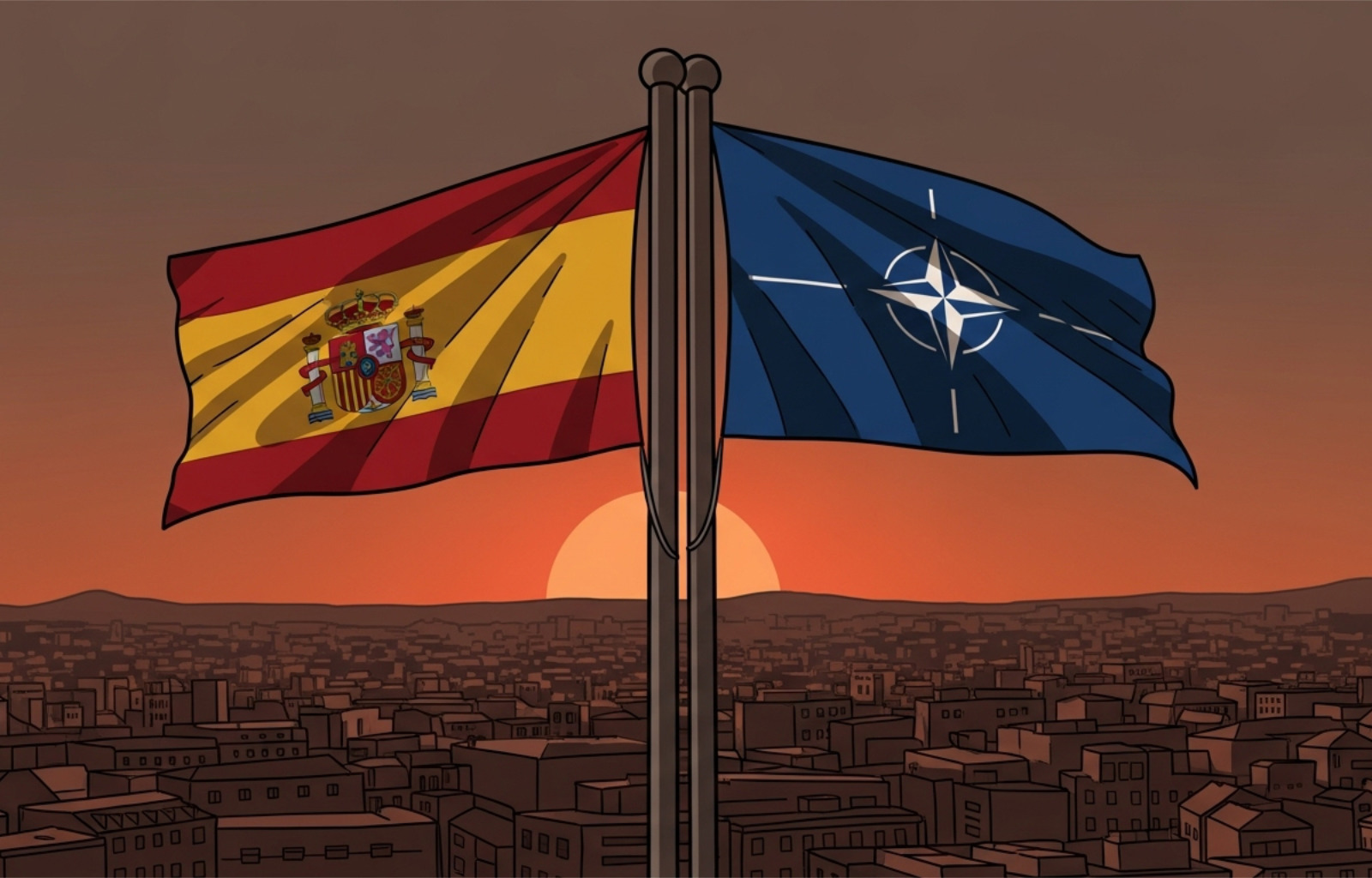Disarmare le parole, per battere la disinformazione

Negli ultimi mesi, lo schema è diventato fin troppo prevedibile: i professionisti della disinformazione rilanciano teorie complottiste – tipo Steve Bannon sull’elezione definita “truccata” di Papa Leone XIV – reti di bot riconducibili alla propaganda russa diffondono false accuse di tossicodipendenza contro leader europei come Macron, Starmer e Merz, e una parte dell’opinione pubblica — alimentata da media accondiscendenti o da piattaforme social in cerca di traffico — amplifica senza filtro. È una strategia deliberata, ormai strutturata, che punta a minare la fiducia nelle istituzioni (inclusa la scienza, peraltro) e a spostare il dibattito pubblico su un piano di caos emotivo e sospetto permanente.
A rendere questo fenomeno più insidioso è il fatto che non trova quasi più opposizione razionale. La risposta prevalente è l’indignazione, lo sdegno, il rilancio isterico. Poco spazio per la verifica, per il dato, per il tempo necessario a distinguere tra fatto e narrazione.
È in questo contesto che assume rilievo l’importante discorso che Papa Leone XIV ha rivolto ai giornalisti il 12 maggio, durante un’udienza nell’Aula Paolo VI. Il Papa ha parlato per appena undici minuti, ma è riuscito a mettere a fuoco una questione centrale: la comunicazione, se non è responsabile, rischia di diventare parte del problema.
Ha usato un’immagine forte, ma precisa: “Disarmare le parole”. Non per censurare, ma per sottrarre il linguaggio pubblico alla logica dell’aggressione. Ha chiesto di dire no alla “guerra delle parole e delle immagini”, di evitare una comunicazione fragorosa e muscolare, spesso funzionale a polarizzare invece che a spiegare. E ha legato questo invito a un’esigenza concreta: restituire voce a chi non ce l’ha, costruire informazione che ascolta invece di imporsi.
Nel suo intervento, Leone XIV ha espresso anche la solidarietà della Chiesa ai giornalisti incarcerati per aver fatto il proprio mestiere in contesti ostili alla libertà di stampa. Ha parlato di “testimoni coraggiosi” e ha ricordato che solo i popoli informati possono essere davvero liberi. È un principio semplice, ma che torna centrale in un’epoca in cui la disinformazione diventa metodo politico e strumento ibrido di guerra.
Un altro passaggio significativo ha riguardato l’intelligenza artificiale. Il Papa ha riconosciuto il potenziale di questi strumenti, ma ha messo in guardia contro l’uso distorto che può amplificare errori, manipolazioni, falsità. La tecnologia, ha detto, non è neutra: dipende da come viene orientata, e serve discernimento per renderla utile al bene comune.
Nonostante il tono amichevole — con qualche battuta su Jannik Sinner, doni ricevuti dai presenti, interazioni dirette — il discorso è stato definito da trattato di deontologia professionale. In un clima in cui la verità viene relativizzata, banalizzata o sostituita da fiction emotiva, il Papa ha ricordato che c’è ancora spazio per una comunicazione sobria, responsabile, verificabile.
Siamo totalmente d’accordo: non si tratta di moralismo, si tratta di metodo. Chi oggi vuole resistere all’inquinamento informativo ha bisogno di strumenti, non solo di valori. E in questo senso, il richiamo del Papa è un invito a rallentare, a controllare, a non reagire per impulso. La forza della democrazia sta nella capacità di tenere il dibattito su un piano di realtà, è lì che si gioca la partita.
La disinformazione non si batte con i contro-narrativi urlati, ma con la qualità e l’affidabilità dei fatti. È un lavoro paziente, che chi fa giornalismo — e chi consuma informazione — non può più permettersi di trascurare.