Dopo l’era unipolare. Il difficile cammino verso l’autonomia strategica europea

Stati Uniti, Russia ed Europa a confronto
Il nuovo ordine globale non ha nulla di ordinato. Sotto la superficie retorica delle organizzazioni internazionali e delle alleanze consolidate, si consuma una ridefinizione profonda delle priorità e delle visioni strategiche delle grandi potenze. Gli Stati Uniti, la Russia e l’Unione Europea – nominalmente partner o rivali, a seconda delle coordinate – si muovono su binari sempre più separati, con obiettivi geopolitici che raramente coincidono e, in alcuni casi, si ostacolano apertamente.
Il funerale di Papa Francesco, evento globale e al contempo simbolico, ha offerto lo spunto per nuove
triangolazioni diplomatiche, come l’incontro tra Trump e Zelensky, ma ha anche sottolineato, per contrasto, quanto l’Europa stenti a ritagliarsi uno spazio proprio nei dossier internazionali più delicati. In un contesto segnato dal ritorno degli imperialismi e da una crescente competizione globale, la sfida per l’UE è ormai chiara: abbandonare il ruolo di comprimaria e costruire una propria identità strategica autonoma, capace di navigare tra le tensioni di Washington e le manovre di Mosca, senza dimenticare Pechino.
Questa analisi passa in rassegna le divergenze tra i tre principali attori del sistema internazionale, per mostrare come l’attuale transizione geopolitica non possa più essere interpretata secondo le vecchie logiche della Guerra Fredda o della globalizzazione liberale.
Serve un nuovo paradigma e l’Europa, se non vuole essere schiacciata, deve cominciare a scriverlo.
Il ritorno degli USA alla politica della forza
La politica estera americana, soprattutto nell’impostazione di Donald Trump, si è progressivamente svincolata dalle grandi narrazioni idealistiche che avevano caratterizzato la fase post-1989, erede di
una “missione civilizzatrice” che aveva legittimato l’egemonia a stelle e strisce sotto la bandiera della democrazia liberale. A partire dalla dottrina Bush fino alle ambiguità multilateraliste di Obama, Washington ha per decenni costruito consenso su una base valoriale universalista. Con Trump, quella grammatica è stata smontata pezzo dopo pezzo.
Trump ha incarnato una dottrina di interesse nazionale nudo e crudo, improntata a:
- protezionismo economico (non come eccezione, ma come principio regolativo),
- ridimensionamento degli impegni multilaterali, letti come fardelli inutili e limitanti,
- negoziazioni bilaterali muscolari di tipo win-lose , dove l’unico obiettivo è prevalere sull’interlocutore, anche se alleato,
- ridefinizione gerarchica delle alleanze tradizionali, in particolare all’interno della NATO,
dove la solidarietà è subordinata al calcolo dei costi-benefici immediati.
A mutare è stato l’intero impianto di legittimazione del soft power americano. La “pace attraverso la forza” -evocata anche nei recenti colloqui con Zelensky- non è stata tanto un ritorno alla diplomazia realista, quanto una sua radicalizzazione. In questo schema, gli Stati Uniti non si percepiscono più come garanti dell’ordine globale, ma come capofila di una nuova era di competizione aperta tra potenze, dove anche gli alleati devono “pagare il prezzo” della protezione americana, e la forza non viene temperata da obblighi morali.
L’ideologia trumpiana, più che destrutturare l’internazionalismo americano, lo ha riconfigurato
come nazionalismo strategico: un’impostazione in cui l’equilibrio mondiale non si basa su regole
condivise, ma su rapporti di forza negoziabili di volta in volta, dove la credibilità è affidata al dominio economico, militare e comunicativo.
La politica dei dazi, ad esempio, non è stata solo uno strumento di riequilibrio commerciale, ma un dispositivo politico per costringere i partner a sedersi al tavolo da posizioni svantaggiate. Allo stesso modo, la strategia verso la Cina ha visto l’uso combinato di sanzioni, narrative ostili e disaccoppiamento tecnologico come strumenti per contenere l’ascesa di Pechino, ridefinendo la logica della globalizzazione secondo un modello “selettivo”, dove gli scambi valgono solo se producono vantaggi asimmetrici per gli USA.
Il piano di pace proposto per l’Ucraina, improntato a concessioni territoriali piuttosto che alla difesa intransigente della sovranità, rappresenta la declinazione più evidente di questa visione: la stabilità viene barattata con la rinuncia a valori un tempo intoccabili. A Trump interessa porre fine al
conflitto per liberare risorse e pacificare il fronte europeo, ma non in nome del diritto internazionale, bensì per ricalibrare il focus strategico sul Pacifico e sulla sfida con la Cina, che
resta la vera ossessione geopolitica del suo secondo mandato.
Questo approccio implica una torsione profonda anche nei rapporti transatlantici. L’Europa, nel
disegno trumpiano, non è più un’alleata strategica, ma un soggetto economicamente competitivo
da contenere e politicamente da subordinare. Le pressioni sull’aumento delle spese per la difesa, le minacce tariffarie, il disinteresse per la coesione interna dell’UE rivelano una visione in cui la leadership americana si regge solo se gli altri sono indeboliti, divisi e dipendenti.
In definitiva, la politica estera americana sotto Trump non è una rinuncia al potere globale, ma una
mutazione del modo in cui quel potere si esercita: senza il peso dei valori universali, senza il vincolo delle alleanze storiche, senza la narrativa della democrazia come export. È una dottrina
imperiale riformulata per il XXI secolo, dove la forza è comunicazione, la pace è transazione, e l’egemonia è ridefinita come preminenza negoziale.
In questo contesto, ogni alleanza diventa condizionata, ogni negoziato è uno scambio a somma zero, e la coerenza morale è sacrificabile a favore del vantaggio immediato.
La Russia e la geopolitica del risentimento
Se l’America trumpiana si è rifugiata in un isolazionismo assertivo, la Russia di Vladimir Putin ha scelto l’esatto opposto: una proiezione muscolare del potere fondata sull’idea che la forza, e non il consenso, sia oggi la vera valuta internazionale. La politica estera del Cremlino è l’espressione di una visione del mondo anacronistica eppure funzionale: quella secondo cui i grandi imperi non scompaiono, ma si ritirano nell’ombra in attesa di riconquistare il centro del palco.
La dottrina russa contemporanea, avviata con l’intervento in Georgia nel 2008, confermata dalla guerra in Siria e perfezionata nel conflitto ucraino, non si limita a una reazione a minacce percepite.
È una strategia coerente, sistemica, che ha un orizzonte ben preciso: la restaurazione dell’influenza russa nello spazio post-sovietico e, più in generale, nel sistema multipolare in via di consolidamento.
Mosca agisce, ormai da anni, secondo tre direttrici operative:
- Difensivo-identitaria: la retorica del “mondo russo” (Russkiy Mir) serve a costruire una cornice ideologica che giustifica l’ingerenza in Stati vicini (Ucraina, Bielorussia, Moldavia) come “protezione dei connazionali” o “difesa dell’identità ortodossa”. In realtà, si tratta di una strumentalizzazione del sentimento nazionale per legittimare espansionismi militari e sovversione istituzionale.
- Disgregativa: la Russia lavora sistematicamente per minare la coesione interna dei blocchi occidentali, puntando sulle loro faglie. Sostiene i movimenti sovranisti in Europa, finanzia media alternativi e disinformazione, promuove narrazioni anti-NATO e anti-UE. Più che costruire un’alleanza propria, Mosca preferisce frammentare quelle esistenti.
- Neo-imperiale: sul piano operativo, il Cremlino mira a ripristinare la propria presenza militare ed economica nei teatri periferici, come i Balcani, il Sahel, il Medio Oriente, l’Artico e l’Indo-Pacifico. La logica è chiara: occupare lo spazio lasciato vacante dagli Stati Uniti e dall’Europa, approfittando delle crisi e delle indecisioni.
Ma la chiave interpretativa più profonda della strategia russa è un’altra: la geopolitica del risentimento. Putin non si limita a sfidare l’Occidente sul piano delle armi o delle alleanze: sfida il suo ordine simbolico. Il Cremlino si muove come potenza ferita, convinta di aver subito un’umiliazione storica con il crollo dell’URSS e la mancata “inclusione onorevole” nel sistema internazionale a guida americana.
Il risentimento diventa così la matrice ideologica che legittima l’uso della forza come vendetta e risarcimento, l’autoritarismo come risposta all’ “ipocrisia democratica” e il revisionismo territoriale come “giustizia storica”. In questo quadro, ogni cedimento dell’Occidente è interpretato non come segno di ragionevolezza, ma come debolezza sistemica. E ogni apertura viene manipolata come conferma di un destino ineluttabile: la Russia deve essere temuta, non amata.
Il soft power russo — già fragile — è stato sostituito da uno “sharp power” aggressivo: campagne di disinformazione, cyberattacchi mirati, uso politico delle risorse energetiche. Più che convincere, Mosca vuole intimidire. Più che attrarre, vuole influenzare. E questo è coerente con
l’idea di un mondo diviso in sfere d’influenza e non in alleanze valoriali.
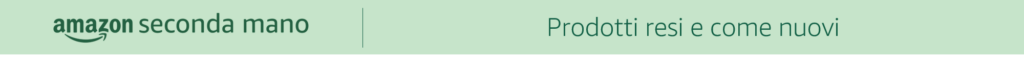
Tuttavia, questa strategia ha anche un costo crescente. La guerra in Ucraina, pur utile per consolidare il potere interno e riaffermare una centralità internazionale, ha generato un isolamento economico e diplomatico senza precedenti, spingendo la Russia in un’alleanza forzata con la Cina che rischia di comprometterne l’autonomia a lungo termine. Ma nel breve periodo, Putin scommette sulla fragilità dell’Occidente, sullo sfilacciamento dell’Unione Europea, sulla stanchezza strategica americana. Ed è proprio per questo che la reazione europea a questa sfida deve essere innanzitutto narrativa: opporre alla geopolitica del risentimento una geopolitica del progetto, capace di ricostruire un immaginario forte, coeso e credibile.
In un’epoca in cui la comunicazione ha lo stesso peso delle armi, la Russia ha capito che seminare sfiducia, divisione e paura può essere più efficace che vincere una battaglia. Ed è in questo terreno simbolico che si gioca oggi la vera sfida dell’Europa.
L’Europa davanti alla sfida dell’autonomia strategica
In questo quadro frammentato e competitivo, l’Unione Europea si trova davanti a un bivio storico.
Se fino a pochi anni fa poteva giocare sul proprio soft power, forte di una diplomazia multilaterale e della difesa delle regole internazionali, oggi non può più permettersi il lusso dell’ambiguità. Il deterioramento dell’ordine globale, tra l’isolazionismo statunitense e il revanscismo russo, impone all’Europa di ridefinire il proprio ruolo nel mondo: non come terzo polo passivo, ma come attore consapevole della propria missione politica e storica.
L’autonomia strategica, tanto evocata quanto elusa nei fatti, deve ora articolarsi in tre piani interconnessi: la sicurezza, l’indipendenza energetica e industriale, e soprattutto la costruzione di
una narrazione europea all’altezza delle sfide contemporanee. Sul fronte della difesa, la guerra in Ucraina ha reso evidente la vulnerabilità del continente in assenza di una capacità militare autonoma. La dipendenza dalla NATO – di fatto, dagli Stati Uniti – può rivelarsi un tallone d’Achille nel momento in cui Washington cambia approccio, come già accaduto sotto Trump.
Ma la sicurezza non si gioca solo con i carri armati: si gioca con i dati, le tecnologie, le catene del valore e la resilienza culturale. In questo senso, l’Europa ha bisogno di una politica industriale che sappia coniugare sovranità e transizione ecologica, e di un sistema informativo che contrasti la disinformazione e valorizzi un’identità pluralista, democratica, coesa.
La dimensione più urgente, però, è quella comunicativa. In un’epoca dominata dalla “geopolitica delle emozioni”, dove potenze rivali impongono il loro frame attraverso simboli, immagini e narrazioni forti, l’Unione Europea appare ancora priva di un racconto condiviso. I valori di pace, diritti umani e multilateralismo, da soli, non bastano più: vanno inseriti in un discorso politico e strategico che parli ai popoli prima ancora che ai governi. In mancanza di una visione coerente e affermativa, l’Europa rischia non solo l’irrilevanza geopolitica, ma anche quella simbolica.
È il momento di decidere se essere solo un arbitro tecnico dei conflitti altrui o un soggetto capace di produrre immaginario, influenza e progetto politico. In questo senso, l’autonomia strategica è anche – e forse soprattutto – una battaglia culturale: per un’Europa che non reagisce, ma propone; che non subisce le narrazioni dominanti, ma costruisce la propria.
La fine delle illusioni multilaterali e la polarizzazione delle grandi potenze richiedono all’Europa una risposta decisa. Non servono solo strutture comuni o piani industriali: serve una visione. Una narrazione solida, credibile e competitiva, capace di reggere l’urto di un mondo dove potere e immaginario camminano insieme.
L’autonomia strategica non è più una prospettiva: è una necessità storica.











