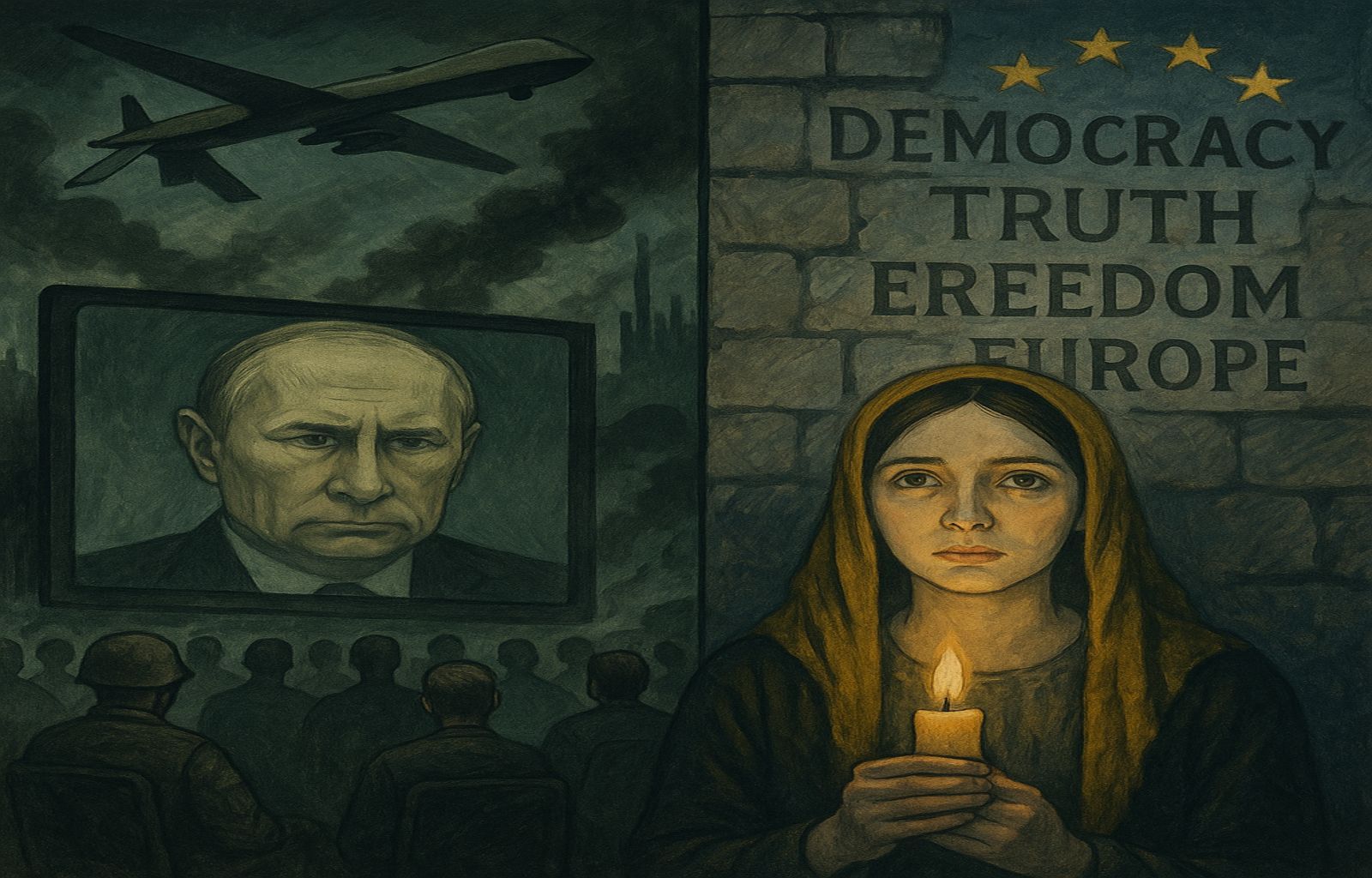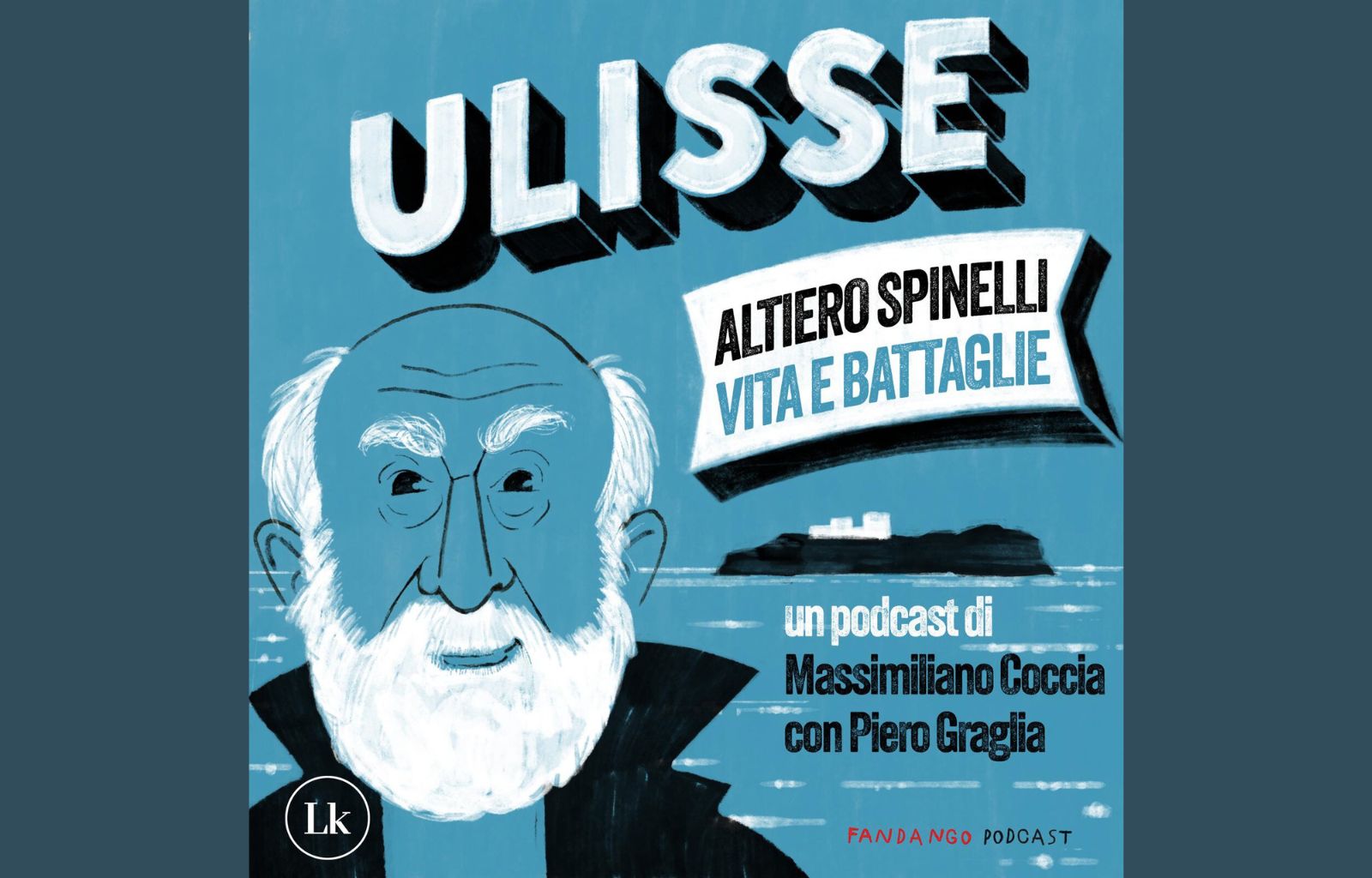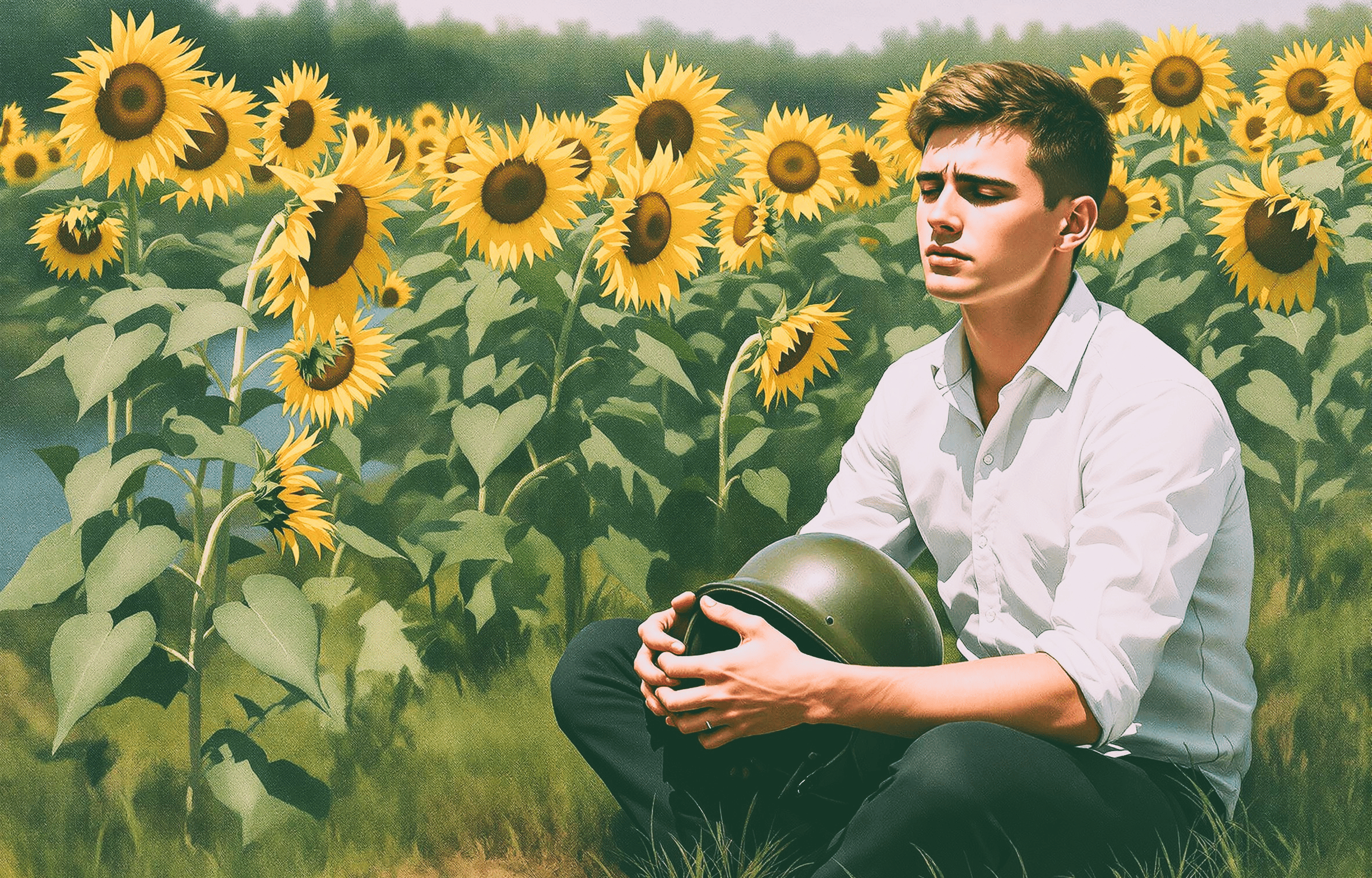L’Italia è di chi la ama: cittadinanza, identità e una destra che non c’è più

Nel 2010, ormai quindici anni fa, l’allora presidente della Camera Gianfranco Fini propose che i figli di immigrati potessero chiedere la cittadinanza al termine di un ciclo scolastico, senza dover aspettare il compimento dei diciotto anni (dai quali peraltro passa spesso qualche altro anno prima dell’effettivo riconoscimento della cittadinanza). “Alla fine di un ciclo scolastico – questo era il ragionamento di Fini – quei ragazzi che sono stabilmente in Italia, perché sono nati qui, sono cresciuti qui con la loro famiglia, hanno il diritto di diventare cittadini”. Non proponeva dunque uno ius soli automatico, ma una cittadinanza legata a elementi concreti di integrazione: l’istruzione, la famiglia, la permanenza stabile nel Paese. In quell’occasione, Fini pronunciò anche una frase che fece molto discutere: “L’Italia è di chi la ama, non solo di chi ha il sangue italiano”. È una frase che colpì allora il sottoscritto e che è rimasta impressa negli anni, anche perché non veniva da un leader progressista ma da chi aveva guidato Alleanza Nazionale, da un uomo cresciuto politicamente nella destra post-missina. Una destra che oggi, semplicemente, non esiste più.
Accanto a quella voce, nello stesso periodo storico, vi era quella di Mirko Tremaglia, altro storico esponente del Movimento Sociale e poi di Alleanza Nazionale, impegnato in una battaglia diversa ma altrettanto legata a una visione dell’identità nazionale: garantire agli italiani residenti all’estero il pieno esercizio del diritto di voto. Dopo la modifica dell’articolo 48 della Costituzione, fu grazie alla legge 459 del 2001, di cui Tremaglia fu promotore, che si concretizzò il voto per corrispondenza. La legge prevedeva che i cittadini italiani iscritti all’AIRE potessero eleggere i propri rappresentanti in Parlamento e votare per referendum direttamente dall’estero, tramite voto per corrispondenza o, su opzione, in Italia. Tremaglia non inventò un diritto nuovo, ma rese effettivo e esigibile quello già previsto dalla Costituzione, riconoscendo che l’identità nazionale poteva vivere anche fuori dai confini, nella lingua, nei ricordi, nei legami familiari e affettivi. È una scelta che può sembrare discutibile, e in certi casi lo è davvero: in linea puramente teorica, può votare anche chi è nato e cresciuto all’estero, non parla italiano e magari non saprebbe nemmeno indicare l’Italia su una cartina. Ma forse è proprio in quella scelta, criticabile certo, ma inclusiva, che si manifestava una visione più ampia e simbolica della cittadinanza, intesa come legame, nel senso più esteso del termine, a meno di intenderla tragicamente come “eredità di sangue” nei secoli dei secoli.
Un esempio concreto, forse ovvio ma efficace: Mario Balotelli. Nato a Palermo da genitori ghanesi, cresciuto a Brescia da una famiglia affidataria italiana, non fu mai adottato. Italiano in tutto – lingua, scuola, cultura, amici – non poté ottenere la cittadinanza prima della maggiore età. La ricevette il 13 agosto 2008, il giorno dopo il suo diciottesimo compleanno. Fino ad allora non poteva giocare con le nazionali giovanili, pur essendo uno dei talenti più brillanti della sua generazione. Rifiutò l’offerta del Ghana e aspettò. Scelse di rappresentare l’Italia, il Paese che sentiva suo. Appena cittadino, fu convocato nell’Under 21 e poi in Nazionale maggiore. Il 28 giugno 2012, con una doppietta alla Germania, portò l’Italia in finale agli Europei. Quel giorno, fu celebrato come simbolo della nazione. Nessuno chiese conto della sua cittadinanza precedente o delle sue origini.
Quel giorno, Balotelli era l’Italia.
Ma è inquietante che certi concetti trovino spazio solo se incarnati da figure eccezionali, celebri o milionarie. Che serva un campione per legittimare l’appartenenza di chi, ogni giorno, vive le stesse esperienze, senza riflettori, è una distorsione profonda. È un tema che meriterebbe uno spazio a parte, ma resta lì: latente, urgente.
Sono passati quindici anni dalle parole di Fini. Nel frattempo, la destra italiana ha smarrito ogni consapevolezza culturale di quel tipo. La questione della cittadinanza, pur essendo giuridica, si gioca innanzitutto sul piano culturale. Non stupisce che una proposta più aperta sia arrivata da Fini: quando la destra aveva una struttura culturale solida, non temeva la complessità o il confronto. Il diverso non era un nemico da rimuovere, ma un elemento con cui misurarsi. La crisi nasce quando l’identità si svuota di contenuti e si riduce a un riflesso del nemico. Se l’identità serve solo a dire “non siamo loro”, allora nessuna legge – né inclusiva né restrittiva – potrà risolvere davvero il problema.